di Franco Pezzini
“[…] Stia dunque a sentire quello che non sa. I tre fiumi dell’antico mondo dei morti, l’Acheronte, il Flegetonte e il Cocito, appartengono oggi all’inferno musulmano, ebraico e cristiano. Il loro corso segna i confini che separano i tre inferni: la Gehenna, l’Ade e l’inferno glaciale dei maomettani. Proprio laggiù, sotto le terre che un tempo appartennero ai Chazari, si incontrano i tre regni dei morti: l’infuocato regno di Satana, con i nove cerchi dell’Ade cristiano e con il trono di Lucifero e le bandiere dell’imperatore infernale; gli inferi dell’Islam dove regnano le gelide pene di Iblis; e infine la regione di Ghebhurah, alla sinistra del Tempio, la Gehenna dominata da Asmodeo, dove siedono gli spiriti ebraici del male, della lascivia e della fame. Questi tre inferni sono ben divisi, i loro confini sono segnati da un aratro di ferro e a nessuno sarà concesso di superarli. Capisco che è la sua mancanza d’esperienza a farle immaginare questi tre inferni in modo sbagliato. Nell’inferno ebraico, nel regno di Beliaal, l’angelo delle tenebre e del peccato, non bruciano come lei crede, gli ebrei. Laggiù bruciano solo gli arabi o i cristiani. Allo stesso modo nell’inferno cristiano non ci stanno i cristiani, bensì i maomettani o quelli del popolo di David, mentre nel regno musulmano delle sofferenze, dove Iblis è sovrano, si trovano solo cristiani ed ebrei, e neanche un turco o un arabo. S’immagini un po’ quel che significherebbe per Masudi, il quale teme il suo tremendo ma tuttavia ben conosciuto inferno, ritrovarsi nello Sheol ebraico o nell’Ade cristiano, dove ad accoglierlo ci sarò io! Invece che in Iblis, s’imbatterà in Lucifero. Sull’inferno in cui soffre un ebreo si leverà un cielo cristiano!”.
Così spiega il diavolo: almeno quello dell’inferno cristiano, almeno a quanto riporta lo scrittore serbo Milorad Pavić (1929-2009) in un libro strano e affascinante che deve parecchio a Borges. Si tratta del labirintico Dizionario dei Chazari. Romanzo Lessico (1987, in Italia 1988 per Garzanti) che intreccia a vicende del tutto inventate la raccolta di tre fantomatiche enciclopedie con riferimenti incrociati. Ciascuna nell’ottica di una delle tre religioni monoteiste: cristianesimo nel Libro Rosso (da cui la citazione, pp. 49-50, voce ‘Branković, Avram’), islam nel Libro Verde e giudaismo nel Libro Giallo – il tutto complicato dal fatto che il testo è proposto in due versioni, una “maschile” e una “femminile”, che differiscono solo in un paragrafo. Al centro, le vicende e i misteri dell’antico regno dei Chazari, tra Europa e Asia, convertitisi a fine VIII secolo o inizio del IX a una delle tre fedi (dopo un certo travaglio, quella d’Israele) ma in un rapporto di continuo travaso di suggestioni, pressioni e tentazioni culturali. 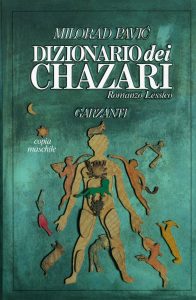 Parecchie considerazioni si potrebbero articolare, su questo romanzo in realtà venato di pesanti ambiguità: se la frase “Sull’inferno in cui soffre un ebreo si leverà un cielo cristiano!” già richiama a un contesto raggelante del passato europeo, nei Chazari – che a dispetto del numero finiscono con l’essere dominati da altri – Pavić sembra richiamare i Serbi. Ambiguità che del resto preludono tragicamente a quanto succederà di lì a pochi anni tra rivalse, miti nazionalisti e fantasie geopolitiche (più tanto pelo sullo stomaco dell’Occidente) nell’area dell’ex-Iugoslavia.
Parecchie considerazioni si potrebbero articolare, su questo romanzo in realtà venato di pesanti ambiguità: se la frase “Sull’inferno in cui soffre un ebreo si leverà un cielo cristiano!” già richiama a un contesto raggelante del passato europeo, nei Chazari – che a dispetto del numero finiscono con l’essere dominati da altri – Pavić sembra richiamare i Serbi. Ambiguità che del resto preludono tragicamente a quanto succederà di lì a pochi anni tra rivalse, miti nazionalisti e fantasie geopolitiche (più tanto pelo sullo stomaco dell’Occidente) nell’area dell’ex-Iugoslavia.
Ed è proprio con un occhio a questa dimensione equivoca che, nel riprendere il filo del nostro tema, preme richiamare la suggestione evocata dal diavolo: la terribilità straniante di trovarsi in un inferno dalle categorie non conosciute, o – per dirla in termini più generali – di confrontarsi con dimensioni di paura che non trovano comprensione nelle categorie culturali note. È in fondo il motivo per cui, venendo a una grana molto più pop, il remake The Ring (2002) reca – a chi scrive, ma ho trovato conferme tra altri spettatori – ben più inquietudine del modello originale giapponese Ringu (1998): e non solo perché di quest’ultimo non riesco a cogliere il sapore di scene chiave (i riti funebri in Giappone, per esempio, hanno caratteristiche molto diverse da quelle che a livello profondo riconosco), ma anche e soprattutto per un problema di coerenza simbolica. In Ringu la storia è coerente a un contesto di credenze in spiriti di vario tipo, si colloca in un certo alveo culturale; The Ring è invece completamente destrutturato, le categorie vanno in palla, i personaggi non riescono a reagire perché il meccanismo è “altro” e non corrisponde a tutto ciò che in Occidente si può sapere sui “fantasmi” (con tutte le virgolette del caso). È un po’ lo scarto che Le Fanu presenta tra i fantasmi delle storie di Padre Purcell – tradizionali, spaventosi ma coerenti a un contesto folklorico – e quelli di In a Glass Darkly, dove i protagonisti colti e scettici non riescono più a gestirli per un deficit di categorie congrue.
Questa dell’alienità è idealmente una delle maschere della paura: il terrore di trovarci in una realtà che non riconosciamo nostra, neanche nel tipo di sofferenze. Ma che presenta un rovescio paradossale in un’altra e opposta forma di paura: quella di scoprirci meticci da sempre, di vedere relativizzate – e minate nelle fondamenta – una serie di categorie identificative del nostro consolidato e compiaciuto storytelling. Di scoprire ibridate le nostre tanto amate “radici”, e non così uniche le nostre specificità.
E proprio il nostro tema pare una buona metafora di tutto questo, per la curiosa, imbarazzante somiglianza delle storie notturne tra culture diversissime: qualcosa che non si esaurisce nelle componenti psichiche e neurologiche comuni ai Sapiens e ai loro fratelli più “primitivi” (sleep paralysis eccetera), o in analogie nei meccanismi culturali. Un magma perturbante che va ben oltre i contenuti specifici del quadro The Nightmare.
 Ricapitoliamo: si è visto come a monte di film fantastici popolari degli anni Trenta emerga il successo del saggio sull’incubo di Ernest Jones; poi, con un passo indietro, come un influsso persino più diffuso (anche su Jones) sia recato da un’opera preromantica sul tema, il dipinto seminale di Füssli. Un ulteriore passo indietro ha portato ad allargare ancora la mappatura dell’area interessata e degli influssi artistici e culturali in riferimento a tradizioni e opere dal mondo latino in avanti. A giustificare non solo la genesi ma il successo del dipinto di Füssli è insomma tutto un intreccio di radici: qualcosa che conosce un’accelerazione in un momento di svolta inquieta della cultura europea, un passo prima della bufera rivoluzionaria. Un addensarsi di nubi tra sogni e incubi della ragione come nella famosa tavola di Goya di poco successiva col suo volo di nottole spettrali (El sueño de la razón produce monstruos, 1797/1799, sorta di controcanto al dipinto füssliano) o in altri dei suoi Los caprichos.
Ricapitoliamo: si è visto come a monte di film fantastici popolari degli anni Trenta emerga il successo del saggio sull’incubo di Ernest Jones; poi, con un passo indietro, come un influsso persino più diffuso (anche su Jones) sia recato da un’opera preromantica sul tema, il dipinto seminale di Füssli. Un ulteriore passo indietro ha portato ad allargare ancora la mappatura dell’area interessata e degli influssi artistici e culturali in riferimento a tradizioni e opere dal mondo latino in avanti. A giustificare non solo la genesi ma il successo del dipinto di Füssli è insomma tutto un intreccio di radici: qualcosa che conosce un’accelerazione in un momento di svolta inquieta della cultura europea, un passo prima della bufera rivoluzionaria. Un addensarsi di nubi tra sogni e incubi della ragione come nella famosa tavola di Goya di poco successiva col suo volo di nottole spettrali (El sueño de la razón produce monstruos, 1797/1799, sorta di controcanto al dipinto füssliano) o in altri dei suoi Los caprichos.
Eppure il discorso così impostato coglie ancora soltanto la cima dell’iceberg. E dobbiamo ora azzardare un ulteriore passo indietro, verso un passato assai più remoto.
Si è citato l’incubo a monte del primo romanzo gotico, nella forma del gigante onirico di Walpole; e una sorta di gigante sarà l’incubus/Creatura di Frankenstein. Ma in realtà il nesso tra incubi e giganti è saldato ufficialmente dal ricordo del nome con cui i Greci (Galeno compreso) etichettavano il fenomeno: Efialte, termine che sembra rimontare a un antroponimo miceneo e-pi-jata, e già nel mondo antico interpretato come un composto epi + allomai, “saltare su qualcuno”, ma che per altri si raccorderebbe a epialos/ēpialos, “febbre con brividi” (in riferimento al delirio?), oppure a iallō, “inviare, lanciare” nella forma composta di “getto su, in, verso”. Efialte è il nome di ben due figure di Giganti del mito greco, entrambi ribelli contro l’Olimpo: il primo figlio di Poseidone e di Ifimedia, e uno dei cosiddetti Aloadi; il secondo un figlio di Gea coinvolto nella Gigantomachia. Entrambi associati a un saltare o lanciare sopra: gli Aloadi sovrappongono il monte Ossa al monte Pelio (o viceversa), per raggiungere l’altezza dell’Olimpo; i giganti ribelli della Gigantomachia tentano di arrivare al cielo (saltare sopra) e finiscono sepolti negli Inferi (il peso della terra lanciato su di loro).  Anche alla luce di certe associazioni mediterranee tra demoni e ombre degli antichi giganti – per esempio nel mondo ebraico degli apocrifi – il nesso tra queste entità ribelli del mito greco (ma in realtà precedenti a esso) e l’omonimo demone incubo non sembra esaurirsi in una semplice omonimia. Quanto al fatto che l’incubus/Alp del dipinto di Füssli non abbia tanto le caratteristiche del gigante quanto del nanerottolo, non esiste in realtà una vera contrapposizione: l’essere che schiaccia e incombe, il gioco del grottesco che veicola, il contesto onirico rimandano – come ben mostra Lewis Carroll coi cambi di dimensioni di Alice – a un unico orizzonte di spiazzamento.
Anche alla luce di certe associazioni mediterranee tra demoni e ombre degli antichi giganti – per esempio nel mondo ebraico degli apocrifi – il nesso tra queste entità ribelli del mito greco (ma in realtà precedenti a esso) e l’omonimo demone incubo non sembra esaurirsi in una semplice omonimia. Quanto al fatto che l’incubus/Alp del dipinto di Füssli non abbia tanto le caratteristiche del gigante quanto del nanerottolo, non esiste in realtà una vera contrapposizione: l’essere che schiaccia e incombe, il gioco del grottesco che veicola, il contesto onirico rimandano – come ben mostra Lewis Carroll coi cambi di dimensioni di Alice – a un unico orizzonte di spiazzamento.
Ma se Efialte è per l’antico mondo greco la maschera mitica dell’incubo inteso come demone maschile, non manca e anzi trova spazio persino eminente la sua controparte femminile, il succubo Empusa: una figura di protovampira della schiera della dea infera Ecate (nel cui profilo trascolora), dall’etimologia dubbia e forse pregreca, risolta talora come “colei che preme/comprime” (da empiezō), ancora una volta nel senso del gravare sul petto. Se altre orchesse della stessa schiera infera insidiano i bambini (e infatti sono spesso ricordate col diminutivo “d’allarme” del linguaggio infantile: Mormó/“lo Spauracchio”, Accó/“Colei che ghigna/fa smorfie”, Maccó/“la Stupida”, Alfitó/“l’Infarinata”, Carcó/“la Mordace?”, Gelló, Lamó cioè Lamia), Empusa minaccia la “seconda nascita”, quella sessuale dei giovani adulti. Entità metamorfica e plurale – come peraltro Lamia e le Lamie, con cui verrà confusa – l’Empusa in forma di procace fanciulla rimorchia sulle strade di notte o nel pericoloso meriggio i viaggiatori che intende divorare o drenare a morte. Senza entrare qui nei dettagli, è evidente che si tratta di un profilo molto simile a quello di un’altra entità stavolta del folklore mediorientale, quella già citata Lilith le cui prime tracce emergono in Mesopotamia e che estorcerebbe sesso al maschio standogli sopra: un’immagine che salda l’idea del sovrastare comprimendo con un più variegato orizzonte di suggestioni sulla temuta supremazia femminile e la minaccia alla virilità.
 Beninteso, si tratta solo di due facce tra le tante repertoriate da imbarazzati mitologi: orchesse e predatrici del respiro-vita – dal sembiante di volatile o di sfinge o di qualunque altra bestia o ibrido (cfr. Hecate Britannica) – che al di là di specializzazioni locali muovono sullo stesso fronte arcaicissimo. Per poi riemergere a infestare la modernità: e non è un caso se tra fine Ottocento e inizio Novecento, archiviate le luminose e numinose signore preraffaellite, l’arte simbolista sprofondi la donna nel torbido moltiplicando immagini dell’incubo anche e soprattutto in chiave femminile. È del 1896 l’Empusa di Carl Schmidt-Helmbrechts (1872-1936) ritta – bontà sua, senza vittime – tra ragni e serpenti; ma nel 1899, Ernst Stöhr (1860-1917) illustra una propria lirica Vampir sulla rivista Ver Sacrum mostrando una vampira che incombe come un incubo su un uomo riverso. Al 1910 circa risale L’incubo di E. Turbacky, dove una figura femminile nuda accucciata su un dormiente – di lei non vediamo il viso, nascosto dai capelli quasi a prefigurare Ringu – punta le mani sugli occhi della vittima, impedendo di aprirli. Poco prima l’artista tedesco Fritz Schwimbeck (1889-1972) aveva offerto nel quadro Il sogno (1909) la visione raggelata di un incubus – una carcassa con zampe ramificate accucciata su un dormiente – e nel Sogno di Semiramide (1909) la regina similmente oppressa da un toro alato Lamassu: ma pochi anni dopo dipinge Il mio sogno, il mio incubo (1915) con il dormiente compresso da una donna-uccello che chiaramente rimanda alla nebulosa arcaica, tra Mesopotamia ed Egeo.
Beninteso, si tratta solo di due facce tra le tante repertoriate da imbarazzati mitologi: orchesse e predatrici del respiro-vita – dal sembiante di volatile o di sfinge o di qualunque altra bestia o ibrido (cfr. Hecate Britannica) – che al di là di specializzazioni locali muovono sullo stesso fronte arcaicissimo. Per poi riemergere a infestare la modernità: e non è un caso se tra fine Ottocento e inizio Novecento, archiviate le luminose e numinose signore preraffaellite, l’arte simbolista sprofondi la donna nel torbido moltiplicando immagini dell’incubo anche e soprattutto in chiave femminile. È del 1896 l’Empusa di Carl Schmidt-Helmbrechts (1872-1936) ritta – bontà sua, senza vittime – tra ragni e serpenti; ma nel 1899, Ernst Stöhr (1860-1917) illustra una propria lirica Vampir sulla rivista Ver Sacrum mostrando una vampira che incombe come un incubo su un uomo riverso. Al 1910 circa risale L’incubo di E. Turbacky, dove una figura femminile nuda accucciata su un dormiente – di lei non vediamo il viso, nascosto dai capelli quasi a prefigurare Ringu – punta le mani sugli occhi della vittima, impedendo di aprirli. Poco prima l’artista tedesco Fritz Schwimbeck (1889-1972) aveva offerto nel quadro Il sogno (1909) la visione raggelata di un incubus – una carcassa con zampe ramificate accucciata su un dormiente – e nel Sogno di Semiramide (1909) la regina similmente oppressa da un toro alato Lamassu: ma pochi anni dopo dipinge Il mio sogno, il mio incubo (1915) con il dormiente compresso da una donna-uccello che chiaramente rimanda alla nebulosa arcaica, tra Mesopotamia ed Egeo.  Più o meno in contemporanea, il pittore e scultore polacco Bolesław Biegas (1877-1954) vara un’intera galleria di straordinaria potenza visionaria – Les Vampires de guerre, quaranta dipinti 1915-18 – dove gli orrori del conflitto mondiale sono resi come l’incombere su uomini riversi di demoni femmina in genere alati, molto simili alle antiche protovampire con funzioni d’incubo… Se a queste raffigurazioni pittoriche aggiungiamo tutte quelle presenti nella narrativa o in altre forme artistiche (per esempio nel Nosferatu del 1922 Empusa è il nome sostitutivo dello stokeriano Demeter per la nave maledetta che porta il vampiro a spargere contagio e morte), e tanto più se consideriamo anche i richiami in chiave di metafora, ci accorgiamo non solo – e non è una novità – del peso di un certo immaginario sul Femminile allarmante, ma che sul piano tipologico il tema dell’incubo conosce con l’avvio inquieto del Novecento una nuova stagione di successi.
Più o meno in contemporanea, il pittore e scultore polacco Bolesław Biegas (1877-1954) vara un’intera galleria di straordinaria potenza visionaria – Les Vampires de guerre, quaranta dipinti 1915-18 – dove gli orrori del conflitto mondiale sono resi come l’incombere su uomini riversi di demoni femmina in genere alati, molto simili alle antiche protovampire con funzioni d’incubo… Se a queste raffigurazioni pittoriche aggiungiamo tutte quelle presenti nella narrativa o in altre forme artistiche (per esempio nel Nosferatu del 1922 Empusa è il nome sostitutivo dello stokeriano Demeter per la nave maledetta che porta il vampiro a spargere contagio e morte), e tanto più se consideriamo anche i richiami in chiave di metafora, ci accorgiamo non solo – e non è una novità – del peso di un certo immaginario sul Femminile allarmante, ma che sul piano tipologico il tema dell’incubo conosce con l’avvio inquieto del Novecento una nuova stagione di successi.
Ma a colpire persino di più è un altro elemento: e cioè la ricorsività lungo i millenni dei nomi di queste entità, nell’ambito di un evidente meticciato. Che il nome di una mattatrice dell’immaginario tra Otto e Novecento come Lilith rimandi all’antica Mesopotamia – e forse più indietro, ma solo da allora ci giungono testimonianze – è un fatto noto: di lì ne troviamo parecchie varianti in Medio Oriente e poi in Europa tramite le comunità ebraiche. Ma per una sua collega, il demone ammazzabambini Gelló, esistono ipotesi etimologiche dal greco (geleĩn, “esplodere di una risata agghiacciante”), in generale dall’indoeuropeo (*gel, “inghiottire”) però anche dal Gallû o Galu sumero-accadico; la ritroviamo in età bizantina (Gylo o Gyllou), nella demonologia ebraica (Gilu, nome segreto di Lilith) e in quella araba come ghoul, nota al fantastico fino a Lovecraft. Per l’orchessa Lamia – “libica” o almeno collocata su set non greci – principale imputata nel mito classico di ratto di bimbi e pedofagia, s’individuano radici mesopotamiche (Lamma sumerica, Lamassu accadica e assira, la diavolessa accadica Lamaštu), transiti nel punico (laham come “mangiare”, “divorare”) e nel greco (lamuros, “vorace/impudente” e laimos, “gola”) e parentela con Lamo, l’Orco per antonomasia, fondatore di Telépilo, città dei Lestrigoni antropofagi dell’Odissea. L’elenco potrebbe continuare, a mostrare l’esistenza di un tessuto condiviso di credenze al di là di distanze geografiche e politiche di territori. Un insieme di travasi continui a partire da un passato remotissimo con forti connessioni. Dove l’interesse dell’esempio sta proprio nella sua apparente marginalità.
Nel suo discutibile ma insieme fondamentale Black Athena (tre voll. 1987, 1991, 2006), Martin Bernal mostra come il mondo greco non rappresenti il miracolo autonomo che una certa lettura nazionalista moderna ha voluto vedere, bensì il frutto – originale, ma in fecondissimo scambio – di una quantità di influenze sui popoli balcanici e delle isole dalle grandi civiltà dell’Africa e dell’Asia, come del resto sostenevano già gli storici antichi. Ma questo intreccio di imprestiti e relazioni corre fin dai tempi che rozzamente ci ostiniamo a considerare pre-istoria, dimenticando che già allora esisteva una storia di uomini tessuta di eventi e di idee. Un meticciato da tempi arcaicissimi, una comunità che nelle stesse paure – anche e in particolare quelle della notte, associate ai grandi misteri a partire dalla morte – vede una koiné, una cultura condivisa. Accanto a Black Athena potremmo individuare un filone di studi Black Empusa.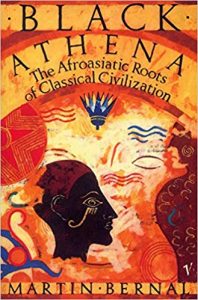
Con una koiné degli incubi che almeno dal neolitico continua ad avvicinare popoli lontani: perché è un fatto che figure analoghe a incubi e succubi fluiranno in tutte le culture. In Europa, a parte le tipologie citate, il folklore ne conosce innumerevoli altre: andiamo dalla ricca demonologia sarda dove l’incubus principale è l’ammuntadòre (ammuntare, “avere incubi”) – ma altre figure possono avvicinarsi, come le surbiles, le cogas, la busha, la surtora, la stria, la giana… – alle credenze ungheresi sul lidérc e l’éjjeljáró (“quello che va di notte”), a quelle estoni sul painaja (“schiacciatore”) e il külmking (“scarpafredda”). Per entità affini all’incubus l’Asia conosce per esempio il karabasan (“minaccioso schiacciatore”) turco, il bakhtak persiano, il pori dell’Assam, il pee ahm thailandese; alla famiglia dei succubi possono richiamarsi l’arabo qarînah – plausibilmente derivato da tempi preislamici – e le indiane yakshini. In Africa troviamo, tra mille altri, il popo bawa di Zanzibar e il tokolosh sudafricano; e in America meridionale il trauco cileno, il tintín ecuadoriano, per non parlare del Brasile, dove si attribuisce al delfino del Rio delle Amazzoni una natura di incubo sciupafemmine.
In un’epoca come la nostra, piena di angosce (la grande invasione, l’estinzione dei figli d’Occidente, la fine di culture strutture identità, l’ossessione delle radici…), ragionare sul rapporto tra alterità culturale e paura sembra fondamentale: tenendo presenti le due facce ideali, astratte del tema – il terrore dell’alienità da un lato, e dall’altro l’allarmante novella che siamo meticci da sempre. In questo senso, il tema dell’incubo diventa anche metafora di una soffocante dimensione “notturna” della paura: “notturna” nel senso di non razionale, coltivata dai grandi media come negli scambi al bar. E diventa occasione e macchina per pensare alle dinamiche sessiste (maschio su femmina, femmina su maschio, mancata accettazione del rifiuto e violenza conseguente…) e razziste con cui possiamo interpretare la realtà; alle ansie in un mondo che scricchiola come al tempo di Füssli, tra crolli di paradigmi e rivoluzioni epocali; alla continua proiezione di tali ombre e maschere nell’odierno immaginario – compreso quello del fantastico moderno, lingua franca e lente efficace per mettere la realtà a un giusto fuoco, cogliendo ciò che altrimenti ci sarebbe precluso. A farci ricordare che un punto comune del nostro essere umani potremmo ritrovarlo persino nelle nostre paure.




