di Sandro Moiso
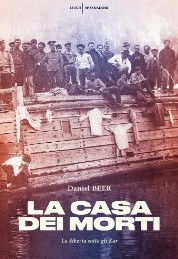 Daniel Beer, LA CASA DEI MORTI. La Siberia sotto gli zar, Mondadori editore, 2017, pp. 460, € 30,00
Daniel Beer, LA CASA DEI MORTI. La Siberia sotto gli zar, Mondadori editore, 2017, pp. 460, € 30,00
Le cifre sembrano incredibili, ma il territorio siberiano copre un’area di 14 milioni di km. quadrati, con una densità di 2 abitanti al kmq. La sola taiga copre 5 milioni di kmq, un’estensione prossima a quella del continente indiano, e possiede una ricchezza forestale maggiore di quella dell’Amazzonia, mentre è attraversata da 53mila fiumi. Una parte consistente del suo territorio è poi caratterizzato dal permafrost, un ghiaccio perenne che si estende in profondità nel terreno e che durante il disgelo e nella stagione estiva tende a sciogliersi soltanto in superficie, dando vita ad immensi acquitrini.
Nella lingua mongola, “Siberia” significa “terra che dorme” anche se costituisce circa i due terzi della Russia attuale e nell’estremo oriente del suo territorio si raggiungono le temperature più basse registrabili sull’intero pianeta, ad esclusione delle regioni artiche. Si estende dai monti Urali fino alle rive dell’Oceano Pacifico e dalle catene dei monti Altaj fino alle rive del mare Artico ed è straordinariamente ricca di minerali, contenenti quasi tutti i metalli preziosi e comprende alcuni dei più grandi giacimenti di nichel, oro, piombo, carbone, molibdeno, diamanti, argento, zinco oltre ad alcuni dei più importanti giacimenti mondiali di petrolio e gas naturali.
Questi i dati odierni, mentre il testo di Daniel Beer, pubblicato da Mondadori, descrive la storia della sua progressiva conquista nel corso dei secoli e del suo sfruttamento da parte dell’impero zarista. Una storia che per molti versi sembra ripetere o, meglio, anticipare l’espansione statunitense verso Ovest tra la fine del Settecento e la seconda metà dell’Ottocento. Compresa la sottomissione forzata delle tribù preesistenti, appartenenti quasi sempre allo stesso ceppo originario delle popolazioni amerindie. Soltanto specularmente rovesciata verso oriente e su un territorio ancora più vasto.
Svoltasi sostanzialmente tra la fine del XVI secolo e il XVIII, l’espansione nell’oriente siberiano fu inizialmente trainata, ancora una volta come nel caso del West americano, sia dalla necessità di ampliamento territoriale che dall’abbondanza di animali dalla pelliccia pregiata: volpi, scoiattoli, ermellini, martore e, soprattutto, zibellini.
“Le pellicce che i promyšlennikki (commercianti privati di pellame – NdR) riportavano dalla Siberia, spuntavano prezzi astronomici in Russia e altrove. Bastava una sola pelliccia di volpe artica per acquistare una fattoria di buone dimensioni,completa di cavalli, bovini, pecore e pollame.
Nella loro avanzata verso est, i russi usarono un insieme di incentivi e violenza per esigere tributi dalle popolazioni indigene della Siberia. Chi collaborava con i promyšlennikki poteva contare su denaro e protezione, mentre chi non lo faceva, oppure era sospettato di nascondere la propria ricchezza, pagava un prezzo terribile: torture, prese di ostaggi e omicidi erano all’ordine del giorno, e interi villaggi vennero distrutti. Alcune tribù, come gli ostiachi, già abituati a pagare tributi ai precedenti governatori mongoli, cercarono un accordo con i russi che avanzavano, restando sconvolti dall’avidità dei nuovi padroni. Altri, come i buriati, opposero fin dall’inizio resistenza all’invasione. Le tribù della Siberia, tuttavia, anche quando si dimostrarono capaci di unirsi in una difesa coordinata delle loro terre, riuscirono a presentare solo una resistenza sporadica. Nessuna era in grado di opporsi alla potenza di fuoco delle forze russe, e decine di migliaia di loro morirono per le malattie portate dagli invasori.”1
L’attrattiva esercitata da quelle terre rimaneva però limitata, ad esempio rispetto a quelli dell’Ovest americano, a causa del clima e delle difficoltà oggettive opposte dal territorio ad un’autentica espansione di carattere agricolo. All’inizio del XIX secolo, infatti, la popolazione siberiana ammontava a non più di un milione di abitanti, quasi tutti concentrati nella Siberia occidentale e in città che spesso non superavano le dimensioni di un grande villaggio. Problema che per certi versi permane ancora oggi, considerato che il territorio siberiano è attualmente abitato da un quarto della popolazione russa complessiva.
Era stata forse questa difficoltà ad aprire le porte di quello che sarebbe successivamente diventato il cuore di tenebra dell’impero per gli stessi russi “bianchi”. Un’autentica prigione a cielo aperto, grazie all’istituzione dell’istituto dell’esilio.
“L’esilio era un atto di espulsione. Ioann Maksimovič, vescovo di Tobol’sk e della Siberia, dichiarò nel 1708: «Così come dobbiamo eliminare dal corpo gli agenti nocivi, in modo che il corpo non muoia, lo stesso deve avvenire nella comunità dei cittadini: tutto ciò che è sano e innocuo si può tollerare, ma ciò che è dannoso va tagliato via». Gli ideologi dell’impero tornarono più volte sull’immagine della Siberia come di un mondo oltre le frontiere immaginarie dello Stato nel quale il sovrano poteva eliminare le impurità per proteggere la salute del corpo pubblico e sociale. Con il passare del tempo, le metafore cambiarono, ma rimase la convinzione di fondo che la Siberia fosse il ricettacolo d’ogni male che affliggeva l’impero”.2
Inizialmente usato per malfattori, assassini e prostitute ben presto l’istituto dell’esilio fu applicato ai contadini rivoltosi, ai nobili attratti dal pensiero democratico dell’Illuminismo e, successivamente e spesso soltanto come alternativa alla pena di morte, per i congiurati decabristi, i ribelli e i rivoluzionari polacchi, gli esponenti dei movimenti populisti e terroristi anti-zaristi, gli anarchici e gli esponenti del socialismo o, meglio della nascente socialdemocrazia russa.
Nobili, contadini, operai, studenti, malavitosi, soldati (russi e stranieri prigionieri), prostitute, rivoluzionari, terroristi, uomini e donne, russi, polacchi ed esponenti delle varie nazionalità oppresse dall’impero iniziarono ad affollare una terra desolata, dalle distanze incommensurabili, in piccoli villaggi, sperdute cittadine, campi di lavoro o fattorie isolate. Da cui era difficile fuggire non tanto per la solerzia dei funzionari o delle guardie, spesso facili da corrompere o dallo scarso ossequio nei confronti del dovere e delle norme, ma proprio a causa delle distanze, del freddo, della diffidenza degli altri abitanti.
Un autentico inferno bianco di cui Beer, professore associato di Storia presso la Royal Holloway dell’Università di Londra, traccia le drammatiche vicende, delineando ritratti, vite, disavventure di un foltissimo stuolo di personaggi. Tracciando però anche un percorso cronologico lungo il quale si delinea una sorta di continuità ideale tra le storie e gli ideali dei deportati, democratici, ribelli, populisti e rivoluzionari socialisti che mostra come la continuità di scelte e di pensiero che caratterizzò l’azione sia dei riformatori democratici che dei rivoluzionari russi avesse nell’esilio siberiano le sue radici “storiche”.
Per ognuno di quegli esiliati le premesse potevano essere infatti diverse per tempo, classe sociale di appartenenza, lingua, nazionalità, credo politico o religioso, ma tutto finiva nel confluire in una pentola, in costante ebollizione, di odio e disprezzo nei confronti dello zarismo e delle sue istituzioni. Così, nonostante le morti, le rese o i pentimenti necessari alla sopravvivenza, la Siberia divenne davvero il luogo, oltre le frontiere immaginarie dell’impero, dove si andò formando la negazione politica e ideologica del corpo sociale edificato dagli czar e la reale coscienza della necessità del suo superamento.
Tutti i rivoluzionari russi, o almeno quelli sopravvissuti alle forche, passarono da lì. Tutti lasciarono un segno, una traccia. Fosse anche soltanto la guardia uccisa per poter fuggire o quelle intimorite dagli attentati in difesa delle condizioni di vita dei prigionieri, messi in atto soprattutto dopo la repressione dei moti rivoluzionari del 1905.3 Tutti impararono qualcosa ed ebbero modo di riflettere. Tutti insegnarono qualcosa ai nuovi venuti. Se non a parole, almeno con l’azione o il comportamento individuale.
La trasmissione della memoria storica e politica, imprescindibile per qualsiasi movimento rivoluzionario, si era fatta concreta. Si potrebbe dire che facesse parte dell’esperienza dell’esilio e dei lavori forzati. Le idee si erano trasmutate in carne e sangue dei deportati e le loro stesse vite finirono col diventare snodi di una rete infinita di comunicazione delle esperienze, concrete ed ideali allo stesso tempo.
Sarà per questo, forse, che l’istituzione successiva dei gulag, soprattutto a partire dal periodo staliniano, fu caratterizzata da quella che venne definita come “ingegneria delle anime”,4 cioè dall’azione costante e determinata tesa ad estirpare nell’esiliato/detenuto qualsiasi velleità critica o di costruzione di un consenso altro da quello stabilito dal regime. Il prigioniero doveva infatti perdere qualsiasi caratteristica individuale, qualunque capacità di pensiero autonomo, per concentrarsi esclusivamente sulla propria sopravvivenza e sulla propria colpa, così come dimostrano opere letterarie straordinarie come i Racconti della Kolyma di Varlan Salamov oppure Una giornata di Ivan Denisovič di Aleksandr Solženicyn o, ancora, molti romanzi di Victor Serge.
Così, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, proprio per gli ideali di liberazione individuale e collettiva più alti che collegano, per linee apparentemente invisibili, gli esiliati della scuola di rivoluzione siberiana alle vittime della Siberia della controrivoluzione stalinista e successiva (basti dire che la Prigione centrale per i lavori forzati di Tobol’sk, costruita a metà Ottocento, è rimasta attiva come istituzione penale fino al 1989), la letteratura rimane uno strumento validissimo e indispensabile per ricostruire e comprendere l’immaginario politico e i fenomeni sociali di ogni società, passata o presente che sia. Come restano a dimostrare anche capolavori quali Memorie dalla casa dei morti di Fëdor Dostoevskij (cui si ispira il titolo del testo di Beer), Resurrezione di Lev Tolstoj o, ancora, la cronaca del viaggio in Siberia di Anton Čechov: L’isola di Sachalin.
Opere di cui l’autore inglese ha sicuramente tenuto conto nella stesura di un testo importante e leggibilissimo allo stesso tempo.
D.Beer, LA CASA DEI MORTI. La Siberia sotto gli zar, pp.22-23 ↩
Beer, pag. 25 ↩
A tal proposito si veda: Jurij Trifonov, I riflessi del rogo. Vita e morte di un rivoluzionario sovietico, Mursia 1981 ↩
Si vedano in proposito, tra le tante opere sull’argomento: Frank Westerman, Ingegneri di anime, Feltrinelli 2006 e Oleg V.Chlevnjuk, Storia del Gulag. Dalla collettivizzazione al Grande terrore, Einaudi 2006 ↩



