di Armando Lancellotti
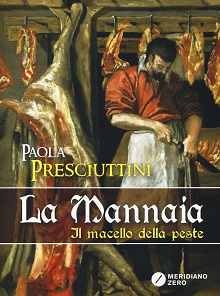 Paola Presciuttini, La Mannaia. Il macello della peste, Meridiano Zero, Bologna, 2017, pp. 303, € 18.00
Paola Presciuttini, La Mannaia. Il macello della peste, Meridiano Zero, Bologna, 2017, pp. 303, € 18.00
La Mannaia, l’ultimo romanzo della fiorentina Paola Presciuttini, è un grande affresco medievale, ricco di personaggi, dettagliato nei particolari, vivace e forte per colori e tonalità. Cornice e al tempo stesso contenuto della rappresentazione è la Firenze del Trecento, una città in cui l’economia organizzata attorno alle Corporazioni delle Arti e dei Mestieri va strutturandosi ed articolandosi in modo sempre più maturo e complesso nel corso del secolo e in cui i rapporti di produzione si definiscono e si specificano. Garzoni, apprendisti ed operai dipendono dai Maestri dell’arte, ovvero i padroni delle botteghe, delle materie prime e dei mezzi di produzione, i soli che possono accedere al Consiglio della corporazione, divenendone consoli e forse priori, per governare così la città, come vogliono quegli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella che da fine Duecento avevano supportato l’ascesa politica della borghesia cittadina, del popolo grasso, a scapito dei magnati. È la Firenze delle aspre lotte tra guelfi e ghibellini, prima e tra Bianchi e Neri, poi, di Corso Donati e della sua disfatta a San Salvi; ma è anche la Firenze della grandi banche dei Bardi e dei Peruzzi, dei loro investimenti avventati e della loro fragorosa rovina ed infine è la Firenze di quel Michele di Lando che a capo dei Ciompi tenta invano di sovvertire il sistema oligarchico al potere per dare voce alle ragioni dei salariati delle botteghe, dei più poveri, degli ultimi.
In mezzo a tutto questo – prima attrice assoluta della storia del secolo XIV e baricentro dell’intreccio narrativo del romanzo – la peste nera del 1348, che sconvolse non solo Firenze e l’Italia, ma tutta l’Europa, decimandone la popolazione in una ecatombe senza precedenti.
Sono una realtà dura ed una società violenta quelle dove l’autrice colloca i suoi personaggi e in cui i poveri tribolano e faticano a sopravvivere, mentre l’emergente borghesia cittadina sgomita senza troppe remore morali per competere e per emergere attraverso il successo negli affari. In ogni caso è una società faziosa e propensa allo scontro e alla violenza, tanto pubblica e politica, quanto privata. È un mondo in cui ai figli si assegnano nomi di animali, come Orso, Lupo, Falco – i tre figli di Torello del Verro, maestro beccaio e poi priore della propria Arte, non una delle sette maggiori, ma la prima delle minori – forse perché ferini sono per lo più i rapporti umani e sociali, soprattutto quelli maschili. E così Torello, rimasto precocemente vedovo della prima moglie Berta, scambia il primogenito Orso con un carretto, un cavallo e l’ingresso nella corporazione, a lui corrisposti, perché privo di figli maschi, da Mastro Pecora, influente e scaltro membro dell’Arte dei beccai, presso la bottega del quale, al Mercato Vecchio, Torello aveva appreso il mestiere di macellaio.
Professione questa scelta quasi per vocazione, avvertita quando, ancora bambino, Torello aveva per caso assistito alla macellazione di una grande vacca chianina dallo sguardo docile e mansueto, che con una dignità ignota agli uomini aveva affrontato davanti ai suoi occhi la morte.
Per rappresentare tonalità e timbri di un mondo così aspro e duro, l’autrice ricorre ad immagini, lessico ed aggettivazione fortemente sensoriali, in cui prevalgono il rosso cupo ed intenso del sangue, grondante dai coltelli affilati dei macellai ed il suo odore pungente, di cui è intrisa la terra battuta del fondaco di Torello del Verro e degli altri beccai e che fa impazzire gli animali che, percependolo, avvertono la morte imminente. Oppure il puzzo della carne da troppi giorni macellata, che nella stagione calda presto si decompone e più in generale gli odori grevi e sgradevoli, più spesso i fetori delle vie e dei vicoli di una grande città medievale come Firenze.
Le vicende narrate sono principalmente quelle della famiglia di Torello del Verro, che, prematuramente rimasto orfano, viene avviato al mestiere di beccaio, apre la propria bottega ed ottiene un successo tale negli affari da meritarsi non solo una posizione influente all’interno dell’Arte, ma addirittura il suo governo. Si sposa due volte, prima con Berta, per la quale nutre una passione fatta più di istinto che di sentimento, poi con Amelia, che gli fa conoscere la passione dell’amore. Donna colta ed istruita, figlia di uno speziale, Amelia – uno dei personaggi più importanti ed interessanti del romanzo – apprende dal padre Gerundio la scienza delle erbe e delle piante officinali e assieme a queste coltiva anche uno spirito indipendente ed una capacità di pensiero libero di certo inconsueti e difficilmente accettabili come tratti della personalità di una donna medievale.
 Da Amelia Torello ha due figli, il primo – Lupo – nasce con metà volto sfigurato da una orrenda malformazione, che lo destinerebbe alla morte il giorno stesso della sua venuta al mondo se, come vogliono le convinzioni del tempo, quella deformità altro non sia che la prova di un immondo contatto col demonio. Lupo si salva per la ferma volontà della madre, assecondata da Torello, che lo destina però ad una vita di assoluto isolamento, di segreto ritiro e separazione dal mondo nella casa in campagna del nonno speziale, privato del battesimo e degli altri sacramenti, di fatto così confermato nella sua condizione di reietto, di corpo estraneo alla società civile e religiosa insieme. Lupo dalla madre eredita l’acutezza e l’intraprendenza intellettuali e nella sua forzata clausura laica legge, studia, apprende il mondo pur non vivendolo, pur non sperimentandolo.
Da Amelia Torello ha due figli, il primo – Lupo – nasce con metà volto sfigurato da una orrenda malformazione, che lo destinerebbe alla morte il giorno stesso della sua venuta al mondo se, come vogliono le convinzioni del tempo, quella deformità altro non sia che la prova di un immondo contatto col demonio. Lupo si salva per la ferma volontà della madre, assecondata da Torello, che lo destina però ad una vita di assoluto isolamento, di segreto ritiro e separazione dal mondo nella casa in campagna del nonno speziale, privato del battesimo e degli altri sacramenti, di fatto così confermato nella sua condizione di reietto, di corpo estraneo alla società civile e religiosa insieme. Lupo dalla madre eredita l’acutezza e l’intraprendenza intellettuali e nella sua forzata clausura laica legge, studia, apprende il mondo pur non vivendolo, pur non sperimentandolo.
Falco, il figlio minore, cresce invece nell’agio della casa che le fortune della bottega hanno permesso a Torello di acquistare e viene avviato al mestiere del padre, per il quale però non avverte alcuna inclinazione, a differenza del fratellastro maggiore Orso, che al mestiere di beccaio era stato avviato da quel Mastro Pecora al quale il padre lo aveva venduto quando era bambino.
E al palazzotto di Torello del Verro si recano, perché convocati dal padre morente, i tre figli ad inizio primavera del 1348, poco prima che in città si scateni l’inferno, poco prima che si abbatta sull’intera Europa una mannaia ben più pesante, affilata, tagliente dello strumento di lavoro di Torello e capace di compiere una mattanza che neppure l’intera Arte dei beccai, così assuefatta alla morte, al sangue e al loro odore, avrebbe potuto immaginare: l’epidemia della peste nera.
Di questo tratta la prima parte del romanzo, che inizia con Torello sul letto di morte e si sviluppa come un flashback che rievoca i momenti principali dell’intera vita del mastro beccaio e Prima, Durante e Dopo (la peste) sono chiamate le tre parti in cui si articola la narrazione. Protagonista assoluta della seconda parte è la malattia, che sovverte ogni assetto, che sconvolge il mondo, che, proprio come vogliono le raffigurazioni tardo medievali della morte “trionfante” e “danzante”, travolge e coinvolge tutto e tutti, senza distinzioni, preferenze o privilegi: servi e padroni, miserabili e potenti, poveri e ricchi, contadini e cavalieri, popolani, nobili, re ed imperatori, laici e religiosi, virtuosi e malvagi, innocenti e colpevoli. È la Grande Livellatrice che semina terrore ed angoscia, ma al contempo e almeno in parte, disordinando l’ordine, riordina il disordine della società, cancellando, almeno dinanzi alla morte, quelle differenze che già un secolo prima movimenti pauperistici e mendicanti avevano denunciato.
E proprio nel momento in cui la Natura sembra abortire se stessa, producendo solo aberrazione e morte, è Lupo, il figlio deforme, il prodotto malato e sbagliato della Natura, il frutto del demonio che assurge al ruolo di guida, assumendosi il compito di mettere in salvo un piccolo gruppo che si rifugia nell’isolamento della casa in cui sono cresciuti lui e la madre Amelia, in campagna, a Ponte a Mensola. E quella piccola comunità, che riunisce i tre fratelli – Orso, Lupo e Falco – e la loro madre, Vanna, moglie di Orso ed altri uomini, donne, bambini e serve, aggiuntisi al gruppo per caso e tra questi anche Fiorenza, una meretrice scappata dal bordello, costituisce un microcosmo in cui si producono gli stessi comportamenti e le medesime reazioni che dinanzi a quell’implacabile flagello si verificano in ogni parte d’Europa.
C’è chi, come Orso, neppure di fronte alla morte resiste alla avidità e abbandona il rifugio, torna a Firenze per cercare nella casa paterna una preziosa cintura con la fibbia d’oro e così facendo corre incontro alla malattia e muore sul letto del padre, nell’estremo ed assurdo tentativo di prendere possesso, almeno come cadavere, di quanto Torello, abbandonandolo bambino da Mastro Pecora, gli aveva sempre negato.
C’è poi Vanna, la moglie di Orso, vissuta nel timore e nel rispetto di Dio e della religione fino all’arrivo della peste, che non esita però ad abbandonare il figlio, legandolo ad un ulivo, durante il viaggio di trasferimento dalla città a Ponte a Mensola, erroneamente credendolo ammalato di peste. Anche i vincoli più stretti, i sentimenti più forti come l’amore materno vengono stravolti dall’impeto della paura della morte. La stessa Vanna poi, alla ricerca del marito che non fa ritorno dalla città, decide di tornare a Firenze e dopo aver ritrovato il cadavere ormai putrefatto di Orso, sconvolta ed inebetita, entra in una di quelle ricche dimore in cui vivono i signori del popolo grasso, a cui in altri tempi non avrebbe neppure osato avvicinarsi. Ma ora che tutto è sconvolto, che ogni ordine è sovvertito, varca la soglia di quel palazzo che il potente notaio suo proprietario ha trasformato in una sorta di postribolo carnevalesco, in cui si pratica ogni vizio, soprattutto della gola e del sesso, nella disperata speranza di poter sfuggire alla morte godendo smodatamente e viziosamente di ogni piacere terreno.
 Ma il disordine dei valori, l’infrazione dei limiti morali e la perdita di se stessi nel vizio sono solo alcune delle possibili conseguenze prodotte dalla mortifera pestilenza sulle azioni degli uomini, perché altri comportamenti egualmente irrazionali, seppur di opposto segno, procedono dalla medesima causa. È il caso di Falco che nelle settimane del ritiro e dell’isolamento a Ponte a Mensola via via si chiude nelle sue letture ossessive delle Sacre Scritture e matura la scelta di abbandonare quella piccola comunità per chiedere l’accesso al monastero di Camaldoli. La sua è una scelta di vita claustrale indotta per lo più dall’angoscia e dallo smarrimento dinanzi alla vanità delle transeunti cose del mondo e della vita stessa, che la peste si è incaricata di mettere in evidenza. Una sorta di fuga dal mondo e dalla vita per paura della morte.
Ma il disordine dei valori, l’infrazione dei limiti morali e la perdita di se stessi nel vizio sono solo alcune delle possibili conseguenze prodotte dalla mortifera pestilenza sulle azioni degli uomini, perché altri comportamenti egualmente irrazionali, seppur di opposto segno, procedono dalla medesima causa. È il caso di Falco che nelle settimane del ritiro e dell’isolamento a Ponte a Mensola via via si chiude nelle sue letture ossessive delle Sacre Scritture e matura la scelta di abbandonare quella piccola comunità per chiedere l’accesso al monastero di Camaldoli. La sua è una scelta di vita claustrale indotta per lo più dall’angoscia e dallo smarrimento dinanzi alla vanità delle transeunti cose del mondo e della vita stessa, che la peste si è incaricata di mettere in evidenza. Una sorta di fuga dal mondo e dalla vita per paura della morte.
Ad affrontare con maggiore equilibrio e compostezza il pericolo costante della morte e la vita segregata di quella piccola comunità che cerca l’isolamento dal circostante mondo appestato sono due personaggi femminili: Amelia e Fiorenza. La prima all’intelligenza e alla conoscenze apprese dal padre speziale aggiunge la saggezza dell’età avanzata, dell’esperienza della vita e del mondo ed affronta la vita che le rimane, la malattia e la morte con sereno equilibrio. La seconda, la prostituta, è una donna sicura di sé e conscia della propria bellezza, padrona del proprio corpo, nonostante lo metta in vendita per professione. È, insomma, ella stessa maestra di un’arte, come Torello o gli altri maestri delle botteghe fiorentine; la sua è l’arte della sensualità, non del sentimento dell’amore, ma del piacere amoroso, sessuale, che padroneggia e dispensa con maestria e della propria arte vuole rendere partecipe anche Lupo, quel giovane ombroso e misterioso, apparentemente incapace di contatto umano, che indossa perennemente un pesante pastrano con cappuccio, tagliato e cucito apposta per coprire la mostruosità della metà sfigurata del suo volto.
E Lupo è un personaggio chiave del romanzo di Paola Presciuttini, perché in un mondo che, travolto dal morbo sconosciuto ed invincibile, si abbandona all’irrazionalità, alle superstizioni o alla fede, cerca di tenere acceso il lume della ragione e non si accontenta di spiegare la peste come conseguenza di una eccezionale congiuntura astrale, o della corruzione dell’aria, o come terribile ma giusta punizione divina degli smisurati peccati dell’umanità, o come vendetta diabolica attuata per mezzo di agenti perversi del maligno come gli ebrei. Proprio lui che per necessità è stato escluso dalla grazia di Dio, dalla fede e dal conforto dei sacramenti ricorre all’uso della ragione che lo guida nell’osservazione della Natura. Convinto che da Dio non possa venire alcun male e a maggior ragione una malvagità come la peste, va alla ricerca di una spiegazione sensata cercandola dentro alla natura, dentro al mondo, tra gli uomini che decide di studiare ed osservare, abbandonando anche lui il rifugio di Ponte a Mensola e l’isolamento dal mondo, che era stata la sua condizione di vita sicura fino a quel momento, per andare in città, per registrare, ispezionare e riflettere. La sua è la curiosità spregiudicata dell’uomo di scienza, che non si accontenta delle risposte già disponibili ed intraprende l’esplorazione di nuovi territori ancora sconosciuti.
In questo lavoro sorretto dalla cultura classica che gli ha insegnato che le malattie, come la rabbia, possono essere trasmesse dagli animali all’uomo, intuisce la spiegazione esatta della trasmissione del morbo pestilenziale, che attribuisce ai tanti ratti morti da cui è letteralmente invasa la città di Firenze, ma le sue intuizioni così come la sua Cronaca rimarranno lettera morta e non incontreranno fortuna nella Firenze degli anni successivi alla più terribile epidemia di peste della storia.



