di Gianpietro Miolato
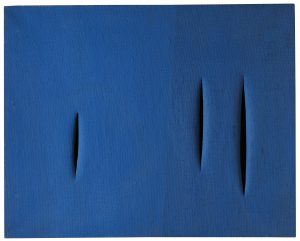 Tra venti minuti sarò morto.
Tra venti minuti sarò morto.
Lo so perché me lo ha detto Elena. È arrivata, ha aperto la porta e ha detto che oggi era arrivato il nostro giorno.
I venti minuti li deduco dal tempo che separa il commiato dal suo ritorno. Ha detto che sarebbe andata a farsi una doccia e che poi mi avrebbe sparato. Conosco le tempistiche: dieci minuti se deve fare i suoi bisogni; venti se deve lavarsi, di cui cinque per la doccia vera e propria e quindici per l’asciugatura e la vestizione.
Ha i capelli castani corti, quindi non si preoccupa di pettinarli e renderli diversi da come possono apparire ad un estraneo. La capigliatura è un misto tra una rasatura e un caschetto. Ha due frange: una frontale e una al lato sinistro. Il resto dei capelli è corto mezzo millimetro. A prima vista si potrebbe pensare che manchi di femminilità rispetto ai canoni estetici cui siamo abituati. Capelli lunghi ben curati o corti sulla parte posteriore della nuca poco importa. L’uno o l’altro, comunque, hanno una proporzione. In Elena non c’è proporzione. Non nella capigliatura. Tale mancanza potrebbe suscitare una repulsione in quanto manca un modello di riconoscimento standard per classificarla. Ma questo varrebbe per un estraneo. Ed io non lo sono.
L’acqua inizia a scrosciare. Essendo l’ultimo giorno che passo su questo mondo, per un momento ho creduto mi sarebbe stato riservato un pasto particolare, l’ultima cena del condannato. Invece non ho ricevuto nulla di diverso da quello che ricevo tutte le sere: niente. Elena mi porta da mangiare una volta al giorno, a pranzo. All’inizio del soggiorno in cantina mi pesava dovermi nutrire così. Ero abituato a tre pasti caldi e non lesinavo in alcolici. Ora non mi pesa più. Noto i miglioramenti della dieta. La pancia è calata al punto che quando mi alzo riesco a vedermi i piedi. Era dalla prima volta che ci conoscemmo vicino alla palestra della scuola elementare di Sossano, sotto un tenue sole d’aprile, che non li vedevo. Inoltre, benché sia meno in forze, mi sento più giovane. È una bella sensazione, soprattutto confrontandomi con Elena. Nell’ultima settimana (anche se non saprei dire che giorno sia oggi, nonostante segni il passaggio di 24 ore in 24 ore grazie ai pasti) mi sono guardato i polsi. Sono filiformi e con uno sforzo potrei liberarli. Ma non avrebbe senso. Così facendo mi allontanerei e non voglio starle lontano. Non più. Se mi trovo in questa situazione è perché lo ha voluto lei. E non avrei potuto desiderare altro. Non desideravo altro.
I rumori della doccia cessano. Immagino Elena mentre esce e prende un asciugamano. Il corpo accarezzato dalle gocce d’acqua calda, lo specchio appannato dal vapore, le impronte lasciate sul pavimento. Ogni elemento concorre a rendere unico il più piccolo gesto. Ed io sono parte di questa unicità. Vorrei essere seduto su una sedia, in bagno, mentre si veste. Non ho mai visto il resto della casa, non so se vi sia una finestra o meno. Ma mi piacerebbe vederle il corpo avvolto dai raggi di sole, con in risalto la morbidezza della pelle e la giovinezza dei lineamenti.
L’ultima volta che ho visto il sole era inverno. Ora vedo solo la luce che filtra dalla porta quando mi porta da mangiare. Il resto del tempo sto al buio, seduto sul materasso. Ripenso alla luce del giorno con nostalgia. Sarebbe bello essere all’aperto ed esprimere quello che provo. Non vorrei che i pochi minuti che mi restano da vivere fossero spesi in cantina.
L’ultimo giorno in cui vidi il sole era un mercoledì di dicembre. Quella sera ci saremmo visti. Le avevo scritto a novembre, per chiederle un incontro. Ufficialmente avevo chiesto di vederla per scusarmi di quanto era avvenuto. All’inizio non aveva risposto, e non ne compresi le ragioni. Avevo scritto un messaggio sulla chat privata di facebook chiedendo se si ricordasse di me. Vederla in foto fu un’epifania. Era limpida in ogni posa. Non aveva molte foto, una quarantina in tutto. E non c’era uno scatto in cui ridesse. Era ripresa di lato o da dietro, mentre sparava in un poligono. Non un’immagine con qualcun altro. Cuffie blu, cappello con frontino, occhiale scuro, fisico sodo e allenato. Il look era identico. Differiva lei. Ogni immagine era un’istante di Elena che non sarebbe tornato. Mi nutrii di quegli istanti. Erano come gli attimi che trascorremmo assieme. E lei, sola in ogni riquadro, lontana da condivisioni amicali d’accatto, risplendeva di una luce senza forma, di una lucentezza esclusa a tutti. Tranne a me. Adorai i momenti di solitudine in cui potei gustarmi il suo viso. Era come tornare nel mio letto, quando ci conoscevamo a vicenda. Attimi irripetibili e assoluti.
Scrissi utilizzando un tono gentile. Non volevo creare contrasti, non dopo quello che era avvenuto. Lei rispose che non poteva dimenticarmi e che era incredula del fatto che l’avessi contattata. Risposi che comprendevo lo stupore, ma che non era più quello di una volta. Avevo avuto modo di cambiare. Lei rispose che non ci credeva e che dopo quello che era successo il semplice sentirmi rendeva la realtà surreale. Utilizzò esattamente quest’aggettivo: surreale. Mi sentii in imbarazzo ma non demorsi. Scrissi una seconda volta per sapere se e quando c’era modo di parlare. La situazione andava chiarita dopo gli anni che ci avevano separati. Per due giorni non ebbi sue notizie. Poi arrivò un messaggio.
Mentre attendevo di sapere se e cosa sarebbe avvenuto, ripensai agli ultimi anni. Non era trascorso un solo giorno senza che la pensassi. Era un punto fisso delle giornate che ero stato costretto a starle lontano. Non è semplice essere rinchiusi in una stanza per giorni e giorni senza avere un appiglio cui aggrapparsi – un po’ come sta capitando in questi mesi. Ma come adesso, anche allora avevo un motivo per non abbattermi: lei.
È difficile spiegare come funzionino certe dinamiche di coppia. E ancor più difficile è spiegarlo ad un giudice. Non mi capacitavo che fosse così oscuro comprendere che il mio agire era stato dettato dall’amore. Non me ne capacitavo per due motivi: primo, era palese alla luce del fatto che mai una volta avevo alzato una mano per farle del male; secondo, c’era stato solo amore. Ma questo era ciò in cui credevo io. Al giudice non era importato, e dovetti scegliere: ammettere che non era stato vero amore ed avere uno sconto di due anni dal soggiorno che mi avrebbe allontanato dalla vita civile; dire la verità, che era stato solo amore, e starmene lontano più di quanto chiunque avesse amato come avevo amato io potesse meritare. Scelsi la seconda.
Nei giorni in cui fissavo il soffitto tra le mura isolate dell’istituto di Vicenza, pensai che avrei trovato solidarietà tra i miei compagni. Non fu così. È incredibile quanto poco siano comprensive le persone quando c’è di mezzo una donna. Provavo a spiegare che non era avvenuto nulla di contrario all’amore, nemmeno fattualmente, ma appena si accennava alla presenza di una donna le parole diventavano inutili. Nemmeno alla luce della mancanza di dinieghi da parte di Elena. Dovetti subire angherie fisiche e mentali che non meritavo, e tutto per aver dato ragione di un sentimento limpido e puro. Mi feriva vedere come la verità cruda e semplice fosse impossibile da dire. Ma quest’esperienza mi aiutò a comprendere che la verità va mediata. E con essa vanno mediati i modi con cui la si esprime. Quando ero in procinto di subire un ingiusto attacco da parte di qualcuno, e tentavo inutilmente di dare un quadro complessivo della situazione in cui mi ero trovato ricevendo in cambio incomprensioni e ostruzionismi, mi sentivo come quando a otto anni uscivo a cena con mia madre.
Ero figlio unico e mia madre lavorava come commessa in un supermercato. Mio padre era morto quando avevo tre anni e lei non se l’era sentita di risposarsi. Diceva che avrebbe offeso la memoria del babbo. Non capivo cosa intendesse e non me ne importava. Non eravamo poveri in quanto papà ci aveva lasciato un appezzamento di terra che veniva lavorato da dei terzisti. Né io né mamma sapevamo cosa e come venisse utilizzato il campo, ci bastava ricevere la percentuale dalla vendita della lavorazione. Benché avessimo l’entrata data dal campo, mia madre voleva lavorare. Non era esclusivamente per una questione economica; lo voleva per non dover stare a casa a rimuginare sulla solitudine.
La casa era di proprietà di papà e si trovava in una viuzza che si perdeva nel mezzo di una collina, tra Belvedere e Pozzolo. Mio padre era figlio unico e i parenti più stretti – una cugina di secondo grado e uno zio acquisito – vivevano in Valle D’Aosta. Con la sua morte la casa era passata a mia madre, assieme al campo. Nessuno si era fatto vivo con pretese economiche. Nessuno si era fatto vivo nemmeno al funerale. Mia madre era stata nominata unica ereditaria dei beni. A volte la vedevo accarezzare i muri in mattone quasi ad affermarne l’appartenenza.
Mangiavamo a casa quasi ogni sera, seduti davanti il camino. Coi turni al supermercato non era semplice pranzare insieme e durante le colazioni non parlavamo molto, ma di sera il clima si ravvivava. A cena mia madre aveva l’abitudine di bere dai due ai quattro bicchieri di vino, dipendeva dalla giornata, e quando si arrivava a quattro i discorsi esistenziali si sprecavano. A me veniva da ridere poiché non capivo il senso delle parole, ma l’ascoltavo meglio che potevo.
Benché non ci muovessimo molto, una volta a settimana, ogni settimana fino al compimento del mio sedicesimo compleanno, andavamo a mangiare la tagliata alla trattoria Al Passeggio. Il locale era posto ai piedi dei colli che sovrastano Lonigo, a dieci chilometri da Pozzolo, e per tutti gli anni che lo frequentai mantenne lo stesso arredamento: muri color panna acida e quadri di clown appesi agli angoli della sala. Non sopportavo i colori tenui e i pagliacci mi trasmettevano repulsione e tristezza, ma non ebbi il coraggio di lamentarmene. Ordinavo mezza tagliata ben cotta, mentre mia madre una tagliata al sangue. Con calma e diligenza consumavamo le pietanze nella quiete del locale, che spesso era vuoto in quanto vi andavamo di martedì. Mia madre gustava i bocconi con soddisfazione. Era come se ogni morso confermasse che si era guadagnata quel sapore e quella consistenza tra i denti. Non di rado, però, la sentivo criticare la cottura, per lei poco curata. Col tempo capii che quelle critiche erano nulla più che lo snobismo degli ignoranti, forma di difesa ultima cui si rivolgono i poveracci come eravamo noi per convincersi d’essere competenti in qualcosa. Quando la sentivo pronunciare di queste critiche stavo zitto, ma una sera di marzo, all’altezza dei dieci anni, stufo di una critica che non mi pareva legittima considerato l’intingolo sanguinolento che le riempiva il piatto, chiesi se il senso di eccessiva cottura non fosse dato dalla macellazione dell’animale anziché dalla presunta incapacità del cuoco. Mia madre sbarrò gli occhi e mi ammonì a non dire più certe sconcezze mentre si era a tavola. La morte di un animale non era argomento di conversazione. Mi sentii umiliato e tacqui. Lei terminò la tagliata e la settimana seguente riprese a criticare e a mangiare.
Questo era il punto: non era necessario avere un quadro complessivo della verità, quello che contava era dar ragione di una porzione di realtà che permettesse di affermare una posizione soggettiva. Che poi questa fosse limitata e scorretta non importava. Soddisfatta la soggettività il resto era superfluo.
Alla luce di questa impossibilità nel dire le cose nel loro complesso, scrissi ad Elena che ero cambiato. Non potevo dirle che l’amavo ancora come il primo giorno. E nemmeno potevo dirle che avrei fatto tutto ciò che era in mio potere per riallacciare la relazione. Era impossibile che nel corso degli anni i genitori e gli amici non le avessero fatto il lavaggio del cervello per convincerla che ero la persona sbagliata. Erano stati loro a troncare la relazione e a mettermi nella condizione di dover essere punito per aver detto la verità, quindi la mediazione mi andava bene se garantiva di tornarle vicino.
Correvo dei rischi a contattarla, avrebbe potuto dirlo a quegli stessi genitori o agli amici – chissà quanto poteva essere stata manipolata –, ma o le scrivevo o non c’erano ragioni per vivere.
I giorni lontano dalla vita civile si svolgono in modo strano. Chiunque abbia esperito questa condizione sa che i pensieri, per quanto incostanti, assumono contorni e significati più vividi rispetto a quando si è liberi. Se pensavo ad un caffè non pensavo ad un caffè qualunque, ma pensavo ad un caffè che diventava il caffè. Il motivo era semplice: un caffè era qualcosa che potevo avere a mia discrezione; il caffè era ciò che agognavo smodatamente senza ottenerlo poiché non mi era concesso di servirmene come volevo. Alla luce di ciò, quindi, Elena diventò la persona che dava senso alle mie speranze. Se aveva dato forma e senso all’amore, ora dava senso alla speranza che una volta uscito sarei tornato da lei, e che con lei avrei ritrovato il senso di completezza che il confine dalla civiltà mi stava togliendo.
Nel messaggio disse di scriverle su 5chat, una chat anonima. Mi spiegò essere uno strumento rapido e semplice. Lei lo usava da anni. Ci saremmo trovati su Chat Over 40, e lei si sarebbe chiamata come me ma al femminile. La trovai al terzo tentativo. Mi chiese se qualcuno sapeva di noi. Dissi la verità: no. Mi chiese allora come poteva fidarsi. Risposi che non avevo nessuno a cui dirlo a causa dell’esilio prolungato cui ero stato sottoposto, e che comunque non avrei avuto motivo di parlarne con qualcuno. Mia madre era morta da quindici anni, lasciandomi in eredità la casa e la rendita del campo – almeno fino alla parentesi che mi allontanò dalla società – e, per quanto la vita relazionale che vivevo si riducesse ad andare al cinema, le poche persone con cui mi rapportavo – il datore di lavoro, i colleghi programmatori, la commessa del supermercato di Grancona – non avevano accettato la coerenza del mio agire.
Non mi avevano cercato quand’ero lontano dalla civiltà e non avevano iniziato a farlo ora che ci ero tornato.
Non sapevo se Elena potesse credere che fossi solo, ma importò poco. Volevo solo ritrovarla.
Ci demmo appuntamento a San Giovanni in Monte, alle 21:15, nell’ex parcheggio dei camion, a mezzo chilometro dalla scuola elementare, lontano da occhi indiscreti che potessero conoscerci. La scuola era stata chiusa nel 1975 e da allora aveva accolto qualche barbone, erbacce e umidità. Alla fine si era stagliata come rudere a memoria di un tempo che non sarebbe più tornato, e di cui non importava più niente a nessuno.
Completando i tornanti che mi avrebbero portato al parcheggio ebbi la nausea. Da una parte a causa dell’auto – le viucole che si staccano dalla provinciale 13 e conducono al centro del comune si inerpicano per i dislivelli del monte come l’edera su una roccia –, dall’altro dall’accumulazione di emozioni e dubbi che mi avevano accompagnato negli ultimi tempi. Le ore trascorse ad immaginare l’incontro, le notti a fissare il soffitto ricordando il suo profilo, il richiamo del suo profumo ogni qual volta un’essenza di fragola mi giungeva alle narici, i violenti abbracci nel buio della mia camera, tutto era vivido e reale. Le mani tremavano e per poco non persi il controllo della Punto mentre completavo l’ultimo tornante. Una nebbia sottile e grigiastra copriva la strada. L’illuminazione asettica della strada dava una sensazione di straniamento, quasi stessi percorrendo la via di una realtà parallela e sconosciuta. Transitando davanti alla scuola elementare la tensione si smussò e provai un senso di ilarità. Vicino ad una scuola ci eravamo incontrati; vicino ad una scuola ci saremmo ritrovati. Svoltai a destra e mi ritrovai su una strada sterrata e non illuminata. Mi fermai all’imboccatura e tirai il freno a mano. Era una laterale dell’arteria principale che da lì a 5 km portava al centro. Non c’era un cartello vero e proprio ad indicare il parcheggio. Si capiva dove fosse da un’insegna arrugginita posta a pochi metri dall’inizio che ritraeva la sagoma di un camion con due uomini stilizzati. La mancanza di illuminazione mi intimorì. Perché Elena voleva che ci vedessimo al parcheggio? E perché a quell’ora? Non me l’ero chiesto prima, preso dai fumi dell’eccitazione, ma adesso non riuscivo a non pensarci. Smontai. Il freddo mi arrivò alla gola come un colpo ben assestato e dovetti coprirmi il collo con le mani. Ero vestito con un maglione e una giacca. La sciarpa era rimasta in cascina. Fissai il tratto di strada illuminato dai fari e mi guardai attorno. La nebbia avvolgeva quel poco di panorama che scorgevo. Nessuno era in procinto di passare, e non lo biasimavo. Le strade erano irte e mal fatte. Buche e dislivelli rovinavano la percorribilità, e dovevi stare attento ai margini della corsia per non cadere nei dirupi che costeggiavano la carreggiata. In cima al monte da cui prendeva il nome il paese, spiccavano cinque luci di altrettante dimore. Io ero quasi a valle, poco dopo l’inizio del dislivello. La tensione stava svanendo, lasciando spazio ad un misto di eccitazione e preoccupazione. Ero eccitato al pensiero di Elena; ero preoccupato che non le piacessi. Quando ci eravamo conosciuti non aveva manifestato insofferenze alla mia persona. Ma ora, dopo il lavaggio del cervello che sicuramente le avevano fatto, e dopo il distacco che ci era stato imposto, cosa avrebbe pensato? Era impossibile non fosse stata convinta della scorrettezza del nostro amore. La reazione di suo padre era ancora vivida e cristallina.
Eravamo nel cortile dietro alla cascina, seduti sui gradini che davano all’entrata di servizio. Era un tardo pomeriggio di metà novembre. La temperatura era mite e avevo deciso di guardare il tramonto assieme a lei. La campagna era immobile e statuaria. I filari di cabernet e chardonnay si concretizzavano come righe di un pentagramma, e la flora circostante conferiva al quadro tali immobilità e simmetrie che mi parve d’essere di fronte a degli emblemi di perfezione. Elena era da me da quattro giorni. Avevo preso ferie. Volevo starle vicino più di ogni altra cosa. Mentre fissavamo il giorno morire, con la notte che avanzava prepotente, sentii un rumore alle mie spalle. Appena mi girai vidi una figura tarchiata muoversi con agilità. Riuscii solo ad alzarmi, staccandomi da Elena. Il pugno arrivò dritto alla gola. Caddi stringendomi il collo. Il cielo divenne nero e la trachea reclamò aria. Iniziai ad annaspare, tentando di voltarmi. Appena mi mossi, il corpo tarchiato mi fu sopra e mi tempestò di diretti al naso. Alzai le mani per difendermi ma non fui abbastanza veloce da evitare che l’uomo me lo rompesse. Il sangue uscì a fiotti e mi riempì il viso. Ne sento ancora il gusto metallico e salato tra i denti. Iniziai a tossire e fui preso da una paura che mai avevo provato prima. Era la paura di perdere Elena. Al settimo pugno le forze scemarono ed ebbi solo il tempo di voltarmi per rivolgerle l’ultimo sguardo. Era rannicchiata di fianco alla scala, stretta nel vestito azzurro a pois del primo giorno in cui era arrivata, e piangeva. La guardai per pochi istanti. Poi svenni. Al mio risveglio ero in ospedale, con due poliziotti al mio fianco. L’avevo persa.
Potevo ritrovarmi in una situazione analoga entro pochi istanti, oppure no. Avevo solo un modo per scoprirlo. Rimontai e mi inoltrai lungo la strada. Arrivato al parcheggio non c’era nessuno. Il luogo ora era utilizzato dai camper. Per non sprecare la struttura non più utilizzata dagli itineranti, il comune aveva convertito il sito. Nella nebbia si intravedevano i cartelli per lo scarico dei rifiuti organici e le prese di corrente. Quella sera di dicembre non c’era nessuno. E dall’ordine che regnava intuii che non era un luogo molto frequentato da chi voleva mettersi in viaggio. Rimasi in macchina, spensi il motore e restai stretto nella giacca. Guardai l’ora: le 21:32. La tensione tornò a salire e mi prese lo stomaco. Ebbi delle fitte al basso ventre e dovetti stringermi le braccia per farle passare. Strinsi invano. Stava accadendo, stava davvero per accadere. Allora perché era in ritardo? Lo stomaco diede un colpo. Mi aggrappai al volante e alzai il colletto della giacca. E se non fosse venuta? Se mi avesse imbrogliato? Scacciai i pensieri scrollando la testa. Non volevo considerare che potesse realizzarsi qualcosa del genere. I suoi genitori potevano averla convinta di quello che volevano; Elena era autonoma. Ma se non fosse stato così? O se, peggio ancora, i suoi genitori le avessero estorto che dovevamo vederci e si fossero presentati al suo posto? Ebbi freddo come mai prima di quel momento. Appoggiai la testa al volante e respirai lentamente. L’amore non è piacevole né semplice. L’amore è insicurezza e attesa, e non ti lascia alternative. Prendere o lasciare.
Una luce attraversò la nebbia. Alzai lo sguardo con uno scatto e trattenni il respiro. Non provai più dolore o ansia. Ero impietrito. La luce si avvicinò e dopo una quindicina di metri i fari di una jeep si materializzarono nella foschia. Mi sentii in soggezione, vulnerabile e alla mercé del destino. La macchina si fermò e spense il motore. Le luci restarono accese, fisse sulla Punto. Ripresi a respirare ansimando. Lo sportello della jeep si aprì e ne uscì una figura. Non riuscii a distinguerla nella nebbia. La figura camminò verso di me e si mise davanti ai fari. Nemmeno controluce ne distinsi il volto. Potevo vederne solo il contorno. Era alta un metro e settanta e portava dei pantaloni scuri ed un giubbotto. Le braccia erano conserte e la testa non era scoperta, sebbene non capii cosa la coprisse. Rimase immobile a fissarmi. I dubbi, le insicurezze e le preoccupazioni mi passarono davanti agli occhi. Lo stomaco riprese a macinare e la gola si fece secca. Temetti che il mio sogno d’amore fosse finito. Di nuovo. Mi voltai ed appoggiai la mano sulle chiavi. Feci per mettere in moto, ma un dubbio mi prese la viscere: e se fosse stata Elena? Stavo per gettare anni di attesa per la mancanza di un briciolo di coraggio? Stavo davvero facendo questo? Se non fosse stata Elena e fossi scappato, avrei evitato spiacevoli conseguenze con chiunque mi stesse aspettando. Ma se non fosse stata lei?
Tolsi la mano dal quadro, aprii lo sportello ed uscii. Il gelo mi colpì il collo, come pochi minuti prima, ma questa volta fu più acuto e penetrante. Fissai la figura. Non ne riconobbi i lineamenti. Mi avvicinai lentamente. Con una mano fece cenno di fermarmi.
«Elena?», chiesi con voce rauca.
La figura annuì, mise le mani in tasca e m’invitò ad avvicinarmi. Il battito del cuore mi riempì le tempie, e la commozione mi prese gli occhi. Era davanti a me. Potevo amarla di nuovo. La figura mi venne incontro allargando le braccia. Io le aprii di rimando. Le lacrime mi segnavano le guance. Quando ci incrociammo vidi gli occhi della figura. Erano azzurro chiaro, intrisi di dolcezza e delusione, come un cielo primaverile dopo un temporale. Occhi indimenticabili. Gli occhi di Elena. Gli anni spesi a fissare il nulla, le iniquità giuridiche, le condanne sentimentali, tutto era finito. L’emozione mi fece abbassare le mani. Lei mi cinse ed avvicinò il braccio destro alla mia bocca. Un aroma intenso e dolciastro mi prese le narici. Fissai quei meravigliosi occhi mentre le gambe cedettero. Poi fu il buio.
Sento dei passi decisi e cadenzati lungo le scale. I passi sono decisi e cadenzati. I passi di Elena. Saprei riconoscerli anche se ne sentissi l’eco a decine di metri di distanza. Guardando la cantina provo un senso di tristezza. Non dovrei contando che per la seconda volta nella mia vita sono stato esiliato dal mondo, ma è così. Se ci penso con attenzione, però, posso capire che la tristezza non è data da quello che il luogo richiama; è data dalla promessa che Elena sta per mantenere. Tra pochi istanti il nostro amore sarà concluso, e ne prendo atto con amarezza. Ma questi giorni sono stati tutto ciò che potevo desiderare. Io la volevo, e l’ho avuta. Il come ho vissuto è relativo.
Quando mi svegliai la testa mi doleva. Appena alzai le mani per accarezzarmela venni bloccato dalle catene. Cercai il telefono e non lo trovai. Non avevo nemmeno il portafoglio. Temetti fosse accaduto, ero stato allontanato da lei un’altra volta. La paura prese il sopravvento sul dolore e mi alzai nel tentativo di liberarmi. Fui rapido, troppo, ed inciampai. La terra mi accolse con tutta la sua durezza. Stetti sdraiato per un tempo che non riuscirei a quantificare. Le tempie mi scoppiavano e sentivo che sarebbe arrivato qualcuno a punirmi per aver perseguito il mio amore. Ma la porta si aprì, e la vidi. Elena era in piedi, statuaria nella tuta verde a righe bianche mentre reggeva un vassoio. Tutto quello che mi circondava perse d’importanza. Tornai alle emozioni del parcheggio. E fui felice. Elena si avvicinò, si inginocchiò e appoggiò un piatto con della minestra. Tentai di parlare ma appena aprii bocca lei se ne andò. E questo è ciò che è avvenuto lungo tutti i giorni che ho trascorso qui sotto.
Non so di preciso quanti siano. Almeno due mesi. Pensai spesso se qualcuno aveva trovato la mia macchina, o se al lavoro avevano denunciato la mia assenza. Magari erano pure venuti a cercarmi. Quello che so è che non mi è pesato sopportare il soggiorno, né il secchio come cesso, né il maglione logoro e unto che mi accompagna da quella sera di dicembre, né le coperte lerce che mi avvolgono quando perdo i sensi dopo la minestra, né il materasso sgualcito che dà asilo al mio riposo.
La porta si apre. Il bagliore mi acceca e alzo le mani per proteggermi. La silhouette si muove vigorosa ma con grazia. In mano Elena ha qualcosa che non vedo. È in controluce. Si sposta e capisco che è un pacco di cartone. Lo appoggia sul tavolo alla sua sinistra. È il tavolo su cui appoggia la cena. Chiude l’uscio dietro a sé e accende la luce. Un altro bagliore mi colpisce e devo coprirmi nuovamente. Il trauma passa dopo pochi istanti e finalmente riesco a guardarla. È radiosa come ogni volta che entra. La pelle è liscia e curata, a differenza della mia. Le flaccide rughe che mi avvolgono, mi fanno vergognare di avere anche solo l’onore di posare gli occhi sulla sua giovinezza. Mi alzo, allentando i polsi dalle manette. Non ho un bell’aspetto, non sono sbarbato né lavato, ma voglio starle di fronte. Elena mi guarda per un secondo, senza far trasparire emozioni. Ha una canottiera bianca da cui non compare il reggiseno, e un paio di pantaloni neri di una tuta. Le spalle sono toniche e aperte, da nuotatrice professionista. Ai piedi porta scarpe da ginnastica. Si avvicina al pacco, lo apre e ne estrae una busta che appoggia al bordo destro. Dal tavolo torna al pacco e ne estrae una confezione più piccola, in plastica. Un odore di mandorle invade la stanza. La fisso mentre si muove, e vorrei essere il tavolo per percepire le mani che ne sfiorano la superficie. Elena getta la scatola a terra e apre la confezione di plastica. Dentro vi è una torta. Mi avvicino e vedo che sulla superficie c’è scritto “buon compleanno”, con a fianco una sua foto. È assieme a suo padre ed indossa il vestito azzurro a pois. Sono abbracciati e ridono.
Lei nota il movimento e intima di fermarmi. Mentre indietreggio, la sua mano è sulla busta di carta. Estrae una pistola e mi spara due colpi allo stomaco. Cado prima ancora di capire quello che è accaduto, ma appena sono a terra lo capisco e un dolore lancinante mi attraversa il corpo. Mi dimeno agonizzando e sbraitando. Appena mi fermo a guardarmi le mani, queste sono ebbre di sangue e così riprendo a stringermi e urlare. Dopo qualche secondo Elena si avvicina, mi dà un calcio per girarmi e mi spara nuovamente alla pancia. Il terzo colpo mi colpisce come il primo, ma sto perdendo sangue e il trauma passa in fretta. Ora sono disteso, con la testa appoggiata al muro. Lei è di nuovo al tavolo. Il dolore è assolutizzante e ho la fronte che gronda sudore. Ho le mani intrise di sangue e anche la schiena ne viene avvolta. Ma non ho paura di morire.
Elena estrae dalla tasca destra dei pantaloni un accendino e due candele a forma di numero. Le inserisce nella torta e le accende. Il numero che le illumina è “20”. Con un dito raccoglie una porzione di glassa e la porta alla bocca. Quando è all’altezza delle labbra noto che sta piangendo. Lei mi vede e mi punta la pistola in faccia.
Al chiarore delle candele gli occhi le luccicano di dolore ed eccitazione.
Sono gli occhi che ho sognato.
Gli occhi che ho bramato.
Gli occhi di quando facemmo l’amore la prima volta.
Dodici anni fa.



