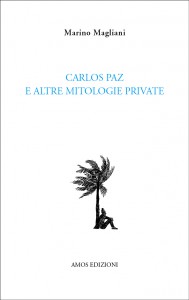 [Pubblichiamo due estratti di racconti contenuti nell’ultimo libro di Marino Magliani, in libreria in questi giorni. Si tratta di storie autobiografiche ma non solo: testi fiabeschi, racconti di ambienti, di personaggi favolosi, in un tempo sospeso e in un luogo che forse non c’è. Il libro verrà presentato a Bologna, alla libreria Modo Infoshop Via Mascarella 24/b, domani, sabato 19 marzo, alle ore 19 con Mauro Baldrati; a Forlì, al Dipartimento di Traduzione dell’Università in Corso della Repubblica 136, alle ore 11; a Firenze alla libreria On The Road in Via Vittorio Emanuele 32, alle ore 19 con Paolo Ciampi; al Rifugio Isera a Corfino (LU) Parco dell’Appennino Tosco Emiliano alle ore 15 (con camminata); a Genova, Museo Biblioteca dell’Attore, via del Seminario 10, ore 17,30, con il Presidente Eugenio Pallestrini, il prof. Eugenio Buonaccorsi e il prof. Vittorio Coletti.]
[Pubblichiamo due estratti di racconti contenuti nell’ultimo libro di Marino Magliani, in libreria in questi giorni. Si tratta di storie autobiografiche ma non solo: testi fiabeschi, racconti di ambienti, di personaggi favolosi, in un tempo sospeso e in un luogo che forse non c’è. Il libro verrà presentato a Bologna, alla libreria Modo Infoshop Via Mascarella 24/b, domani, sabato 19 marzo, alle ore 19 con Mauro Baldrati; a Forlì, al Dipartimento di Traduzione dell’Università in Corso della Repubblica 136, alle ore 11; a Firenze alla libreria On The Road in Via Vittorio Emanuele 32, alle ore 19 con Paolo Ciampi; al Rifugio Isera a Corfino (LU) Parco dell’Appennino Tosco Emiliano alle ore 15 (con camminata); a Genova, Museo Biblioteca dell’Attore, via del Seminario 10, ore 17,30, con il Presidente Eugenio Pallestrini, il prof. Eugenio Buonaccorsi e il prof. Vittorio Coletti.]
La pancia
(…) Ma lo scrittore non era neanche al museo, e allora l’uomo che cercava lo scrittore riprese a girare le strade e lungo i canali di Haarlem, e a tutti quelli che gli sembravano degli scrittori, o che leggevano un libro, che erano scrittori che leggevano o lettori che scrivevano, e ne incontrò moltissimi, anche donne scrittrici, gentili, con le calze rosse e i fianchi rotondi, che avrebbe preso volentieri alla pecora non fosse che cercava lo scrittore, egli chiese se avevano visto per caso lo scrittore delle panchine.
Gli rispondevano tutti la stessa cosa: lo scrittore che narra le panchine oggi non l’abbiamo visto, qui c’è lo scrittore che narra le lune, e quello che narra l’amore, e ce ne sono altri che narrano gli animali, e il Portogallo. L’uomo con la pancia prese nota e scoprì un mucchio di nomi di grandi narratori, Cavazzoni, Celati, Giacomo Sartori, Antonio Tabucchi, l’argentino che narrava i tassi mortiferi, Elio Lanteri, Vincenzo Pardini, Giorgio Vasta, e scoprì che lo scrittore delle panchine era Sebaste perché prima di quel giorno non sapeva che si chiamava Sebaste, in tanti anni non s’erano mai chiamati, si sedevano uno accanto all’altro e mentre parlavano si guardavano, oppure si aspettavano e quando uno dei due arrivava da lontano e l’altro era già seduto, si guardavano e basta. Oppure chi era seduto diceva all’altro: sei arrivato? Ma mai una volta che fossero arrivati assieme, tanto da salutarsi e chiamarsi per nome.
L’uomo con la pancia seguì le indicazioni e andò chiedendo fin quando non incontrò davvero Beppe Sebaste.
Era una mattina, era domenica ad Haarlem, e Sebaste stava seduto su una panchina di legno, in un parco. La panchina era più alta del normale e i piedi di Sebaste non toccavano per terra, ma dondolando sfioravano il pezzo di terra spelacchiata. Sulle assi scolorite c’erano delle incisioni. L’uomo con la pancia si avvicinò e lesse.
Te sei Sebaste, gli chiese poi. Sono Sebaste, rispose Sebaste.
Narri le panchine, domandò l’uomo con la pancia.
Sebaste abbassò le palpebre.
Ho capito, però te non sei lo scrittore che si sedeva sulla panchina di fronte alla mia finestra.
Perché no, potrei esserlo, dove si trova la panchina, in che piazza, di quale città?
L’uomo con la pancia disse il nome della piazza, e disse che la città era Haarlem, ma poi aggiunse: no, non sei tu.
Tornò a guardare la Sint Bavo e la panchina, il suolo infossato dove lui o Sebaste, il Sebaste che conosceva lui, posavano i piedi. Panchina vuota. Lo immaginava. Entrò in casa, andò rasente al muro per non restare prigioniero dello specchio, strisciò, ancata dopo ancata. Si rialzò, si tolse la giacca, poi ci pensò su un attimo e rifece gli stessi gesti, prese la giacca, scansò l’incontro con lo specchio, e a pancia a terra raggiunse la porta, uscì, andò a risedersi sulla panchina e per un attimo ebbe la strana idea che lo scrittore fosse lui, che non era mai stato lui, certo, troppo semplice, ma ora sì era l’uomo con la pancia lo scrittore. Ma non era lui, del resto non sapeva cosa scrivere, le panchine erano già di Beppe, le lune e i giganti di Cavazzoni, le amebe di Sartori, i giornalisti portoghesi di Tabucchi, l’albero e le vacche erano di Bravi, l’oceano e il ragazzo di Conte, i lupi di Pardini, il tempo di Vasta, persino il molo di Porto Maurizio era di uno, e scrivere il mare no, da casa sua non si vedeva. No, non era mica lui lo scrittore. Illusioni di biografia di una pancia, ma non lo scrisse.
Non era lo scrittore. Scrivere di donne messe alla pecora, o di cose del mondo, ma aveva troppi bei ricordi, e anche un po’ tristi, di quando era bambino, per mettersi lì a scrivere e non pensare ai ricordi, perché in fondo era felice se pensava alla sua vita, ricordava che la mamma a volte gli chiedeva se aveva la malinconia, e questa cosa, stranamente allora lo teneva lì, incollato a quella finestra a guardare fuori, e ora non sapeva perché ma questa cosa di stare alla finestra anche ora e di guardare la Sint Bavo non gli spiaceva.
Corsica Ferry
(…) D’estate lavoravo sul Corsica Ferry, il traghetto che porta i turisti da Genova in Corsica. Facevo il mozzo. Lavavo i piatti dei marinai, e il mattino e la sera, quando si sbarcava a Genova o si salpava da Bastia, aiutavo alla manovra girando il verricello.
A Bastia si arrivava verso il tramonto e io terminavo i lavori in fretta per uscire a fare un giro. Non mi era concesso di conoscere la città, la nave ripartiva mezz’ora dopo e mi avrebbe lasciato a terra. Riuscivo a malapena a passare il cancello e fare quattro passi fino a una piazzetta con una scala che conduceva a una chiesa, poi rientravo. Ma una sera, malgrado avessi preso ogni precauzione, tornai e la nave non c’era più. Chiesi informazioni ai doganieri e ai legionari che piantonavano l’ingresso al porto (a volte qualche soldato fuggito dalla Legione Straniera tentava di imbarcarsi sul Ferry). Dissero che era risalpata pochi minuti prima, e se salivo sullo spartivento la vedevo. Non ci potevo credere. Com’era possibile che il tempo fosse volato in quel modo? E la paura, che per tanto tempo mi aveva lasciato quietare, la paura di quell’orizzonte nudo con la sola sagoma del traghetto in lontananza mi assalì. Mi fu chiaro che era esattamente come sostenevano i dottori: c’era un tempo che non mi apparteneva, e se vivevo in quel tempo non avevo paura, anche se del vero tempo perdevo il controllo. Per questo avevo perso la nave. In effetti, quell’impressione, da bambino, di aver vissuto ogni tanto accanto al bambino impaurito, e in quel mentre non avere paura, la ricordavo bene. Mi era successo sugli ulivi, in collegio, ovunque, il tempo si fermava qualche istante e quando lo riprendevo mi scoprivo in ritardo per le cose della vita, entrare in classe, raggiungere un posto. Avevo dunque perso l’imbarco perché ero stato l’altro? Trascorsi la notte «corsa» a ragionare. Senza paura si vive mezzi contenti, scoprivo, ma ogni tanto appunto si perde la coscienza, avviene la frammentazione: saltano sequenze, si perde una nave. E ora come stai? A parte la sopraggiunta paura – mi trovavo su un’isola da solo, senza soldi, in maglietta, di notte ormai –, non stavo male, e il luogo era abbastanza piacevole. C’erano luci e musiche, lampadine colorate e pezzi di firmamento, piazze e scalinate, portici e musica, gente allegra, c’era l’avventura. La Corsica era questo. Le stradine in salita assomigliavano a quelle genovesi. Camminavo e continuavo a ragionare. La paura è la penisola di un’isola. E quando fui stanco di camminare cercai una panchina, ne trovai una in una piazzetta, e mi sedetti a guardare i giocatori di bocce nel campetto sotto i platani. Poi i giocatori raccolsero le bocce, le pulirono con lo straccetto e se ne andarono. Passandomi davanti mi dissero bonnenuit, jeune homme. Io risposi bonnenuit messieurs, e ricordai quando a Saint Maxime avevo imparato a nuotare. Dopo un po’ mi venne freddo e fame, e ripresi a passeggiare. Mi dissetavo alle fontane, guardavo le vetrine dei ristoranti che chiudevano e tornavo a sedermi su una panchina. Quando uscii dalla città albeggiava, rubai delle pesche in un orto, le mangiai senza lavarle, mi coricai in un prato, rannicchiato, e quando mi svegliai mi scaldava il sole. Entrai in un supermercato, ciondolante per la fame, misi un croissant nel cestino, ogni tanto ne strappavo un pezzo e lo divoravo infilandomi tra la gente, masticavo di nascosto un pomodoro, e dopo il croissant e il pomodoro divorai in pochi morsi una tometta di formaggio di pecorino corso. Mi chinavo per prendere delle cose basse, e via una dentata al pecorino corso, carta e tutto. Davo la colpa all’altro, quello che si assentava e non aveva paura, quello che aveva perso la nave. Rimisi le cose al loro posto, alla cassiera dissi che non compravo nulla. Poco distante c’era il mare, feci il bagno, mi sdraiai al sole e quando mi rivenne fame tornai a nutrirmi al supermercato, ma stavolta mi beccarono e mi sbatterono fuori. La sera, a capo chino, entrai nel porto e trovai il Corsica Ferry ormeggiato al suo posto. I marinai se la ridevano, dandosi di gomito. Il comandante mi fece chiamare sul ponte di comando e disse che mi sbarcavano, erano le regole della Marina, l’indomani mattina sarei passato all’agenzia marittima a Genova, in via XX settembre, dov’era la sede, a ritirare lo stipendio. La notte, seduto sulla sdraio a poppa, tra i turisti (un marinaio mi aveva portato la cena e una coperta), guardai le stelle e ascoltai a lungo il dondolio della nave. Lassù, chissà dove, dissi, vive l’altro che ogni tanto ti tira brutti scherzi.



