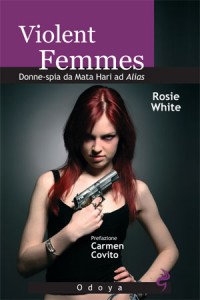di Franco Pezzini
In un bel volume uscito nel 2008 per i tipo Odoya, “Violent Femmes. Donne-spia da Mata Hari ad ‘Alias”’, la studiosa britannica Rosie White, Senior Lecturer alla Northumbria University di Newcastle, raccoglie dalla storia, ma soprattutto da narrativa e schermi, una ricca carrellata di figure femminili nel segno del segreto e (appunto) della violenza. Una violenza che però non si consuma nella dimensione emotiva o sensuale delle vecchie vamp squilibrate e squilibranti, ma accede a interessi razionali: non necessariamente condivisibili, certo, ma provocatoriamente non diversi da quelli perseguiti – sempre secondo stereotipi – dalla sezione maschile dell’umanità.
In effetti la qualifica professionale più corretta per una simile, variegata costellazione di personaggi è quella di agenti segrete: e il quadro della citata violenza è molto vario, abbracciando un arco ideale tra gli amabili cazzotti di Emma Peel e le pallottole della tormentata Nikita.
Le saghe di queste “donne violente” investono e mettono in crisi non solo le raffigurazioni convenzionali del rapporto tra i sessi, ma quello con la società e le istituzioni, esplorate nei loro giochi d’interessi e nei più imbarazzanti dietro-le-quinte: e conquistandosi ruolo di protagonista, sia pure all’interno di organizzazioni in gran parte maschili, “la figura della donna-spia mette a nudo una serie di contraddizioni che […] sono lo specchio delle contraddizioni in atto nel mondo reale” – come sintetizza Carmen Covito nell’introduzione.
La storia di questo peculiare (e niente affatto ingenuo) punto di osservazione corre da Mata Hari, figura archetipica di spia/donna fatale, attraverso un secolo di convulsioni dei modelli sessuali, sociali, politici: basti pensare al forte stacco tra l’ottimismo delle saghe di agenti segrete degli anni Sessanta e il clima ben diverso della cultura del sospetto postmoderna. Qualcosa insomma che appare emblematico di una continua, vertiginosa ridefinizione di modelli dell’immaginario in stretto rapporto con scelte, fedi e scetticismi dell’uomo della strada.
“Sebbene spie e spionaggio esistano sin dai tempi biblici, i resoconti popolari che hanno per protagonista l’agente segreto sono legati a un’inquietudine tipica del Ventesimo secolo intorno al tema dell’identità nazionale e personale” – così Rosie White, che àncora il preambolo del suo volume al fronte dell’identità sessuale delle spie maschili nella letteratura popolare inglese all’inizio del Novecento, prima fra tutti la Primula Rossa della Baronessa Orczy. Ma, appunto, agenti e spie esistono sin dai tempi biblici, se vogliamo usare questa espressione: e la storia pregressa delle violent femmes è assai più ricca di provocazioni di quanto spesso si pensi. Una galleria che senza forzature occorre far partire dall’alba della storia, visto che fin da età assai remote un’attività di intelligence – nei fatti o nella finzione narrativa – ha coinvolto a pieno titolo anche donne.
Se la rozza maschera della mulier chiacchierona, incapace di tenere il segreto, è da sempre un topos patriarcale, anche il carattere in apparenza opposto di attrice per natura teorizzato per esempio nell’Ottocento (intriganti le considerazioni di Bram Dijkstra nel classico Idoli di perversità. La donna nell’immaginario artistico filosofico letterario e scientifico tra Otto e Novecento, Garzanti 1988) ha in realtà origini antichissime: che la donna finga, inganni, illuda seguendo una peculiare e innata propensione del proprio sesso rappresenta un altro diffuso luogo comune, neppure scalfito dall’ipotesi che possa (semmai) trattarsi di possibili strategie di resistenza in contesti storico-sociali che non concedono alternative.
D’altra parte quelle stesse caratteristiche – finzione, inganno, illusione – giocate da figure maschili possono assurgere a qualità ammirate: e non è un caso che agli albori dell’intelligence in Occidente brilli la figura del mentitore Odisseo, che non solo dirige operazioni “coperte” o vi partecipa in prima persona, ma attorno a sé coagula una schiera di colleghi/trickster come l’arciladro Autolico (suo nonno), l’astuto Sisifo (attribuitogli da qualcuno per vero padre, invece del povero Laerte), l’ingegnoso Palamede (poi dal Nostro accusato falsamente di doppiogioco coi Troiani e giustiziato) e l’infiltrato Sinone. Non ci stupiamo allora, quando Odisseo penetra travestito in Troia durante l’assedio come un moderno James Bond, che finisca a confrontarsi con una donna essa pure ritratto dei più sfuggenti doppigiochi. A ricordare: “[…] l’ignorarono / tutti; io sola lo riconobbi, anche così conciato” è infatti la fulgente Elena, quando nell’Odissea Telemaco giunge alla corte di Lacedemone per recuperare notizie del padre.
La regina incalza: “e l’interrogai molte volte: e con astuzia eludeva. / Ma quando io lo lavavo e l’ungevo con l’olio, [dove le pratiche dell’ospitalità sconfinano nel brivido erotico del contesto noir] / e vesti gli posi addosso e giurai gran giuramento, / che non avrei scoperto ai Troiani Odisseo / prima che fosse tornato all’agili navi e alle tende, / allora tutto il piano degli Achei mi narrò” (Odissea, 4, 249-256, trad. Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi 1989). O almeno la parte del piano che in quel momento il prudentissimo re di Itaca poteva esporsi a spifferare a un’interlocutrice, giuramenti o meno, di relativa affidabilità. Calate le carte, fu in quella situazione che (secondo altre fonti) Elena gli avrebbe svelato quale copia del Palladio fosse autentica, permettendo una seconda incursione entro le mura con Diomede allo scopo di rubarla – onde indebolire magicamente Troia e, diremmo noi, fiaccarne il morale. Ma in quel dialogo insperato con l’agente degli Alleati Elena riuscì a contrattare anche la propria incolumità per il giorno della caduta della città? In ogni caso la donna che parla a Telemaco è ormai reintegrata da anni al posto di moglie, madre e sovrana, lasciandosi alle spalle sogni e scandali: ed è forse naturale che nel racconto enfatizzi il proprio appoggio all’agente greco, e la fiducia riposta in lei da un uomo saggio come Odisseo.
Per continuare: “Poi, dopo ch’ebbe ucciso molti dei Teucri col bronzo affilato, / tornò fra gli Argivi e molte notizie portò. / Allora le Troiane acuto singhiozzavano; invece il mio cuore / godeva, perché l’animo s’era già volto a tornare / indietro, in patria, e piangevo la colpa che Afrodite mi spinse / a commettere, quando dalla mia patria mi condusse laggiù, / la figlia mia abbandonando e il talamo e l’uomo / a nessuno inferiore per bellezza o per senno”. Cioè quel (non proprio travolgente) Menelao che le sta davanti, e lei ritiene prudente blandire: con una prova di eloquenza dai toni di spiacevole cinismo – il cenno al pianto delle Troiane – ma che rammenta per mielosa abilità la parlantina dello stesso Odisseo.
Si noti che qui Elena non menziona un paio di successivi episodi, nel segno del più funambolico doppiogioco, che mostrerebbero anche meglio alcune sue peculiari capacità. Anzitutto a favore dei Troiani quando, sotto il cavallo di legno che conteneva tra le costole i migliori guerrieri achei, avrebbe preso a imitare diabolicamente le voci delle loro mogli: col risultato di farli andare in crisi, costringendo addirittura Odisseo a ucciderne uno che aveva perso il controllo. Con un vertiginoso voltafaccia, sarebbe stata però sempre lei che, nella Troia in festa per la creduta partenza dei Greci, aveva trovato modo di segnalare con un fuoco dall’alto il via libera alla flotta appostata presso Tenedo. Episodi che nella loro contraddittorietà – esemplare è in tal senso l’Elena di Virgilio – la dicono lunga sulla complessità del personaggio.
È evidente che la maschera della donna alla deriva dei sensi (il potere di Afrodite che trascina alla colpa) non esaurisce Elena nel profilo di una vamp più trascinante di altre. Dimentichiamo la biondina belloccia di Troy: se proprio vogliamo offrire volto d’attrice a una delle espressioni in assoluto più emblematiche delle contraddizioni sessuali di una cultura patriarcale – che trattiene come le ombre di un mondo diverso, di dee e potestà femminili di spiazzante fulgore – meglio ricordare allora l’enigmatica Scilla Gabel dell’ottima Odissea televisiva di Franco Rossi, 1968, col trucco similegizio quasi memore della storia che vorrebbe la vera Elena custodita sul Nilo, mentre Achei e Troiani si accoppano per un fantasma. E registrare il commento di Barry Strauss, che nello studio La guerra di Troia, Laterza 2007, avvicina Paride ed Elena a Juan ed Evita Perón, permette di cogliere ulteriori sfumature del ritratto.
In effetti la figura della donna più bella del mondo è troppo complessa perché si pretenda di ricondurla a una cifra unitaria, e la psicologia del personaggio (peraltro cangiante, per più versi inafferrabile) muove da convulse riletture e razionalizzazioni di un contesto mitico arcaico, poi indefinitamente rievocato. L’eventuale profilo di ingrata doppiogiochista resta così circonfuso di ambiguità: e ogni versione reca in fondo un’Elena diversa, trattenendo mistero e contraddizioni in un provocatorio gioco d’ombre. Tuttavia in quella donna che sotto il cavallo, con mossa d’attrice consumata, simula voci di amiche e conoscenti udite tanti anni prima, o che invece sulla rocca di Troia segnala con archi di fiamma nella notte il via libera agli Achei, giocando il tutto per tutto di una partita che coinvolge vita propria e assetti politici, militari ed economici in un momento di collasso epocale, è in fondo lecito ravvisare almeno qualche rapporto con le violent femmes in discorso. E forse vedere proprio Elena col suo gioco di finzioni, inganni e illusioni quale archetipo femminile della categoria, in coppia con lo smaliziato collega Odisseo.
Se la maschera di colei che tradisce le porte è insomma congrua a un’immagine di intelligence come area del disinvolto doppio gioco, del tradimento dalle insondabili motivazioni, e che guarda a una realtà complessa di interessi e ragioni, Elena non è però certo l’unica a vantare una simile licenza. Nella storia arcaica di Roma, la figura di Tarpea (o Tarpeia) che apre le porte ai Sabini non è meno sfuggente: il desiderio avido di ciò che i ricchi nemici tengono al braccio sinistro, le armille d’oro per i quali la ragazza mercanteggia il tradimento, resta un’accusa colorita dell’improbabilità di certe oniriche motivazioni di fiaba. E come nelle fiabe Tarpea viene punita – schiacciata da qualcos’altro che i nemici tengono appunto al braccio sinistro, cioè i pesantissimi scudi. Se in generale nell’episodio si è individuata una filigrana mitica indoeuropea – una guerra di fondazione, conflitto simbolico originario tra i Romani espressioni delle prime due funzioni, religiosa e militare, e i Sabini della terza produttrice di ricchezza, in vista di una conciliazione alla base della Storia – anche il dettaglio di Tarpea è a ben vedere frutto di una razionalizzazione storicistica. Da un lato il personaggio può rispondere a un ruolo “critico” del plot indoeuropeo (nell’omologo conflitto tra Æsir e Vanir della mitologia norrena, Dumézil giudica corrisponderle l’enigmatica figura della maga Gullveig, su cui gli Æsir si accaniscono invano), ma dall’altro affonda radici in un culto ancestrale del Campidoglio. In accordo con la forma più arcaica della leggenda su una Tarpea vergine guerriera, il nome – di origine, pare, non latina ma sabina – doveva suonare *tarqueia, da tarqu-, “vincere” : la figura raffigurata nelle monete, che emerge a braccia sollevata da una catasta di scudi, e ancor prima la statua-trofeo che doveva spuntare da un cumulo di armi strappate al nemico, effigiava la dea tutelare del Mons Tarpeius (“monte della vittoria”), una delle due cime del Campidoglio. Era insomma questa sorta di Palladio la vergine che sorge dalla battaglia, la guerriera eponima del primissimo mito col suo tumulo di scudi: anzi forse tali spolie dei nemici coprivano la sede della Dea ancor prima della costruzione del tempio di Giove Capitolino – anche se di ciò nulla resta nell’età dei cronisti.
Non sappiamo se l’uso di precipitare dal precipizio meridionale del colle i rei di tradimento e altre gravi colpe contro la comunità (fino al I secolo d.C.) si colleghi a qualche arcaica forma sacrificale: ma anche nel caso di Tarpea indagare sul profilo di un personaggio che resta mitico significa indagare sui motivi simbolici e ideologici – compresi stereotipi e nervi scoperti – alla base di una o dell’altra riscrittura. Anche qui infatti le versioni si sprecano: se nella principale, di Tito Livio, Tarpea è la figlia di Spurio Tarpeio comandante della cittadella, una variante di tale Antigono, criticata da Plutarco, la vorrebbe figlia dello stesso re sabino Tito Tazio, rapita da Romolo e dunque in cerca di rivalsa: il che sembra cambiare parecchio il significato del “tradimento”, per quanto egualmente sanzionato dai congiunti sabini (per mostrare comunque, si immagina, un exemplum di rigore contro chi svende le porte della città).
In una terza versione, di Calpurnio Pisone e documentata da Dionigi di Alicarnasso, si tratterebbe invece di un piano per ingannare il nemico – il che addirittura capovolge il senso tradizionale del racconto, mutando la traditrice in improvvisata agente segreta di Roma intenzionata a privare i Sabini degli scudi (avrebbe chiesto direttamente quelli), e ahimè tradita dal messo inviato a Romolo. Si è osservato che una simile versione in chiave di revisionismo buonista appare piuttosto forzata; nondimeno Dionigi la preferisce perché il monumento funebre alla ragazza sul colle più sacro della città e le libazioni annue in suo onore gli parrebbero inconciliabili con la memoria di una traditrice. Visto che probabilmente si tratta di un’antica dea, il motivo ovviamente perde forza. D’altra parte il noto uso di precipitare proprio di lì traditori e criminali poteva militare a favore della lettura colpevolista, che semplificava le cose anche da un punto di vista ideologico: se la razionalizzazione romana storicizza il mito, spiegare una disfatta militare attraverso una traditrice aggiusta il quadro assai meglio della penosa storia di un’agente sfortunata (o pasticciona). Ma la suggestione resta.
Si diceva che il movente dell’avidità di Tarpea reca un forte sapore da fiaba: del resto nella filigrana del racconto i Sabini rappresenterebbero funzionalmente i portatori della ricchezza, ed è coerente con lo sviluppo simbolico e di exemplum (in negativo) mostrare almeno una figura che da questa ricchezza resti abbacinata fino al tradimento. Poi certo, le storie di true crime evidenziano come spesso i veri moventi e strategie criminali suonino assurdi, antieconomici e comunque improponibili per un narratore con pretese di “credibilità”: il che può suggerire cautela nel tranciare giudizi sui racconti tradizionali. Ma le fonti recano un altro possibile movente: invece che per desiderio di oro, Tarpea potrebbe aver tradito per una diversa forma di concupiscenza – non meno legata alla funzione di ricchezza/fertilità. Parliamo dell’attrazione fisica.
A colpire Tarpea con la sua avvenenza sarebbe stato il capo Sabino Tito Tazio, di cui – sostiene romanticamente Properzio – la Vestale Tarpeia si sarebbe invaghita di un amore doppiamente proibito; ma in un’ennesima variante, ancora documentata (con scetticismo) da Plutarco sulla base del racconto del poeta Similo, il fatale innamoramento di Tarpea non avrebbe riguardato il re e l’assedio dei Sabini, bensì il capo dei Celti Boi e una diversa vicenda bellica – alla luce di una tradizione letteraria ellenistica molto più interessata ai Galli che non ad arcaici popoli italici quali i Sabini. Dalla versione “gallica” di Similo deriva a sua volta probabilmente la storia pseudoplutarchea (pare farlocca) di una pseudo-Tarpea dell’Asia Minore, tale Demonice di Efeso, che avrebbe tradito la propria città consegnandola ai Galli dell’ennesimo Brenno per desiderio dei loro preziosi ornamenti.
Non occorre entrare in questa sede in letture molto analitiche che pure aprirebbero intriganti percorsi (come sul ruolo in Livio delle donne legate alle origini di Roma, che per vari motivi si aprono a clan diversi dal proprio – in direzione insomma orizzontale invece che verticale/patriarcale – per incorporare stranieri nel popolo romano). Basti invece considerare come anche stavolta una figura miticamente equivoca e con funzione narrativa di doppiogiochista e magari agente segreta finisca col rappresentare un efficace specchio degli imbarazzi comunitari – il rapporto con lo “straniero” (tanto più se indissolubilmente legato alla nostra storia), con l’idea di sconfitta, con le origini stesse di un’epopea costituzionale.
Se poi la lettura erotica del tradimento di Tarpea sembra di origine ellenistica (il responsabile potrebbe essere proprio Similo) e dunque il movente più antico pare quello della cupidigia, è però vero che la prima definirà un topos. Ancora Paolo Diacono, parecchi secoli dopo, lo ripropone per un’altra traditrice/apritrice di porte, Romilda, moglie del duca del Friuli Gisulfo (Historia Langobardorum, IV, 37). Assediata in Cividale dagli Avari che le hanno ucciso il marito (circa 610), la duchessa scorgerebbe dall’alto delle mura l’aitante e giovane capo nemico che passa in rassegna le truppe. A quel punto “meretrix nefaria concupivit” e gli manda un messaggino in cui, in sostanza, propone uno scambio: lui la sposa, e lei gli lascia in balia la città con tutti gli abitanti. Le conseguenze per Cividale saranno spaventose, ma a sua volta la dark lady pagherà cara l’idea: dopo una notte allegra con il giovane re finirà violentata da dodici Avari e poi impalata, con il compiaciuto commento “Talem te dignum est maritum habere”. Sia o meno vero il fatto, il racconto riecheggia in chiave di topos antifemminile le antiche storie citate. Certo, la Tarpea che per amore o lascivia tradisce Roma, e la Romilda che per lussuria (o paura?) tradisce Cividale si apparentano più alle femme fatale travolte dai sensi che alle agenti segrete di cui in discorso: ma i motivi del segreto, del tradimento comunitario, del doppiogioco e della simulazione collocano le loro storie in un bacino almeno contiguo.
Per trovare però un’agente segreta in senso più proprio – rapporto con un’organizzazione, periodici rendiconti, altalena iniziale di frustrazioni e poi successo – dobbiamo tornare, come ricordava opportunamente Rosie White, verso i tempi biblici: e fare insomma la conoscenza dell’agente filistea nome in codice Dalila.
(Continua.)