Lottare contro il probabile, sperimentare l’inverosimile, mettere alla prova la realtà
(Appunti su Lost, il NIE e la Crisi)
“Rovistando tra i futuri più probabili
voglio solo futuri inverosimili.”
– Le Luci della Centrale Elettrica, Lacrimogeni
“E adesso quella parola, la più incredibile.
Sciopero.
Da qualche tempo stava succedendo qualcosa. Un disciplinato subbuglio attraversava i college, animato dai reduci. Era come se la soglia dell’attenzione collettiva si fosse d’improvviso innalzata a una vetta prima sconosciuta. Si iniziava a discutere di ogni cosa, anche i piccoli dettagli della vita comune.”
– Wu Ming 4, Stella del Mattino
“Una operazione di diagnosi in relazione alle trasformazioni, ai modi del divenire, non pensa all’identificazione di possibili, ma in primo luogo a una lotta contro le probabilità, una lotta i cui attori devono definire se stessi contro queste probabilità. Si tratta della creazione di parole che avranno solo il senso di provocare la loro reinvenzione; parole la cui più alta ambizione è di diventare ingredienti di storie che, senza di esse, sarebbero forse state un po’ diverse.”
– Isabelle Stengers, Cosmopolitiche
1. JACOB BIFRONTE
Qualche mese fa ero sul divano e mi stavo godendo una puntata di Lost [1]. La dovrò raccontare almeno un po’, quindi occhio allo spoiler. Per farla breve, Benjamin Linus e John Locke erano al villaggio degli ‘altri’, e stavano come sempre facendo discorsi di fondamentale importanza, quando all’improvviso un commando di mercenari irrompe nella scena per catturare Benjamin. Lo scontro ha esiti tragici, ma alla fine il gruppo riesce a scamparla. Ben dice agli altri fuggitivi che occorre assolutamente andare da Jacob. Jacob? chiede Sawyer stizzito. Jacob è l’uomo che ci dirà cosa faremo, risponde Ben (“what to do next”).
Nella mitologia di Lost, Jacob è una sorta di misteriosa divinità che governa le sorti dell’Isola e che ogni tanto si manifesta. Come mai – pensavo – tra tutto quel pandemonio di Lost gli autori ci hanno pure infilato questo Jacob che dice ai personaggi che cosa devono fare? Al che uno strano cortocircuito mi ha condotto su wikipedia alla pagina di uno dei creatori della serie, il celebre J.J. Abrams. La lettura del suo nome per esteso mi ha fatto un po’ trasalire:
Il Jacob autore della fiction ha lo stesso nome del Jacob divinità nel racconto.
Chiariamoci, non è che voglio stare qui a dare la breaking news della soluzione di Lost. Questa non è né una spiegazione né una novità, tant’è che scorrendo il web l’omonimia era  segnalata en passant alla voce “curiosità” su Lostpedia. Quello che dico lo dico prima di tutto da appassionato (da fan!): l’accoppiata Jacob-Jacob mi serve qui non come teoria cinica e distaccata ma come personale chiave di lettura per apprezzare ancora di più le vicende degli isolani, e per comprendere altre cose che mi accadono intorno e reclamano attenzione. Il New Italian Epic, per esempio, e questi tempi oscuri.
segnalata en passant alla voce “curiosità” su Lostpedia. Quello che dico lo dico prima di tutto da appassionato (da fan!): l’accoppiata Jacob-Jacob mi serve qui non come teoria cinica e distaccata ma come personale chiave di lettura per apprezzare ancora di più le vicende degli isolani, e per comprendere altre cose che mi accadono intorno e reclamano attenzione. Il New Italian Epic, per esempio, e questi tempi oscuri.
In questa versione pirandelliana e direi umoristica [2] della serie – dove i personaggi che vanno dal dio Jacob andrebbero in cerca dell’autore-creatore — convergono a mio parere tre ingredienti narrativi in una miscela esplosiva: il primo – quasi un classico ormai – che gioca sui paradossi e porta avanti un discorso sperimentato o teorizzato da (oltre a Pirandello, e saltando di palo in frasca) Einstein, Gödel, Whitehead, Escher, Pynchon, PKD, Deleuze & Guattari, David Lynch e ci metto anche gli spassosissimi allestimenti radiofonici dell’ucronico Istituto Barlumen; il secondo che lavora sulla memoria e ammicca all’esperienza del lettore; infine il terzo che dispiega al massimo il potenziale abilitante del pop e lo mette direttamente in forma di racconto.
Cerco di spiegarmi meglio. Prima di tutto Lost mette in campo una serie di paradossi spaziotemporali: all’inizio uno pensa che c’è una storia da ricostruire in base ai flashback, poi si ritrova gettato nel futuro con i flashforward, e alla fine capisce che non ci sono né flashback né flashforward, perché è l’isola che fa il tempo (e il testo) narra le vicende, e proietta da sé cose che poi chiamiamo passato presente e futuro. In secondo luogo, le vicende narrate connettono il vissuto dei personaggi a quello del pubblico sulla base di piccole fuoriuscite letterarie e di design legate al pop (i riferimenti a King, PKD, Steinbeck, Petula Clark, Mama Cass, il Dharma, il videotape, lo stile eighties…). Infine — e qui viene il turno del pop come sistema abilitante — la narrazione tracima alla grande dall’involucro televisivo e viene messa in scena la tensione sempre presente tra sceneggiatori e pubblico. In questo processo lo Jacob bifronte agisce da soglia narrativa facendo incontrare e scontrare da un lato le pratiche di fabbricazione di una serie tv (soggetto, sceneggiatura, montaggio, regia, produzione, distribuzione ecc.) e dall’altro le pratiche di fruizione e di bricolage narrativo (le fandom, i blog, il peer to peer, le accanite conversazioni post-episodio e così via)[3]. I tre livelli sono incastonati con l’uno nell’altro in un impianto efficacissimo e dal ritmo travolgente: le vicende sono fatte per essere raccontate e raccontano di come sono fatte (l’accoppiata Jacob-Jacob), evocano immaginari comuni (attraverso i rimandi alla memoria e all’esperienza ), ne fanno immaginare di nuovi (la tensione sceneggiatori-produzione-fandom-blog ecc.). E’ come se l’analisi semiotica di un testo venisse raccontata dalle gesta dei personaggi, e questi personaggi comprendessero anche sceneggiatori e pubblico senza soluzione di continuità: pratiche di produzione testuale, racconto, e pratiche di fruizione coesistono nello stesso mondo narrato.
2. AFFINITÀ E DIVERGENZE TRA LOST E NIE
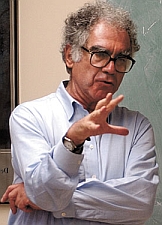 Trovo in Lost diversi punti di contatto con il NIE, rilanciati e approfonditi nel caso specifico dal bell’articolo di Daniele Marotta,
Trovo in Lost diversi punti di contatto con il NIE, rilanciati e approfonditi nel caso specifico dal bell’articolo di Daniele Marotta,  “Rock the Borbons”: il what if, la transmedialità, la chiamata in causa del pubblico. Nell’ottica “Jacob bifronte” questi elementi si fondono insieme, c’è la messa in racconto di tutto il discorso dell’officina letteraria: la costruzione del rapporto tra la vita e l’esperienza di chi scrive e quelle di chi legge, la manifattura del romanzo che accompagna la costruzione di una poetica. L’aggancio a Lost mi permette però di sviluppare un ulteriore tema, apparentemente slegato – ma non troppo – dai precedenti, e che mi sembra connettere la poetica del NIE (e in particolare degli UNO) ad altre opere, italiane e non [4]. Le chiamo “storie di sopravvissuti”.
“Rock the Borbons”: il what if, la transmedialità, la chiamata in causa del pubblico. Nell’ottica “Jacob bifronte” questi elementi si fondono insieme, c’è la messa in racconto di tutto il discorso dell’officina letteraria: la costruzione del rapporto tra la vita e l’esperienza di chi scrive e quelle di chi legge, la manifattura del romanzo che accompagna la costruzione di una poetica. L’aggancio a Lost mi permette però di sviluppare un ulteriore tema, apparentemente slegato – ma non troppo – dai precedenti, e che mi sembra connettere la poetica del NIE (e in particolare degli UNO) ad altre opere, italiane e non [4]. Le chiamo “storie di sopravvissuti”.
In un magnifico saggio intitolato Unus testis (‘unico testimone’, “Just one witness” nella versione inglese) Carlo Ginzburg [5] torna sul difficile rapporto tra prova, finzione, verità, storia. Ginzburg prende le mosse proprio da quei resoconti storici che ricostruiscono gli eventi in base ad una sola testimonianza. Come è possibile, si interroga l’autore, risalire all’esistenza di un fatto storico affidandosi all’unico testimone in grado di renderne conto, e che si rivela appunto inconfutabile? La figura del sopravvissuto diviene così il punto di massima convergenza e instabilità tra verità e finzione, storia e romanzo, tanto da mettere in crisi simultaneamente “positivismo (ossia una “ricerca storica positiva” basata sulla decifrazione letterale dei documenti,) e relativismo (ossia “narrazioni storiche ” basate interpretazioni figurali, inconfrontabili e inconfutabili). Le narrazioni basate su un’unica testimonianza […] possono essere considerate come casi sperimentali che confutano l’esistenza di una distinzione così netta: una lettura diversa della documentazione disponibile influisce immediatamente sulla narrazione”.
Le storie dei testimoni unici, afferma lo studioso, sono dunque casi sperimentali. Casi in cui bisogna sporcarsi le mani e capire se cose inverosimili siano realmente accadute, se ciò che è terribilmente vero sia stato fatto passare per inventato, o se costituisca mera finzione. E’ in questo senso, conclude Ginzburg citando Benveniste, che il testimone è superstes: sopravvissuto. Scrive Benveniste:
Poiché superstes stesso non significa solo ‘superstite’ ma in certi casi ben attestati ‘testimone’. (così superstare vuol dire ‘tenersi al di là, sussistere al di là’, di fatto al di là di un evento che ha distrutto il resto […] I superstites hanno resistito al di là dell’avvenimento; colui che ha superato un pericolo, una prova, un periodo difficile, che è sopravvissuto, è superstes. […] O ancora ‘che si tiene sulla (stat super) cosa stessa, che vi assiste, che è presente’. Non è il solo uso di superstes; “sussistere al di là di…” non vuol dire solo “essere sopravvissuto a una disgrazia, alla morte”, ma anche “aver attraversato un evento qualsiasi e sussistere al di là di questo evento”, quindi essere stati “testimoni”. E’ chiara la differenza tra superstes e testis. Etimologicamente testis è colui che assiste come terza parte (*terstis) a un affare in cui sono interessati due personaggi. […] Ma superstes descrive il ‘testimone’, sia come colui che ‘sussiste al di là’, testimone e nello stesso tempo sopravvissuto, sia come ‘colui che sta sulla cosa’, che vi è presente. […] Superstitio è il dono della seconda vista che permette di conoscere il passato come se fossimo stati presenti, superstes. Ecco perché superstitiosus enuncia la proprietà della doppia vista che si attribuisce ai veggenti, quella di essere testimoni di eventi ai quali non hanno assistito [6].
Lost inizia con l’occhio di Jack che si apre sul disastro del volo Oceanic 815. Occhio che attraversa la catastrofe, sopravvive, assiste a sangue, urla, disperazione. Si ravvede, agisce, va in soccorso agli altri sopravvissuti. Manituana esordisce con un Grand Diable bambino strappato da Molly alla morte, la stessa donna che poi traghetta quel che resta degli indiani oltre il lago (il popolo indiano è esso stesso un sopravvissuto); nel prologo di Romanzo Criminale, un non precisato superstite della Banda della Magliana punta una pistola contro alcuni teppistelli di Campo de’ Fiori, urlandogli contro: “Io stavo col Libanese!”. E poi: Lo *** di Confine di Stato, scampato ad un ospedale psichiatrico pre legge Basaglia; l’uomo e il bambino de La Strada che camminano in un paesaggio post-apocalittico; il Fu Mattia Pascal (ancora Pirandello!), sopravvissuto per errore alla morte di un altro spacciato per se stesso [7]; il multiforme protagonista di Q, che sopravvive ogni volta con un nuovo nome; Ned che sopravvive come può a “Urens” in Stella del Mattino, insieme a chi si porta dietro gli spettri della prima guerra mondiale. Babsi Jones e Roberto Saviano, ambedue che sopravvivono al proprio racconto, e grazie al proprio racconto. Vitaliano Ravagli in Asce di Guerra. E Primo Levi, al quale Ginzburg dedica il suo saggio.
Figura radicale — declinazione dell’alterità simile a quella di straniero, dissidente, idiota, accattone, prostituta — il sopravvissuto si porta addosso l’indicibile e si presta al contempo come occasione per parlarne: offre il terreno del suo corpo e della sua memoria per sperimentare se l’inverosimile si sia avverato, e raccontare versioni differenti della storia. Fino a che punto? Il sopravvissuto pone dei problemi delicati: le vicende che racchiude possono infatti prestare il fianco ad ogni sorta di mistificazioni [8], reclamano di essere indagate e verificate con cura e con urgenza. Si tratta di verità parziali e relative, eppure necessarie in quanto permettono di risalire ad un evento oscuro che ha inghiottito la voce degli altri che non ce l’hanno fatta. Se poi l’evento fosse così eclatante da prevalere su coloro che gli sopravvivono, il problema si porrebbe all’inverso: il sopravvissuto diventerebbe nient’altro che un reduce imprigionato in un mito sclerotizzato che si celebra uguale a se stesso, e che occorre scardinare e rimodulare. L’unus testis si configura invece come leva mitopoietica, luogo di costruzione di una storia e di un epos ancora da raccontare, di una memoria da far vivere o rivivere: la sua testimonianza – che sembrerebbe oscillare paurosamente tra rivelazione e finzione – è in realtà la testimonianza modesta [9] di una storia singolare, non simbolo ma traccia da seguire.
Tutto questo per dire che il modo in cui vengono raccontate le ‘storie di sopravvissuti’ costituiscono secondo me una sorta di prova per capire come si instaura il rapporto tra scrittura, opera e lettura. Da questo punto di vista, Lost è elusivo e lascia sempre in sospeso la questione di chi sia sopravvissuto a cosa. In un mondo instabile come quello dell’Isola sembra che si possa veramente dire di tutto dei sopravvissuti e che i sopravvissuti possano raccontare qualsiasi storia. C’è una continua apertura del racconto, quasi a voler prescindere dalla sua natura seriale. La narrazione procede attraverso una sorta di ripetizione del differimento, continua disseminazione di tracce e divagazione spaziotemporale che elargisce colpi di scena all’ordine del giorno attraverso un’accumulazione progressiva di suspence [10]: quanto ancora lo sguardo del pubblico può giocare su questo trip reiterato? La storia di Lost e quella del suo pubblico andrà avanti? Sarà sostenibile? Come verrà data forma a tutti i frammenti?
Penso che l’elusività è anche la potenza di Lost, che così facendo alimenta un immaginario smisurato, una fantasmagoria la cui ricomposizione arriverà – forse – tra un paio d’anni. Insomma, c’è ancora un dolce naufragare prima della resa dei conti tra sceneggiatori, pubblico, personaggi, scene, produttori: tutte le facce dello stesso Jacob. Posso però andare a guardare come le opere che abitano il NIE affrontano le storie dei sopravvissuti e la questione delle aperture narrative. Queste narrazioni tengono sempre presente le pratiche di lettura e l’obbligo della priva, sull’esempio del romanzo storico: sono oggetti scomodi che non possono essere concepiti per bastare a se stessi, e che si affidano al lettore affinché possa prendersene cura in relazione alla propria esperienza. La poetica di Gomorra, Romanzo Criminale, Sappiano le mie Parole di Sangue, Confine di Stato incorpora studi, bibliografie, ricerche d’archivio, sentenze, documenti che legano l’efficacia narrativa alla prova dei fatti. In queste opere la sperimentazione dell’inverosimile avviene sulla base di un rigoroso lavoro di inchiesta e investigazione: qui manifattura della narrazione, storia raccontata e accadimenti storici si implicano a vicenda. C’è come un istanza pragmatica che si accompagna a quella etica: la realtà è già complessa di suo, sarebbe superfluo complicarla a dismisura o peggio negarla. La realtà — strano a dirsi! — esiste. E occorre, questo sì, darle un senso. Non uno qualsiasi. Per come l’ho intesa, quest’esigenza spinge a ricondurre paradossi, ucronie e distopie su un piano di immanenza e impegno civile: la realtà viene dissodata ‘dall’interno’[11]. In queste opere i salti spaziotemporali, sono tutt’altro che ‘fughe’, gli straniamenti non hanno nulla di esotico, le prospettive eccentriche nulla di schizoide: ognuno di questi elementi serve a guadagnare posizioni per osservare gli eventi da luci diverse e agire di conseguenza. Il lavoro di superstitio, la doppia vista che permette di essere presenti al passato e al futuro, sottende una vocazione *archeologica* del NIE: nel senso classico, e nel senso di Foucault. Ovvero, l’archeologia è sia una disciplina che investiga sulle tracce delle antiche civiltà e ne riarticola i frammenti, sia un metodo che permette di muoversi tra le pieghe degli accadimenti presenti, renderli eventuali, intervenire. In particolare:
reperire la singolarità degli avvenimenti al di fuori di ogni finalità monotona; spiarli dove meno li si aspetta e in ciò che passa per non aver storia — il sentimento, l’amore, la coscienza, gli istinti; cogliere il loro ritorno, non per tracciare la curva lenta di un’evoluzione, ma per ritrovare le diverse scene dove hanno giocato ruoli diversi; definire anche l’istante della loro assenza, il momento in cui non hanno avuto luogo. […Genealogia non sarà mai] partire alla ricerca della loro «origine», trascurando come inaccessibili rutti gli episodi della storia; sarà al contrario attardarsi sulle meticolosità e sui casi degli inizi; prestare un’attenzione scrupolosa alla loro risibile cattiveria; aspettarsi di vederli sorgere, maschere finalmente cadute, col volto dell’altro; andare a cercarli senza pudore là dove sono – «frugando i bassifondi»; lasciar loro il tempo di risalire dal labirinto dove nessuna verità li ha mai tenuti sotto la sua guardia.[12]
Il Lawrence di WM4 incarna tutti i paradossi e le possibilità di questo doppio metodo, questa superstitio che racconta la storia del presente attraverso quella passata, si fa carico di quella futura. E viceversa. La sensibilità archeologica spinge Lawrence verso luoghi lontani, lo conduce a prendere parti considerate “sbagliate”, oscure, scabrose, minoritarie, fallimentari. Ma è qui, dove non è possibile imporre una griglia interpretativa, dove la capacità di calcolo – sia essa economica o morale – non permette di fabbricare in serie oggetti e persone che confermino la sua stessa validità, qui l’impianto perde la sua consistenza necessaria, si mostra fallibile, inaccettabile, trasformabile: Attraverso il sopravvissuto Lawrence, la sperimentazione archeologica dell’inverosimile mette in discussione le verità scontate. Prende la consistenza di una lotta contro la probabilità che mette alla prova il reale opponendosi sia ad una logica dell’esistente, sia alla sterile contemplazione di possibilità infinite: fruga i bassifondi, per ritrovare le diverse scene dove hanno giocato ruoli diversi; definire anche l’istante della loro assenza, il momento in cui non hanno avuto luogo.
3. EFFETTO IKEA
Se finora Lost si è mosso con estrema eleganza tra Scilla e Cariddi, tra gli infiniti mondi possibili e la monotonia narrativa, molte altre produzioni e piattaforme si fanno prendere parecchio la mano da questo meccanismo… tant’è che qualche volta ci speculano pure. E ahimé, oh Jacob dio-creatore, dopo aver tessuto le tue lodi ora mi tocca rinnegarti!
Per l’appunto, J.J. è anche produttore di  Sei protagonista, e forse signore dell’ambiente che ti circonda, solo se ti fai macchina tu stesso, se in definitiva diventi una componente di quell’apparato. […] Il vero problema culturale e istituzionale è quello di valutare fino a che punto si è di fronte a vere discontinuità, che segnano un congedo da un altro mondo, e dove, invece, è possibile e necessario mantenere una continuità che consenta quel trascendere dell’umano di cui parlava Julian Huxley, impedendo così la nascita di un “doppio standard” nella considerazione dell’umano e del post-umano. Si manifesta la preoccupazione di chi segnala il rischio di una svalutazione dell´umano per effetto di una percezione del post-umano come portatore di un valore più forte, aprendo la via ad un conflitto, addirittura ad una “guerra”, tra umani e post-umani. Un conflitto, evidentemente, che nasce sul terreno dei valori di riferimento e che può essere evitato solo se si ha la capacità di mantenere fermi, e di proiettare nel futuro, i principi prima ricordati di dignità, eguaglianza, autonomia.
Sei protagonista, e forse signore dell’ambiente che ti circonda, solo se ti fai macchina tu stesso, se in definitiva diventi una componente di quell’apparato. […] Il vero problema culturale e istituzionale è quello di valutare fino a che punto si è di fronte a vere discontinuità, che segnano un congedo da un altro mondo, e dove, invece, è possibile e necessario mantenere una continuità che consenta quel trascendere dell’umano di cui parlava Julian Huxley, impedendo così la nascita di un “doppio standard” nella considerazione dell’umano e del post-umano. Si manifesta la preoccupazione di chi segnala il rischio di una svalutazione dell´umano per effetto di una percezione del post-umano come portatore di un valore più forte, aprendo la via ad un conflitto, addirittura ad una “guerra”, tra umani e post-umani. Un conflitto, evidentemente, che nasce sul terreno dei valori di riferimento e che può essere evitato solo se si ha la capacità di mantenere fermi, e di proiettare nel futuro, i principi prima ricordati di dignità, eguaglianza, autonomia.
Sono preoccupazioni necessarie, perché questa logica di assorbimento sta entrando in un regime di probabilità e di autorinforzo in modo alquanto esplicito. M’è venuto di chiamarlo “effetto ikea” in omaggio al legno del mio divano, che – non me ne voglia la multinazionale dell’arredo – forse avrebbe meritato di diventare qualcos’altro, o di restare quello che era. Ma non è che l’Ikea sia qui una metafora. E’ solo un altro modo di intessere racconti: design invece di cinema o letteratura. Il fatto è che la pretesa di delegare la totale responsabilità della narrazione al pubblico, sia essa cinematografica, letteraria o progettuale viene spesso spacciata per celebrazione del mito dell’utente-spettatore come artefice del proprio destino: un problema complesso ed ‘ecologico’ viene liquidato facendolo ricadere su corpi superindividualizzati. Come sopravvivere alla promessa di onnipotenza differita alla vita eterna, e testimoniarne il carattere illusorio?
Se è vero che tiriamo tutti ampie boccate dai vari oppi dei popoli che la società dei consumi ci mette a disposizione, gli stessi i fumi d’oppio si ritorcono contro gli incensatori e hanno reso più opaco il terreno di scontro. Conflitti sottili proliferano all’interno dell’industria culturale, erodono piattaforme di sfruttamento e logiche di probabilità. S’è visto che l’egemonia e i panopticon sono schiaccianti, ma solo se guardati come un tutt’uno da occhi lontani. Da vicino sono male organizzati, contano tanti buchi quanti i bug dei software di Bill Gates.
In tutto questo discorso il NIE entra per almeno due motivi. Prima di tutto perché a fronte del processo di reificazione e individualizzazione, la nebulosa risponde affermando la dimensione polifonica delle storie e la natura corale (e in questo senso eroica) dell’individuo. E poi perché da quello che sta venendo fuori mi pare chiaro che la nuova epica non riguardi solo fiction e letteratura, ma più in generale il rapporto tra ciò che si fa/si racconta e come lo si fa/come lo si racconta: nella letteratura come nell’economia, nell’organizzazione del lavoro come nei modelli di consumo, nelle scienza come nella tecnica e nella società. Può risultare strano concepire come storia ciò che è fatto di scienza e di tecnica, eppure anche lì c’è una poiesis, un fare, anche lì c’è il problema di quali storie narrare per quale pubblico, anche lì c’è una presa di posizione da decifrare, da portare avanti o da contrastare. Si tratta di riattivare l’intreccio tra materialismo narrativo e materialismo storico, tenendo presente che la via iconoclasta non comporterebbe altro che un semplice ripristino del sistema. Si tratta di usare le parole in modo simbiotico su fatti, miti e oggetti per reinventarne la natura. Perché il problema è che la storia e le storie sfuggono di mano tanto alle forze individualizzate quanto a quelle individualizzanti: cambia il modo in cui ci si riconosce come classe a fronte delle specifiche disuguaglianze nei rapporti di forza, cambiano i rapporti di forza a seconda di come incrociano il piano delle narrazioni, del lavoro, dei diritti, della finanza, delle tecnoscienze, e cambia anche il tipo di conflitto. Diventa allora centrale individuare il piano del conflitto. Anzi, si tratta proprio di fabbricarlo, situarlo, seguirlo. Come si fa con le storie.
Valerio Evangelisti coglie veramente nel segno:
Per inciso, la non-dottrina di Friedman oggi è adottata dalla Banca Centrale Europea (l’ha inclusa anche nel progetto di Costituzione e nel patto di Lisbona) e dall’Occidente nel suo assieme. Se come teoria fa acqua, i suoi risvolti politico-sociali sono netti: smontare la classe operaia — o più in generale il proletariato — quale soggetto compatto, portatore di istanze collettive. Scinderla in individui costretti a contrattare individualmente, o a piccoli gruppi, la propria sopravvivenza. Abolire i contratti di lavoro nazionali, in modo da lasciare i soggetti deboli in balia di se stessi. Illuderli con lo specchietto di una falsa autonomia, in modo che l’azienda possa, all’occorrenza, liberarsene come facevano le antiche mongolfiere, quando staccavano e gettavano nel vuoto i sacchetti di sabbia per prendere il volo. […] Si tratta di comprendere meglio la composizione attuale di classe, nel contesto dell’economia astratta. Da lì si deve ripartire, e da un quadro internazionale che offre sorprese sgradite ai monetaristi.
Amo molto quest’ultima affermazione: ripartire da soprese sgradite. Le sorprese sgradite giunte da decenni per i docili ‘consumatori/risparmiatori’, stanno presentando il conto ai monetaristi. Il fatto è che non avendo più molti soldi per frequentare supermercati, i non-morti cominciano a porsi domande improbabili, a lungo accantonate e ora quanto mai ineludibili: A cosa siamo sopravvissuti? A cosa stiamo sopravvivendo?
Sono domande che chi si imbarca in odissee terrificanti dall’Africa o dall’Asia verso l’Europa ce le ha già marchiate a fuoco nella schiena, e aspetta da tempo che la sua storia di sopravvienza sia ascoltata in modo degno. Altri invece hanno bisogno di porsele per riconoscersi addosso il marchio e la responsabilità di aver vissuto in un mondo che pretende di scaricare ‘altrove’ i rifiuti del proprio benessere, un altrove che è da sempre stato qui. La pulsione a raccontarsi come sopravvissuti di un modello economico e militare delirante inverte il rapporto figura sfondo, cambia orizzonte di lettura, diviene piano di conflitto che parte dal mito e rientra nelle condizioni materiali. Alla stregua di Edmond Dantes, risaliamo a ritroso la catastrofe: l’illusione che potevamo ritagliarci il nostro piccolo spazio e prescindere dal resto, di sistemarci nonostante tutto; il processo brutale di oggettivazione subìto, gli innumerevoli effetti ikea di cui siamo stati testimoni e reduci; la condizione quotidiana di discriminazione per il genere o per la razza, il lavoro svilente o precario, il paesaggio violento e deturpato che ci accoglie [15]. Ripensiamo chiave la nostra autobiografia ipertrofica e reificata in chiave ecologica e collettiva, usciamo dalla “nera adolescenza dei secoli” come singolarità individuali, “farfalle dal bozzolo”, “luoghi di tutti i rapporti”.
Certo, l’esperienza intera che quel giovane (che forse ero io) andava facendo, gli rivelava nella realtà non soltanto un paese ignoto, ignoti linguaggi, lavori, fatiche, dolori, miserie e costumi, non soltanto animali e magia, e problemi antichi non risolti, e una potenza contro il potere, ma l’alterità presente, la infinita contemporaneità, l’esistenza come coesistenza, l’individuo come luogo di tutti i rapporti, e un mondo immobile di chiuse possibilità infinite, la nera adolescenza dei secoli pronti ad uscire e muoversi, farfalle dal bozzolo; e l’eternità individuale di questa vicenda [16] […]
4. EPICA TASCABILE E HUMOUR DELLA VERITÀ
Una cosa come Cloverfield potrebbe andare avanti all’infinito raccontando la stessa storia, come un meccanismo sacrificale all’inverso. Ci sono dei prodigi. C’è un mostro avvolto dal mistero. Si può cedere all’illusione di chiedersi da dove venga, chi sia, cosa voglia, ma sarebbe come pendere dalle labbra dallo scienziato di turno per una spiegazione rassicurante ma fuorviante. Ciò che importa invece è che il mostro è già in terra, i prodigi si sono già manifestati, hanno distrutto le narrazioni moderne che li avevano evocati. Bisogna farci i conti. Perché come afferma Rorty [17], se è vero che non c’è più posto per le grandi narrazioni, ciò non impedisce di intessere narrazioni edificanti di prim’ordine. Narrazioni epiche, aggiungerei.
Una volta di fronte agli effetti Ikea e allo You sbandierato ai mille venti occorre tener conto di come è fatta la storia, di quello che narra, e di chi la legge. Prendere Jacob, Jacob, e Jacob Bifronte tutti e tre insieme. Guardare al dito, alla luna e a com’è fatto il cannocchiale. Le storie dei superstes che ho passato in rassegna rappresentano un terreno propizio per questo tipo operazioni, grazie alla loro natura straniante. Lo straniamento è una tecnica umoristica. Nel famoso esempio della donna anziana marcatamente truccata, Pirandello (eccolo qua, finalmente!), definisce l’umorismo come “sentimento del contrario”. L’espressione mette in scena simultaneamente il tentativo disperato di fissare una volta per tutte il divenire della vita e la natura fallimentare di questo atto. Se ridiamo in modo umoristico, lo facciamo con una punta d’amarezza, di rabbia. In altre parole, laddove l’ironia nega ciò che afferma rinviando ad un piano sterile su cui gli interlocutori si intendono in modo complice (“quell’onest’uomo del presidente!”), l’umorismo ci getta nudi di fronte al paradosso di dare un senso a qualcosa che non ce l’ha, senza nessun terreno comune a cui appellarci. Ecco, la nuova epica mi si offre come via pragmatica all’umorismo: perché come tutti i paradossi, il sentimento del contrario si risolve nella prassi, ci costringe a rincorrere il senso che stiamo costruendo, e nulla vieta, tornando a Rorty, che questo senso possa essere edificante.
Tra i passaggi che più ho amato di Manituana ci sono quelli in cui lo sguardo di Philip si sofferma con l’acume di un Voltaire d’oltreoceano sulla società del Regno Unito: Philip osservò gli invitati: difficile attribuire natura umana alla maggior parte di quegli esseri coperti di tessuti sgargianti, stretti negli abiti, in bilico sui tacchi di dieci pollici, dita invisibili sotto grappoli di anelli, teste affondate nelle spalle sotto il peso di parrucche simili ad uccelli impagliati. Erano intenti a ballare, ruminare cibo, conversare. Più avanti Le Grand Diable si incammina solitario per i sobborghi di Londra, e sono ancora i suoi occhi di straniero che raccontano le storie dei nuovi sopravvissuti: quale che fosse la condizione toccata in sorte, uomini e donne mostravano tutti lo stesso colorito cinereo, come se il cielo lattiginoso che gravava sulle teste avesse preso possesso della carne. Ognuno, mendicante o vetturino, servo o signore, sembrava perduto in un’occupazione di importanza vitale. Ma non si trattava che di prolungare a tempo indefinito l’esistenza: mangiare abbastanza per non crepare di fame, bere abbastanza per non pensare, avere addosso abbastanza stracci per non morire. […] La via brulicava di ogni genere di persone. La pancia della capitale si apriva lurida e vociante. Aria pregna di polvere di carbone, greve di feci umane e animali.
Dice WM1 nel suo memorandum: “Quell’effetto non è semplice ‘straniamento’: è lo sforzo supremo di produrre un pensiero ecocentrico. E’ simultaneamente un vedere il mondo da fuori e un vedersi da fuori come parte del mondo e del continuum”.
Un vedere e un vedersi. Una doppia vista.
Superstitio.
Sospendere per un attimo i giochi, quel che basta per vincere la perplessità. Prendere posizione e agire “con il fronte davanti agli occhi” [18]. Tener conto di tutto ciò che potrebbe andare diversamente e al contempo assumersi la responsabilità di ciò che si sceglie di esperire, disseppellire, raccontare, affrontare [19]. Sottrarsi all’angoscia delle possibilità infinite e prendersi carico del senso da attribuire alla propria individualità e alle altre connesse. Lottare contro la probabilità rigettando la selezione naturale come unica via all’evoluzione, giocare a favore di un andamento non lineare e non finalistico del divenire:
Se imparare a pensare, vuol dire imparare a resistere a un futuro che si dà come evidenza, possibile e normale, noi non possiamo farlo né evocando un avvenire astratto, dal quale sia stato spazzato via tutto ciò che si offre alla nostra condanna, né riferendoci a una causa remota, che noi potremmo e dovremmo immaginare immune da ogni compromesso. Resistere nel presente al futuro probabile, vuol dire scommettere che il presente offra ancora materia per la resistenza e che sia popolato da pratiche ancora vive anche se nessuna di queste è sfuggita a quella modalità parassita generalizzata chele coinvolge tutte [20].
Di fronte a questi nobili compiti, uno pensa al NIE e si immagina qualcosa di maestoso, eroico. Eppure si tratta di una prospettiva che fornisce un equipaggiamento leggero e ad alto potenziale. Penso in particolare a come gli UNO incarnano questa poetica, e mi viene in mente una sorta di “epica tascabile”, come il  socialismo degli Offlaga Disco Pax: qualcosa che appartiene alle pratiche del presente, molto vicina allo spirito della reality fiction di cui parla
socialismo degli Offlaga Disco Pax: qualcosa che appartiene alle pratiche del presente, molto vicina allo spirito della reality fiction di cui parla  R. S. Blackswift. Da portarsi dietro senza il peso di troppe citazioni [21]. Da masticare piano come foglia di coca boliviana per tragitti impervi. Da usare, soprattutto, come grimaldello per connettersi ad altre singolarità individuali e tenere sempre aperta la possibilità di una conversazione.
R. S. Blackswift. Da portarsi dietro senza il peso di troppe citazioni [21]. Da masticare piano come foglia di coca boliviana per tragitti impervi. Da usare, soprattutto, come grimaldello per connettersi ad altre singolarità individuali e tenere sempre aperta la possibilità di una conversazione.
Note
1. Guardacaso (ci sarà di mezzo Jacob?) si trattava della puntata “The shape of things to come”, la stessa da cui prende le mosse  questo pezzo recentemente comparso su Carmilla e che è quanto di più acuto io abbia letto finora a proposito di Lost. Toccherò qui solo di striscio quel livello di analisi, rinvio perciò all’articolo per i dovuti approfondimenti.
questo pezzo recentemente comparso su Carmilla e che è quanto di più acuto io abbia letto finora a proposito di Lost. Toccherò qui solo di striscio quel livello di analisi, rinvio perciò all’articolo per i dovuti approfondimenti.
2. Umoristica e non gelidamente ironica. Riprenderò alla fine il discorso parlando di “humour della verità”. (Peraltro, talvolta ciò che è gelidamente ironico dalla parte dell’opera narrata può diventare caldamente umoristico grazie all’opera della lettura).
3. Il rapporto tra sceneggiatori, pubblico e produttori nella costruzione del racconto è strettissimo tanto che queste figure sfumano l’una nell’altra. E’ anche vero che il lavoro di sceneggiatura va avanti nella misura in cui la produzione investe nell’impresa (“Ci sarà una nuova serie?”, “Quanti episodi saranno?”), il che dipende dal gradimento del pubblico e così via. Il modo in cui Lost organizza questa trama è sottile, incorporato e affiorante, a differenza ad esempio dalla pur esilarante serie italiana Boris, che mette in scena questo rapporto attraverso una simulazione con una fiction sulla fiction, con intenti satirici. E’ un’impressione, ma questa natura simulata mi lascia delle perplessità su Boris (mentre ho amato a dismisura la serie “buttafuori”, degli stessi autori). Per questo motivo un finale di Lost à la Boris, in cui vengono inquadrati operatori e sceneggiatori, farebbe cadere la serie nel ridicolo. O no?
4. Il tutto tenendo conto della mia memoria lacunosa e della mia esperienza di lettura, per natura di cose limitata. Le opere letterarie che verranno menzionate qui di seguito vanno perciò considerate più come emblemi che come riferimenti puntuali ed esaustivi, sono semplicemente quelle con cui mi trovo più a mio agio in questo discorso. E d’altro canto quello che sto scrivendo vuole essere più un terreno di lavoro aperto ad aggiunte, critiche e commenti.
[postilla: Comunque, credo che molte delle opere che hanno a che fare con i sopravvissuti abbiano a che fare con le numerose prese in considerazione da Simone Sarasso  nel suo pezzo sull’Apocalisse. Dato il tema ho voluto leggerlo solo alla fine di questo scritto, ed è incredibile come sembrino due facce della stessa medaglia!]
nel suo pezzo sull’Apocalisse. Dato il tema ho voluto leggerlo solo alla fine di questo scritto, ed è incredibile come sembrino due facce della stessa medaglia!]
5. Ginzburg, Carlo (2006) ‘Unus Testis’, ne Il filo e le tracce, Milano: Feltrinelli. L’opera di Carlo Ginzburg meriterebbe conoscenze e approfondimenti ben al di là della mia portata: non dico che potrò usarla con rispetto, ma spero con la minore spregiudicatezza possibile.
6. Benveniste, Emile (1976) Il vocabolario delle Istituzioni Indoeuropee II — Potere, Diritto, Religione, Torino: Einaudi (pp. 485-496, qua e là).
7. Pirandello è diventato una sorta di chiave per il mio ragionamento, e su questo punto rimando all’ultimo paragrafo. Aggiungo alla precaria lista anche il romanzo di Alexandre Dumas Il Conte di Montecristo che WM1 leggeva nel capodanno del 2005. Infine, la tematica dei sopravvissuti potrebbe essere estesa alla letteratura “steampunk”, visto anche il recente invito di Alberto Prunetti che si intitola giusto  “Sopravvivere con il punk a vapore”.
“Sopravvivere con il punk a vapore”.
8. Tanto per cominciare il sopravvissuto è difficile da individuare come tale: L’Henry Gale di Lost decifrato da Alessandra Daniele mette in guardia e in crisi lo status degli altri sopravvissuti, ribalta i ruoli [tra l’altro il vecchio Ben è proprio l'”other” per eccellenza]. Vorrei anche ricordare il paradossale sopravvissuto Robert Neville in I Am Legend di Matheson, e – visto che ho chiamato più volte in causa l’autrice – il racconto  “Mutazione” comparso di recente su Carmilla, che mi pare ribaltare l’amaro finale di Matheson.
“Mutazione” comparso di recente su Carmilla, che mi pare ribaltare l’amaro finale di Matheson.
9. Modest witness è il termine utilizzato da un filone transdisciplinare di studi sulla scienza e la teconologia (STS — Science and Technology Studies: si veda Simon Shapin [“Pump and Circumstance: Robert Boyle’s Literary Technology”, in Social Studies of Science, n.14, pp. 481-520], Donna Haraway [‘Modest Witness: Feminist Diffractions in Science Studies’, in Galison, P. and Stamp, D. J. (a cura), The Disunity of the Sciences: Boundaries, Contexts, and Power, pp. 428-441] e il meraviglioso e a tutti gli effetti “epico” saggio di Sharon Traweek [‘Attraversare i confini: le strategie narrative negli studi sulla scienza e tra i fisici nella Città della scienza di Tsukuba, Giappone’, in Pickering, A. (a cura), La scienza come pratica e come cultura, Torino: Edizioni di Comunità]. Gli STS si rivolgono ai fatti scientifici più spesso che storici, ma si interrogano con un metodo analogo sulle pratiche di laboratorio che conducono ad una nuova scoperta o invenzione. Ciò non tanto per fare le pulci a scienziati o ingegneri, quanto per rendere conto della complessità di una scoperta, tracciando l’opera di tutti gli attori che concorrono alla sua ‘manifattura’: i trucchi, le passioni, le rivalità, i finanziamenti necessari a generarla, che alla prova del pubblico vengono rimossi presentando invenzioni e scoperte come fatti o prodotti in sé e per sé.
10. Il sottotesto marxiano-ecologico della mia terminologia non è una metafora, ma vuole collegarsi al discorso della prospettiva ‘ecocentrica’ avanzato da WM1. Le produzioni letterarie e narrative sono parte dell’ecosistema, in quanto rientrano nel discorso dell’industria culturale. Ovvero le pratiche di sceneggiatura e messa in racconto hanno a che fare con le esigenze di produzione e di fruizione, non sono mere finzioni. In questo senso bisognerebbe studiare molto più a fondo le vicende riguardanti lo  sciopero degli sceneggiatori negli USA avventuo nel 2007-2008. Per quanto situati in una cornice che legittimava l’impianto classico del copyright, tali eventi hanno reso perfettamente conto della natura letteralmente ecologica delle narrazioni.
sciopero degli sceneggiatori negli USA avventuo nel 2007-2008. Per quanto situati in una cornice che legittimava l’impianto classico del copyright, tali eventi hanno reso perfettamente conto della natura letteralmente ecologica delle narrazioni.
11. Esiste poi un interno e un esterno? E’ qui secondo me il fulcro della presa di posizione allegoritmica da parte di WM1, coerente all’affermazione della necessità di portare avanti il conflitto dall’interno dell’industria culturale. Memorabile è la frase dei WM che lessi in un qualche “giap!” d’annata e che suonava pressappoco così: “noi siamo come l’asteroide di armageddon, ma non veniamo da un altro pianeta”.
12. Foucault, Michel (1971) ‘Nietzsche, la genealogia, la storia’, in Fontana, A. e Pasquino, P. (a cura), Michel Foucault – Microfisica del Potere – interventi politici, pp. 145-172. Dello stesso Autore (1971) L’archeologia del sapere, Milano: Rizzoli. Nel pensiero dello studioso il metodo archeologico confluirà successivamente nell’approccio genealogico lasciando però intatto l’impianto. Mantengo qui il termine “archeologia” perché si lega meglio alle tematiche che voglio discutere, ma mi faccio rientrare anche il discorso della genealogia.
13. Lo stesso discorso vale a mio parere per  Fringe, serie recente dello stesso J.J. In cui il mondo è considerato come laboratorio in cui si conducono abominevoli esperimenti di cui i più sono ignari. Tematica affrontata peraltro in modo molto più pregnante e appassionante dagli STS di cui parlavo in nota 9. Che poi in tema di sopravvissuti Cloverfield ci dica che è il filmato stesso che sopravvive alla specie umana, non mi sembra un contributo troppo originale. Soprattutto quando lo stesso film (presumibilmente prodotto con macchine da presa) ha la faccia tosta di sottendere che di quello che sta dentro alle telecamere c’è parecchio da dubitare. D’accordo Jacob, ma TU Jacob, da che parte stai? Bah, l’idea mi fa tornare in mente il celebre detto di Céline sull’inculare le mosche. (A proposito, ve li immaginate gli alieni che si imbatteranno nel voyager, ad interrogarsi sul perché ci sia dentro un
Fringe, serie recente dello stesso J.J. In cui il mondo è considerato come laboratorio in cui si conducono abominevoli esperimenti di cui i più sono ignari. Tematica affrontata peraltro in modo molto più pregnante e appassionante dagli STS di cui parlavo in nota 9. Che poi in tema di sopravvissuti Cloverfield ci dica che è il filmato stesso che sopravvive alla specie umana, non mi sembra un contributo troppo originale. Soprattutto quando lo stesso film (presumibilmente prodotto con macchine da presa) ha la faccia tosta di sottendere che di quello che sta dentro alle telecamere c’è parecchio da dubitare. D’accordo Jacob, ma TU Jacob, da che parte stai? Bah, l’idea mi fa tornare in mente il celebre detto di Céline sull’inculare le mosche. (A proposito, ve li immaginate gli alieni che si imbatteranno nel voyager, ad interrogarsi sul perché ci sia dentro un  cd con una compilation alquanto bizzarra? Lo considereranno un sopravvissuto attendibile della specie umana?)
cd con una compilation alquanto bizzarra? Lo considereranno un sopravvissuto attendibile della specie umana?)
14. Sono grato a  Lipperatura per aver segnalato e reso disponibile l’articolo di Rodotà (e per molto altro). A suo tempo la notizia del Time era venuta fuori con un
Lipperatura per aver segnalato e reso disponibile l’articolo di Rodotà (e per molto altro). A suo tempo la notizia del Time era venuta fuori con un  articolo di Valerio Evangelisti e la cosa mi aveva dato parecchio da pensare. Da notare che come racconta Evangelisti, secondo i Lettori del Time quella copertina avrebbe dovuto essere dedicata all'”epico” Chàvez ma all’ultimo momento la redazione ha ripiegato pilatescamente sullo “You”.
articolo di Valerio Evangelisti e la cosa mi aveva dato parecchio da pensare. Da notare che come racconta Evangelisti, secondo i Lettori del Time quella copertina avrebbe dovuto essere dedicata all'”epico” Chàvez ma all’ultimo momento la redazione ha ripiegato pilatescamente sullo “You”.
15. Da dove viene il mito di Obama se non dall’incarnazione di tutti i sopravvissuti degli Stati Uniti d’America e agli Stati Uniti d’America? Le sue parole a Chicago potevano essere quelle di chiunque, pronunciate in qualsiasi tempo e luogo. Ma non i volti che le ascoltavano, né il mondo che le seguiva in televisione. La grandezza di Obama poggia sulle spalle di milioni di voci, prima fra tutte quella di Ann Nixon Cooper, la donna nera da lui evocata che ha attraversato 106 anni di discriminazione razziale, ha fatto la fila al seggio e messo la sua croce. (il riferimento è  qua)
qua)
16. Carlo Levi, Lettera all’editore Giulio Einaudi per la seconda edizione di Cristo si è fermato ad Eboli, 1963. Non smetto di emozionarmi rileggendo queste parole. Ci ritrovo i paradossi dello spazio e del tempo, la fatica e la magia dell’esistere, la tensione etica e il desiderio, la lotta e la scoperta, l’esperienza e l’alterità, l’incertezza. E anche Lost, Jacob, la crisi economica, l’Ikea, la Nuova Epica. Fino all’esperienza di questi miei ultimi due anni un po’ più complicati dei precedenti, a cui mio malgrado sono sopravvissuto.
17. Rorty, Richard (1982) Consequences of pragmatism, Minneapolis: University of Minnesota Press.
18. Riprendo quest’espressione dal  gran bell’intervento di Marco Amici sul NIE.
gran bell’intervento di Marco Amici sul NIE.
19. Leggo su wikipedia che Pirandello paragona l’umorismo al dio Giano bifronte, in quanto è riso e pianto insieme. Ritrovo nella similitudine il caro Jacob, la cui doppia faccia mi parla del potere abilitante/disabilitante delle narrazioni. Le narrazioni “fanno fare”, ma questo far fare incorpora un’affordance, un invito operativo che imprime un certo orientamento all’azione. Contrastabile certo, ma non eludibile.
20. Stengers, Isabelle (2005) Cosmopolitiche, Roma: Sossella. (p. 19). Questo è pressappoco ciò che la filosofa intende con “Humour della verità”.
21. Anche se mi rendo conto che con 21 note e 7117 parole che faccio fatica a rileggere, questo non è proprio il pulpito adatto per parlare di equipaggiamento leggero.
* Claudio Coletta è dottorando di Sociologia e ricerca sociale all’Università di Trento.  Un altro suo intervento (“La terra di nessuno del pop”) è stato pubblicato su Carmilla quasi due anni fa.
Un altro suo intervento (“La terra di nessuno del pop”) è stato pubblicato su Carmilla quasi due anni fa.





