di Luca Briasco
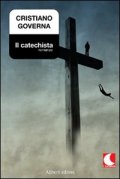 Cristiano Governa, Il catechista, Aliberti editore, 2007, pp. 229, € 15,00.
Cristiano Governa, Il catechista, Aliberti editore, 2007, pp. 229, € 15,00.
Conosco Cristiano Governa da tre anni. Ci siamo incontrati per la prima volta a Bologna, per la prima edizione del Festival su Cinema e letteratura. Cristiano collaborava con la Cineteca di Bologna, abbiamo gestito assieme una rassegna sulle trasposizioni filmiche dei romanzi di Jim Thompson, combattendo un caldo record e colmandolo delle nostre chiacchiere.
Abbiamo cominciato parlando di noir, di lì siamo passati alla letteratura tout court, alla musica, alla politica. Mi sono trovato davanti una mente straordinariamente ricca, ma soprattutto, per citare direttamente da Il catechista, una mente che sa porsi le domande giuste, ossia quelle che non si fanno “per sentirci rispondere ciò che abbiamo già deciso”. Una mente di cui la scrittura è il braccio armato, l’emanazione diretta. Quella di Cristiano Governa è una scrittura di domanda, a sua volta; una scrittura che non esita a interrogarsi sul degrado del mondo, ma rinunciando ai sociologismi e alle spiegazioni precostituite.
Proprio per questo, presentare Il catechista come un giallo sugli effetti devastanti della cultura televisiva e dei nuovi miti del reality sarebbe confondere il pretesto da cui muove il libro con la sua sostanza. Anche su questo, Cristiano Governa non potrebbe essere più chiaro. Fin dalle prime pagine, si capisce che la trama, il mistero, non contano. Il colpevole, se così si può dire, il lettore se lo trova davanti subito. Esibito in modo chiaro. E quanto alla televisione, imposta dall’assassino alla sua comunità di elezione in tutta la sua mortifera vacuità, è lo stesso catechista a chiarirne la funzione: “La tv è la porta, l’uscio lasciato socchiuso fra la realtà e noi stessi; ma la porta non è responsabile di chi la varca per fare irruzione in casa nostra.”
Dove sta dunque la sostanza de Il catechista? Mi piace pensare che stia altrove, in un tema costantemente penalizzato dalle modalità con cui oggi lo si affronta sui giornali, sul piccolo schermo e anche in letteratura: la grande crisi del religioso, nel senso più ampio, estensivo e laico del termine. E l’affermazione di un modello di vita fondato sul non credere, ergo sulla credulità. Nessuno meglio dell’autore può spiegare questo apparente paradosso, ragione per cui lascio ancora una volta parlare lui, con la voce del giovane catechista, che illustra la condizione spirituale delle sue pecorelle: “La questione non è se loro sanno o non sanno la verità, il fatto è che la verità a loro non interessa, mettitelo in testa; non ne hanno più bisogno. Si sono costruiti esistenze nelle quali la verità creerebbe solo imbarazzo e rallentamenti, mentre loro devono vivere con spudoratezza e velocità, e poi anche se la incontrassero, la verità in persona intendo, non saprebbero più riconoscerla, e sai perché? Perché non credono più a niente e quindi si bevono tutto; il dubbio e il sospetto sistematico coi quali ‘crescono’ i figli non aumentano il loro senso critico di ricerca del vero, al contrario li preparano alla sistematica somministrazione di menzogna.” E ancora: “Chi non crede non esclude nulla, chi non esclude nulla non sceglie niente; credere è come occupare una stanza con un mobile robusto e affidabile, dalle misure esattamente identiche alla grandezza della stanza. Riempie lo spazio, completa. Ma i loro cervelli devono restare vuoti per poterci mettere le nostre cianfrusaglie e il modo migliore per lasciare vuota una stanza è riempirla di ciò che non serve.”
A me questa sembra la vera sostanza del romanzo, la sua forza più autentica. E invito i lettori a guardare con attenzione le epigrafi che accompagnano molti dei capitoli, e che sono un modo con cui Cristiano – con un’onestà che appartiene a pochi – dichiara le proprie fonti di ispirazione, letterarie, filosofiche e musicali, da Flannery O’Connor ai Nine Inch Nails, dai Joy Division a Lucio Dalla per arrivare ai Simple Minds, creando un sistema virtuoso, tracciando la strada per riflessioni ulteriori, affidate a chi voglia e sappia andare oltre le coordinate di genere.
Ho detto che Il catechista non è un giallo. Ho evitato con cautela il termine noir, e non per caso. Sono infatti convinto che Cristiano abbia scritto un noir, ma non nell’accezione attuale e slabbrata con cui si usa la parola. Piuttosto, un noir classico, che torna alle radici del genere, a quei romanzi disperati dei Cain o dei Thompson in cui a dominare non è il mistero e la ricerca del colpevole, ma la discesa del protagonista nel laicissimo inferno del crimine, il suo progressivo, inesorabile trasformarsi in un morto vivente, come quello che vediamo galleggiare in una piscina mentre ci parla dall’oltretomba, in Viale del tramonto di Wilder. E certo, nel caso di Cristiano parliamo di un noir particolare, filosofico e religioso: un’esplorazione del male che, a titolo illustrativo e non per cercare paragoni, mi ha fatto pensare ai film di Abel Ferrara, o ai romanzi di Bernanos.
E ancora, un noir volutamente slabbrato, ridotto a frammenti (un po’ come Memento o come certi romanzi di Philip Dick) perché legato a un narratore malato di Alzheimer. L’amnesia, altro tema portante de Il catechista, è l’occasione per il secondo paradosso apparente sul quale è strutturato il romanzo. Voglio ancora affidarmi alle parole di Cristiano, che così fa descrivere al protagonista la sua malattia: “La mia testa è un armadio senza grucce nel quale si possono anche infilare gli abiti, ma non c’è alcun luogo in cui poterli appendere; i pensieri e i ricordi cascano in terra, da qualche parte, nell’oscurità dell’armadio stesso. A volte li ritrovo e li riconosco.” Proprio attraverso l’emozione del riconoscimento, il narratore combatte una grande battaglia in difesa della memoria, ridotta ormai, nel vortice della quotidiana credulità, a un pesante bagaglio di cui disfarsi nel nome di una nuova leggerezza. Una battaglia nella quale a essere in gioco è la comprensione dei fatti, ma anche e soprattutto la possibilità di raccontarli in un modo che li faccia ancora significare.
Non so dove andrà Cristiano, dopo Il catechista. In un certo senso questo libro è il culmine di una serie di tentativi dei quali, in passato, mi ha fatto parte, e che ruotavano attorno a temi molto simili, senza però trovare ancora una forma e una struttura convincenti. Neanche in questo libro tutto funziona. Ma credo sia inevitabile. Perché la mente di Cristiano Governa, la sua perenne ricerca di un senso non banale delle cose a volte inevitabilmente dominano sul lavoro di definizione dei personaggi, di ricerca della lingua giusta con cui farli parlare. E però, a mio modo di vedere, questo è uno degli esordi narrativi più potenti degli ultimi tempi; uno di quei libri che si riprendono in mano più volte, e sui quali si continua a riflettere anche molto tempo dopo averli riposti su una mensola. In attesa, magari, di un altro romanzo che sappia porsi e porci le domande giuste.



