Se un nuovo romanzo di Philip Roth appare in libreria, l’evento è assicurato. Tuttavia non è assicurata la tenuta qualitativa dell’opera a confronto con le aspettative. Intendiamoci: Roth è tra i tre o quattro migliori scrittori viventi al mondo, ma la sua discontinuità è ormai da considerarsi una norma. Da ![]() Portnoy a
Portnoy a ![]() Everyman (Einaudi, traduzione di V. Mantovani, € 13.50), l’ultimo nato che il suo genio ha partorito, sono tanti gli interludi, i momenti in cui lo scrittore americano ha ripreso fiato, per lanciarsi poi in variazioni consistenti ed travolgenti, trasformazioni personali che hanno trasformato la letteratura contemporanea. Roth ha il pregio e il difetto di affiliare: esiste un partito di “rothiani”, con i quali personalmente vado solo saltuariamente d’accordo. Prendiamo il caso de
Everyman (Einaudi, traduzione di V. Mantovani, € 13.50), l’ultimo nato che il suo genio ha partorito, sono tanti gli interludi, i momenti in cui lo scrittore americano ha ripreso fiato, per lanciarsi poi in variazioni consistenti ed travolgenti, trasformazioni personali che hanno trasformato la letteratura contemporanea. Roth ha il pregio e il difetto di affiliare: esiste un partito di “rothiani”, con i quali personalmente vado solo saltuariamente d’accordo. Prendiamo il caso de ![]() L’animale morente: a mio parere uno dei libri fondamentali usciti nell’ultima decade, e attaccato da fidatissimi partigiani di Roth. I quali hanno disdegnato anche
L’animale morente: a mio parere uno dei libri fondamentali usciti nell’ultima decade, e attaccato da fidatissimi partigiani di Roth. I quali hanno disdegnato anche ![]() Il complotto contro l’America, qui trovandomi d’accordo. I medesimi dicevano che
Il complotto contro l’America, qui trovandomi d’accordo. I medesimi dicevano che ![]() La macchia umana, un romanzo per me memorabile, non era all’altezza di
La macchia umana, un romanzo per me memorabile, non era all’altezza di ![]() Sabbath o della
Sabbath o della ![]() Pastorale (di quest’ultimo titolo non ho imbarazzo a dire che per me vale Underworld di DeLillo). Con Everyman ci si troverà allibiti, “rothiani” e non: questa è la quintessenza di Roth, il negativo del motivo per cui il suo racconto vitalista ha conquistato lettori carnali e desiderosi di una libido letteraria che facesse fremere la carne fuori dalla letteratura stessa.
Pastorale (di quest’ultimo titolo non ho imbarazzo a dire che per me vale Underworld di DeLillo). Con Everyman ci si troverà allibiti, “rothiani” e non: questa è la quintessenza di Roth, il negativo del motivo per cui il suo racconto vitalista ha conquistato lettori carnali e desiderosi di una libido letteraria che facesse fremere la carne fuori dalla letteratura stessa.
Anzitutto: Everyman non è un romanzo. E’ un racconto lungo in cui la psicologia dei personaggi non conta o, se conta, è sviluppata ai minimi termini. Conta solo la psicologia del protagonista, il chiunque che parla, il quale ritroviamo morto, alla sua inumazione, nell’unica scena di questo libro capace di stamparsi sull’occipite. Il resto è un flashback, in cui il cadavere, riesumato solo a mezzo della memoria e della potenza della narrazione, riassume non tanto il suo passato – esercizio in cui Roth solitamente dà il meglio di sé -, quanto la sua decadenza. Quale decadenza? Morale? Potrebbe benissimo essere, poiché Everyman è il titolo di un morality play inglese medievale (editato intorno agli inizi del ‘500). A differenza del morality play, l’Everyman di Roth non fa ridere affatto. A differenza del morality play, l’Everyman di Roth non è un incontro con la morte, ma con la decadenza fisica e psichica. 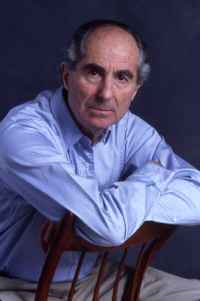 C’è una bella differenza: talmente bella che potremmo additarla come il deposito di bellezza che Roth poteva inserire in questo racconto lungo, senza in effetti farlo.
C’è una bella differenza: talmente bella che potremmo additarla come il deposito di bellezza che Roth poteva inserire in questo racconto lungo, senza in effetti farlo.
La prima impressione è infatti quella di assistere a un teatrino di perdite, a una lista del telefono in cui si cancellano i nomi e gli indirizzi di coloro che non sono più raggiungibili, perché passati all’altro mondo. E’ la lettura di un atlante dell’invecchiamento, in cui il corpo non giunge mai una volta alle spiraloidali assolutezze di laicismo assoluto a cui Roth è pervenuto nelle scene memorabili dei suoi romanzi migliori. Qui c’è un cardiopatico e c’è una descrizione dei suoi infarti multipli e dell’inserimento di by-pass e di un fibrillatore: punto. C’è una continua, esacerbata maledizione lanciata all’età del decadimento fisico, che non conduce a saggezza ma a malattia. Quindi, non c’è morale. C’è nichilismo, questo sì: e lo avevamo capito dal corpus intero di Roth. Corpus, tuttavia, bucherellato: ci sono momenti, in Roth, in cui la scrittura non è controllata, e tuttavia rimane sublime dal punto di vista dello stile, ma la materia – che è sempre: carne, vita, stato di veglia, eros, piacere e dolore che intridono il corpo e la psiche – è sfondata in direzione di sconcertanti abusi della consapevolezza, condotta all’inconsapevolezza. Valga, per tutti gli esempi che si potrebbero fare, l’incontro tra lo Svedese e la figlia, terrorista vegana anoressica, in Pastorale americana (detto per inciso, considero l’intero romanzo breve L’animale morente un buco nero unico, uno sfondamento totale della materia da parte di Roth).
In Everyman, no. In Everyman è come se assistessimo allo sforzo di botanici che piantano un germoglio e si affannano a sperare che esso dirami i suoi prolungamenti e diventi albero. Tutto il coté borghese, che in Roth si sublima in affreschi da storia della letteratura, viene qui ossificato: i rapporti vanno così e così, bastano dialoghi limitati a capire che le storie sono quelle che sono, quelle che conosciamo.
Tutto ciò sia detto senza offesa verso alcuno dei partigiani di Roth.
Everyman o è un romanzo non riuscito o è un romanzo che Roth non voleva fare riuscire. Propendo per la seconda ipotesi.
Che cos’è, infatti, questo processo di ossificazione a cui il plot, il ritratto dei personaggi, il dipinto delle loro vite – questa fossilizzazione, che incarbonisce, a cui tutto il libro viene sottoposto? Ho troppa fiducia nello Zuckerman in carne e ossa per non sospettare. La verità plausibile, a mio parere, è che in Everyman accada questo: Philip Roth fa precipitare le proprie premesse, su cui ha costruito un monumento letterario, al deposito salino e disidratato delle proprie conclusioni. Everyman è quello che Roth è: senza mediazioni. E tutta la vivacità, l’enorme inventiva che permette la carne quando è florida, per un vitalista nichilistizzato come Roth, diventa la litania secca, priva di speranza, che è questo racconto lungo. Roth fa i conti con se stesso: ecco quello che ha pensato sempre e che ha sempre funzionato e, adesso che si avvicina la morte, non può più funzionare. Il complotto era un’avvisaglia: inventare, creare l’ucronia per raccontare i propri esordi, per raccontare sé, era così faticosa, così pomposamente inutile e improbabile… E, nell’Animale morente la malattia mortale veniva, una volta ancora, scaricata sugli altri, mentre per sé ci si tiene la prostata che non regge, ma non stronca. In questo senso, Everyman è un titolo comico e viene ristabilita la logica del morality play: c’è da ridere a pensare che uno sia tutti a queste condizioni, che Roth universalizzi questa visione della vita come landa desolata ai suoi estuari, mentre era il paradiso in cui latte e miele colavano e scorrevano quando si stava bene, si aveva la forza di separarsi dalle proprie mogli, addirittura di sopportare interventi chirurgici.
Si appalesa il limite intrinseco di Roth: egli non è uno scrittore vitalista, egli è uno scrittore materialista. Non c’è una volta che vada radicalmente a domandarsi cosa ci faccia qui, con questa “macchina del corpo”. Non c’è nemmeno l’eroismo prometeico di chi, di fronte al nulla, si chieda qualcosa a proposito del nulla. In questo, Roth è uno scrittore del secolo scorso: plausibilmente antimetafisico, tenendo presente però che il materialismo radicale è pura metafisica. La cifra di arroganza, quella logorrea divina che ha fatto i grandi romanzi di Roth, si dissecca e rimane ciò che è: arroganza. L’arroganza di chi detiene a priori le risposte in base all’empiria, perché ritiene che soltanto il corpo (e la mente che ne dipende – e vadano a quel paese tutte le acquisizioni neuroscientifiche e fisiche di questi ultimi vent’anni!) sia il testimone unico e casuale di quell’accidente che chiamiamo “vita”. Con Everyman, Roth costruisce la specola più veritativa attraverso cui guardare la sua precedente produzione: nessuna destinalità, le coincidenze fanno tutto, i casi della vita sono talmente interessanti che un’epopea la si può scrivere anche in epoca laica, anche nell’era che, in letteratura, sembra avere abolito l’epica. Anzi: gli accidenti dell’esistenza sono proprio quest’epica! Va da sé, un’epica occidentale, newyorkese-ebraica, colta – non universale. Perché se vado a leggere Omero di fronte a diseredati indiani, è certo che costoro reagiranno alle universalità che Omero scandisce, pur costruendo il progetto umanistico occidentale; se vado a leggere ai medesimi soggetti l’Everyman di Roth, essi sorrideranno. L’epica di Roth non è, dunque, epica; e non lo è nel momento che costituisce l’acme dell’epica: il confronto con la morte. Che Roth evita debitamente, in Everyman: poiché qui il confronto è soltanto con i sintomi, con i propri pregiudizi, con se stesso che pensa alla morte – e non con la morte stessa.
Delle due, una: o è un romanzo veritativo sul sé che l’umano occidentale è divenuto (un sé non autointerrogativo se non sul piano psicofisiologico); o è un romanzo inutile molto bene scritto. Il tempo sceglierà tra le due possibilità. Tuttavia, se devo scommettere sulla scelta del tempo, Everyman morirà, ci si scorderà di questo libro che svanirà, mettendo a rischio la memoria di tutto Roth, perché davvero lo rappresenta nella sua quintessenzialità. Peccato che non potrò verificare l’esito della scommessa: ammesso che la specie non devasti se stessa e il pianeta, devono passare almeno centocinquant’anni per fare un bilancio circa ciò che Roth ha significato nella nostra epoca ma, soprattutto, su quello che può significare nelle epoche a venire e quello che avrebbe potuto significare in quelle passate – cioè quanto di universale sia o meno presente nella sua letteratura.
Articoli recenti
- L’eternauta e le declinazioni del nemico 3 Luglio 2025
- Frantz Fanon, a cent’anni dalla nascita 1 Luglio 2025
- Come insetti sui margini del mondo 30 Giugno 2025
- Un’anomala discronia 29 Giugno 2025
- Dove il mysterium si fa tremendum 28 Giugno 2025
- Il reale delle/nelle immagini. Trump e il ruolo politico delle nuove immagini 27 Giugno 2025
- La pittura, il biliardo e l’inferno 27 Giugno 2025
- «Banditi» per necessità ovvero la Resistenza così come fu 25 Giugno 2025
-
Intervista a Emanuele Trevi
Nel Labirinto di Philip K. Dick 2 24 Giugno 2025 - Abbasso le buone maniere 23 Giugno 2025
- Palazzo Cesi raccontato senza 23 Giugno 2025
- Cozzilla il re dei mostri 21 Giugno 2025
- Intervista a Hansy Lumen 20 Giugno 2025
- Immaginazioni e utopie italiane. Scritture di fantascienza di Corrado Alvaro 19 Giugno 2025
- Dominio, dissimulazione, resistenza e rivolta 18 Giugno 2025
- Prima stella a destra 18 Giugno 2025
-
Ruggine siamo e ruggine ritorneremo.
Nel Labirinto di Philip K. Dick 1 17 Giugno 2025 - Referendum: tra depressioni e reticenze 15 Giugno 2025
- Isabel in Wonderland (Piccole stregherie 1) 14 Giugno 2025
- Police abolition 14 Giugno 2025
- Il genocidio di Gaza tra decolonizzazione e competizione vittimaria 13 Giugno 2025
- Schiacciati per aver deciso di combattere. Ancora su Haymarket Square, Chicago e la memoria di classe 11 Giugno 2025
- Haymarket, Chicago 11 Giugno 2025
- Guerriglia psichica 10 Giugno 2025
- Identità e maschere nell’era digitale 8 Giugno 2025
Chi siamo
1) Carmilla è un blog dedicato alla letteratura di genere, alla critica dell'immaginario dominante e alla riflessione culturale, artistica, politica, sociologica e filosofica, riassumibile nella dicitura: “letteratura, immaginario e cultura d'opposizione”.
E' esente da qualsiasi tipo di attività a scopo di lucro ed è priva di inserti pubblicitari o commerciali. Inoltre non è oggetto di domande di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche che conseguano qualsiasi ricavo e si basa sull'attività volontaria e gratuita di redattori e collaboratori.2) Carmilla non si articola in piani editoriali ed è esclusivamente on line. La pubblicazione di contributi su temi d'attualità è esclusivamente funzionale ad affrontare i temi sopra elencati.
3) Pertanto, in riferimento ai punti 1) e 2) Carmilla non è soggetta alla registrazione presso il Tribunale, ossia alla Legge 1948 N. 47, richiamata dalla Legge 62/2001, nonché l’Art. 3-Bis del Decreto Legge 103/2012, _N. 4_16 e successive modifiche, l’Articolo 16 della Legge 7 Marzo 2001, N. 62 e ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni N. 666/08/CONS del 26 Novembre 2008, e successive modifiche.
4) Carmilla è composta da editor chi si autogestiscono con senso di responsabilità nei riguardi del collettivo redazionale e del Direttore Responsabile. I contributi pubblicati non corrispondono
necessariamente e automaticamente alle opinioni dell'intera Redazione o del Direttore Responsabile. Questo aspetto va tenuto presente per quanto riguarda ogni tipo di azione o richiesta, in un'ottica di composizione di eventuali contenziosi, contattando la Redazione tramite l'e-mail sotto indicata.5) L’indirizzo e-mail ha una funzione esclusivamente tecnica, di interfaccia con quanti intendano comunicare osservazioni relativamente al materiale già pubblicato (titolarità delle immagini, dei contributi e correttezza dei medesimi), motivo per cui non si risponderà' a chi lo userà per inviare contributi da pubblicare o a qualsiasi tipo di richiesta di carattere editoriale, commento o discussione. Esso è: carmillaonline_legal chiocciola libero.it
6) La pubblicazione online, cartacea, multimediale o in qualsiasi altro format dei contributi già pubblicati su Carmilla, è consentita solo citando la fonte egli autori dei contributi menzionati.
Direttore Responsabile: PETER FREEMAN

Archivi
- luglio 2025
- giugno 2025
- maggio 2025
- aprile 2025
- marzo 2025
- febbraio 2025
- gennaio 2025
- dicembre 2024
- novembre 2024
- ottobre 2024
- settembre 2024
- agosto 2024
- luglio 2024
- giugno 2024
- maggio 2024
- aprile 2024
- marzo 2024
- febbraio 2024
- gennaio 2024
- dicembre 2023
- novembre 2023
- ottobre 2023
- settembre 2023
- agosto 2023
- luglio 2023
- giugno 2023
- maggio 2023
- aprile 2023
- marzo 2023
- febbraio 2023
- gennaio 2023
- dicembre 2022
- novembre 2022
- ottobre 2022
- settembre 2022
- agosto 2022
- luglio 2022
- giugno 2022
- maggio 2022
- aprile 2022
- marzo 2022
- febbraio 2022
- gennaio 2022
- dicembre 2021
- novembre 2021
- ottobre 2021
- settembre 2021
- agosto 2021
- luglio 2021
- giugno 2021
- maggio 2021
- aprile 2021
- marzo 2021
- febbraio 2021
- gennaio 2021
- dicembre 2020
- novembre 2020
- ottobre 2020
- settembre 2020
- agosto 2020
- luglio 2020
- giugno 2020
- maggio 2020
- aprile 2020
- marzo 2020
- febbraio 2020
- gennaio 2020
- dicembre 2019
- novembre 2019
- ottobre 2019
- settembre 2019
- agosto 2019
- luglio 2019
- giugno 2019
- maggio 2019
- aprile 2019
- marzo 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- novembre 2018
- ottobre 2018
- settembre 2018
- agosto 2018
- luglio 2018
- giugno 2018
- maggio 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- dicembre 2017
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- agosto 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- maggio 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- luglio 2016
- giugno 2016
- maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
- agosto 2015
- luglio 2015
- giugno 2015
- maggio 2015
- aprile 2015
- marzo 2015
- febbraio 2015
- gennaio 2015
- dicembre 2014
- novembre 2014
- ottobre 2014
- settembre 2014
- agosto 2014
- luglio 2014
- giugno 2014
- maggio 2014
- aprile 2014
- marzo 2014
- febbraio 2014
- gennaio 2014
- dicembre 2013
- novembre 2013
- ottobre 2013
- settembre 2013
- agosto 2013
- luglio 2013
- giugno 2013
- maggio 2013
- aprile 2013
- marzo 2013
- febbraio 2013
- gennaio 2013
- dicembre 2012
- novembre 2012
- ottobre 2012
- settembre 2012
- agosto 2012
- luglio 2012
- giugno 2012
- maggio 2012
- aprile 2012
- marzo 2012
- febbraio 2012
- gennaio 2012
- dicembre 2011
- novembre 2011
- ottobre 2011
- settembre 2011
- agosto 2011
- luglio 2011
- giugno 2011
- maggio 2011
- aprile 2011
- marzo 2011
- febbraio 2011
- gennaio 2011
- dicembre 2010
- novembre 2010
- ottobre 2010
- settembre 2010
- agosto 2010
- luglio 2010
- giugno 2010
- maggio 2010
- aprile 2010
- marzo 2010
- febbraio 2010
- gennaio 2010
- dicembre 2009
- novembre 2009
- ottobre 2009
- settembre 2009
- agosto 2009
- luglio 2009
- giugno 2009
- maggio 2009
- aprile 2009
- marzo 2009
- febbraio 2009
- gennaio 2009
- dicembre 2008
- novembre 2008
- ottobre 2008
- settembre 2008
- agosto 2008
- luglio 2008
- giugno 2008
- maggio 2008
- aprile 2008
- marzo 2008
- febbraio 2008
- gennaio 2008
- dicembre 2007
- novembre 2007
- ottobre 2007
- settembre 2007
- agosto 2007
- luglio 2007
- giugno 2007
- maggio 2007
- aprile 2007
- marzo 2007
- febbraio 2007
- gennaio 2007
- dicembre 2006
- novembre 2006
- ottobre 2006
- settembre 2006
- agosto 2006
- luglio 2006
- giugno 2006
- maggio 2006
- aprile 2006
- marzo 2006
- febbraio 2006
- gennaio 2006
- dicembre 2005
- novembre 2005
- ottobre 2005
- settembre 2005
- agosto 2005
- luglio 2005
- giugno 2005
- maggio 2005
- aprile 2005
- marzo 2005
- febbraio 2005
- gennaio 2005
- dicembre 2004
- novembre 2004
- ottobre 2004
- settembre 2004
- agosto 2004
- luglio 2004
- giugno 2004
- maggio 2004
- aprile 2004
- marzo 2004
- febbraio 2004
- gennaio 2004
- dicembre 2003
- novembre 2003
- ottobre 2003
- settembre 2003
- agosto 2003
- luglio 2003
- giugno 2003
- maggio 2003
- aprile 2003
- marzo 2003
- febbraio 2003
- gennaio 2003



