di Franco Pezzini
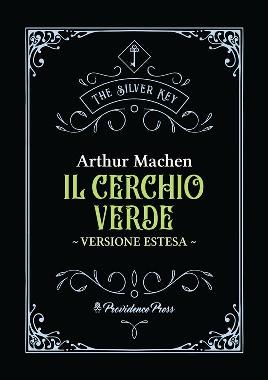 Arthur Machen, Il Cerchio Verde (versione estesa), ed. orig. 1933, trad. di Fiorella Polidoro, con tre racconti trad. da Frank J. Morisi, testi di Giacomo Ortolani e Gianfranco Calvitti, pp. 235, € 20,90, Providence Press, Bologna 2022.
Arthur Machen, Il Cerchio Verde (versione estesa), ed. orig. 1933, trad. di Fiorella Polidoro, con tre racconti trad. da Frank J. Morisi, testi di Giacomo Ortolani e Gianfranco Calvitti, pp. 235, € 20,90, Providence Press, Bologna 2022.
“Hillyer non aveva intenzione di scivolare nel precedente stato di oscuro assorbimento nella miriade di studi, meditazioni e ricerche […] Avrebbe dedicato la sera, e magari buona parte della notte, al suo lavoro; il mattino, invece, si sarebbe mescolato tra la gente e avrebbe esplorato l’infinito mondo di Londra: di per sé, lo studio di una vita intera”.
Ma quando il flâneur Arthur Machen (1863-1947) scrive il suo ultimo romanzo Il Cerchio Verde (The Green Round), 1933, è ormai lontano dai tempi degli scritti più noti e giovanili memori di tanti vagabondaggi, Il gran dio Pan (The Great God Pan, 1894), I tre impostori (The Three Impostors, 1895) e La collina dei sogni (The Hill of Dreams, 1895-1897, pubbl. 1907) come dallo stesso pur maturo Il terrore (The Terror, 1917). È settantenne, e rivede la propria opera con qualche rincrescimento – gli pare troppa (confessa nell’autobiografia) l’enfasi spesa sull’oscurità e l’orrore – e del resto il mondo intorno è cambiato. Conclusa l’età vittoriana, chiuso anche il mondo pre- e post- Grande guerra sul cui sfondo collocare le proprie fantasie mistico-patriottiche (che, pur nella loro eleganza, ci sembrano molto più lontane degli spettri bellici alla Bierce), il vecchio simbolista deve avvertire un sapore di vago smarrimento. Non stupiscono certe sue manifestazioni di simpatia per un fascismo di cui in fondo non capisce granché, e gli pare romantico e misticheggiante contro l’incalzare del materialismo: non ha del resto elementi concreti per comprendere davvero disvalori e farabutti legati ai gagliardetti fascisti, ma un certo smarrimento deve coinvolgere tutto un orizzonte. E di questo smarrimento Il Cerchio Verde può offrire qualche indizio, al netto di un esito umanamente sapiente nella presa d’atto finale – prima di passare, negli ultimi anni, a una scrittura essenzialmente saggistica.
L’edizione apparsa per i tipi Providence Press – merita sottolineare – è meravigliosa. E non solo per l’elegante veste grafica, ma per la cura, la ricchezza critica e l’intelligenza da cui il volume (tanto più la versione estesa ora presentata) è connotato. Splendido e lucido l’ampio saggio postfattivo di Giacomo Ortolani al romanzo con un lussureggiante corpus di note, molto bello anche il corsivo finale di Gianfranco Calvitti a tre racconti di guerra macheniani meno noti – e degni d’interesse: La storia del sergente Richard Haughton, Il calvario di Azay, Il canto di guerra dei Gallesi. Meritorio soprattutto l’approccio che lascia alle spalle certe banalità trite e ritrite su Machen – eredi di tutto un filone di vecchie e ambigue proposte editoriali, magari strumentalmente ideologiche – per riportarlo allo specifico di un orizzonte letterario puro nel dialogo intenso con James, Wells, Kipling, Stevenson, Wilde, MacDonald, Lord Dunsany…
Ed è bello leggere questo romanzo anche sul filo del dibattito sul weird. In un contesto di godibilissime frecciate al gusto moderno e insieme a un certo tradizionalismo brontolone, il povero Lawrence Hillyer, solitario studioso di cose “nascoste”, si trova costretto a trascorrere un periodo di relax a Porth, una località di villeggiatura sulla costa del Galles. Lì qualcosa di perturbante sembra però restargli attaccato addosso per incalzarlo a Londra, e scatenargli intorno una quantità di inquietanti fenomeni che fanno pensare ai casi strambi repertoriati da Charles Hoy Fort (1874-1932), autore di un certo successo in quegli anni. Casi che però, con approccio molto diverso, Machen rende occasione per riflessioni filosofiche – quei nessi causali tanto determinanti per una riflessione sul weird – e speculazioni su sogno, occulto, folklore e quelle che potremo chiamare sincronicità, traghettando a un finale in qualche modo aperto.
Il fatto è che, sembra dire Machen, gli approcci disciplinari ai misteri della realtà non sanno coglierne lo specifico: è tra gli interstizi che occorre riflettere in termini eziologici. Come ne Il gran dio Pan si svelano i corti limiti da un lato delle scienze sociali e dall’altro di una mitologia erudita vittoriana, così ne Il popolo bianco (The White People, 1904) – e in realtà anche in altre opere – si constata la fallacia di quegli studi positivistici di antropologia religiosa e folklore al tempo tanto apprezzati: e qualcosa del genere torna a proporsi qui. Che il raccapricciante bambino visto aggirarsi attorno a Hillyer o decisamente al suo fianco sia un’Ombra perturbante, o che sia piuttosto uno sfuggente membro del Piccolo Popolo – ma questi rappresentano solo nomina nuda – le caratteristiche delle azioni a quello imputabili, offerte come squisite affabulazioni di un elegantissimo narratore, coprono tutto il ventaglio tra l’atroce e il bizzarro, costringendo il lettore a rivedere le proprie categorie. Fino alla presa d’atto che ognuno debba offrire una propria “spiegazione” o lasciare aperto il caso. Dove in questione non è tanto una rinuncia, ma la riflessione sapienziale ormai matura su un imbarazzo radicale: un fantastico come incertezza e impossibilità di stabilire positivamente un esito che vede dialogare in qualche modo Todorov e Schrödinger, per insidiare la stessa efficacia delle categorie (delitti inspiegabili anche per poliziotti sussiegosi, poltergeist e altri fenomeni parapsichici, fate…) impegnate nel discettare del mistero. Il lavoro del vecchio Machen, la sua provocazione su una realtà che nessun bisturi può permetterci di notomizzare in modo completo, è ormai qui idealmente concluso.



