di Luca Baiada
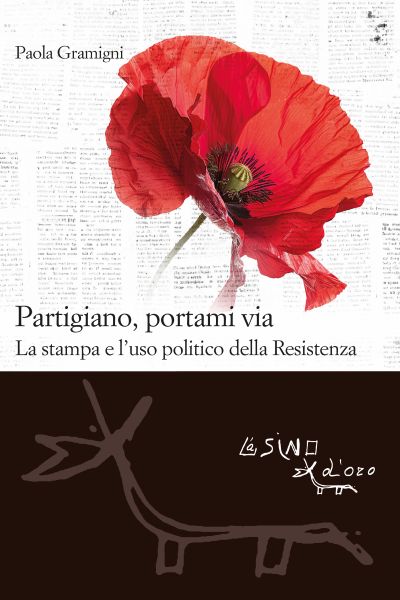 Paola Gramigni, Partigiano, portami via. La stampa e l’uso politico della Resistenza, prefazione di Lidia Piccioni, L’asino d’oro edizioni, Roma 2025, pp. 176, euro 18.
Paola Gramigni, Partigiano, portami via. La stampa e l’uso politico della Resistenza, prefazione di Lidia Piccioni, L’asino d’oro edizioni, Roma 2025, pp. 176, euro 18.
Una ricerca condotta su libri, giornali e periodici. Oggetto, il lavoro culturale e comunicativo attorno alla Resistenza. Si segnala per l’impegno nell’approfondimento e per un tono schierato, senza ambigue imparzialità. Le premesse sono buone perché danno peso a Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, e alle controversie che aprì anche a sinistra.
L’autrice si muove in tutta sicurezza. È smaliziata, quando dà conto del fatto che il concetto di guerra civile spezza «l’immagine oleografica e rassicurante della Resistenza come fenomeno unitario». Il revisionismo antiresistenziale è fronteggiato a viso aperto e l’analisi è profonda. È una mistificazione, trattare i fatti sminuzzando dettagli senza cogliere il senso d’insieme, come si fa per la cronaca nera: la storia scompare e «al suo posto resta una valanga di singoli eventi la cui veridicità è affidata alle memorie dei parenti e ai racconti dei testimoni, oculatamente selezionati, di allora».
Così è smascherata la trappola insita nella memoria scissa dalla storia. Certe tecniche narrative strizzano l’occhio al pubblico con porzioni precotte, pastoni di fatti spiccioli. Sono le raccolte di ricostruzioni alternative, di ipotesi, di illazioni. Gramigni dice bene: chi ha cercato di far scomparire la storia ha lavorato su testimoni «oculatamente selezionati». È stato il caso delle insistenze pelose sulla memoria divisa (le stragi di Civitella e Guardistallo, o altro), quando ricerche falsamente neutrali e innovative hanno riproposto tesi antipartigiane e stravecchie.
Partigiano, portami via legge il revisionismo in parallelo con le manovre eversive, anche quelle ricollegabili a lontani cambi di gabbana. Nel 1990 Andreotti ammette l’esistenza di Stay Behind; nello stesso anno riemergono le carte Moro a Milano, in via Monte Nevoso, e c’è la stagione di Francesco Cossiga «picconatore»; a maggio 1991 Cossiga esalta la struttura Osoppo; nel 1992 c’è una commemorazione dell’eccidio di Porzûs, Cossiga sta per andarci ma la visita è annullata e ci va Edgardo Sogno[1]. Dopo la guerra la Osoppo venne ricostituita come Organizzazione O, con ex partigiani, parroci ed ex repubblichini; l’Organizzazione O, a sua volta, nel 1956 fu sciolta e confluì in Gladio[2]. E proprio sui partigiani osovani, Cossiga dichiara che «con una continuità ideale rispetto al loro impegno nella Resistenza, essi entrarono a fare parte delle Divisioni Osoppo-Friuli e Gorizia, dell’Organizzazione O e della rete Stay Behind»[3]. Più chiaro di così.
Meno convincenti, invece, le pagine in cui per capire i fatti ci vuole dimestichezza con le questioni processuali e, più in profondità, con la giustizia. Così l’Armadio della vergogna, l’archivio sulle stragi nazifasciste insabbiato nella sede centrale della giustizia militare, è presentato con dettagli tralatizi:
In relazione all’indagine istruttoria per Priebke, nell’estate del 1994, mentre il procuratore militare Antonino Intelisano stava cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che poteva essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kappler, viene «scoperto» un armadio in legno marrone, sigillato, con le ante rivolte verso il muro, protetto da un cancello in ferro e da un lucchetto[4].
Manca anche una rivisitazione critica del fatto che la celebrazione dei processi, durata dalla seconda metà degli anni Novanta al 2015, si è risolta in una ventina di dibattimenti e ha portato in carcere solo tre nazisti.
È giusto che si ricordino tre convegni dopo la fine del blocco socialista: In memory: per una memoria europea dei crimini nazisti, ad Arezzo nel 1994; La Resistenza tra storia e memoria, a Roma nel 1995; Identità e storia della Repubblica. Per una politica della memoria nell’Italia di oggi, a Roma nel 1997. Ma bisogna notare la coincidenza con la riemersione dell’Armadio e, quindi, le implicazioni con la giustizia sui crimini del nazifascismo. Va sottolineato, per esempio, che il convegno In memory fu finanziato non solo da enti pubblici, ma da una banca e dalla Volkswagen Stiftung[5].
Anche sull’Atlante delle stragi, il libro ricorda il finanziamento tedesco ma non ne trae conclusioni complete. È necessario rendersi conto dei difetti di tutta l’operazione e del nesso perverso fra cattiva storiografia e mancati risarcimenti ai familiari delle vittime. Insomma, bisogna cogliere il legame fra memoria anestetizzata e giustizia mancata. Bisogna anche accennare agli altri prodotti memoriali che, proprio come l’Atlante delle stragi, sono stati finanziati dal Fondo italo-tedesco per il futuro, «Deutsch-Italienischer Zukunftsfonds». Si pensi a NS-Täter in Italien. Le stragi nell’Italia occupata nella memoria dei loro autori. L’accostamento parla da sé. Documentazioni di crimini, come l’Atlante, e di voci dei criminali, finanziate e accomunate in un’operazione protetta dalla ragion di Stato. Un appiattimento che conferma la mancanza di profondità di quelle ricerche nate strumentali, la loro fragilità politica e la loro inanità morale.
Sia chiaro, però. Sarebbe ingeneroso addebitare all’autrice, che si è rimboccata le maniche su un tema necessario, le lacune di buona parte del lavoro storico, in Italia. Oltretutto, sono pochi i grandi storici formati nel Novecento che abbiano anche una preparazione giuridica (tra loro Pavone, Enzo Collotti, Pietro Scoppola e Nicola Tranfaglia). In proposito Raffaele Romanelli ricorda le parole di Gioacchino Volpe, all’inizio dello scorso Secolo, sulle brutte conseguenze di questa lacuna[6]. Romanelli si esprime in un convegno proprio su Pavone.
Sul metodo, Partigiano, portami via è consapevole di sé, quando si rende conto delle conseguenze insite nel perimetro posto alla ricerca. La storia è fatti, non parole sulla storia:
Non sapremo mai se la delegittimazione della Resistenza veicolata dai media per scopi politici contingenti, oppure la strisciante rivalutazione del fascismo-regime implicita nella lettura dell’8 settembre 1943 come «morte della patria» e non come inizio del riscatto, oppure, infine, la polemica di Renzo De Felice con la storiografia d’ispirazione antifascista, ampiamente ripresa dalla stampa, abbiano, tutte queste vicende, avuto o meno un’influenza decisiva nell’indirizzare l’elettorato moderato. Ci limitiamo a constatare che prima si è iniziato a mettere in discussione le radici storiche della «Repubblica nata dalla Resistenza», poi, in una congiuntura politica del tutto inedita, sono stati sdoganati i neofascisti come partito di governo.
Qui l’autrice ha il merito raro di segnalare una questione senza imporre una soluzione preconfezionata. Aggiungiamo soltanto qualcosa.
L’onda nera non è tutta d’inchiostro, e solo un suo rivolo passa dalle cabine elettorali. La percezione della successione temporale tra le fasi è giusta, e per cogliere l’insieme bisogna considerare, per esempio, che gli anni Ottanta – Renzo De Felice storico di grido, Giuliano Ferrara suo intervistatore – sono anche quelli delle sconfitte operaie, della riscossa padronale, del Pci che scivola via credendo di aggrapparsi alla questione morale e dell’asse Craxi-Andreotti-Forlani. A un arretramento della lotta di classe è corrisposto un indebolimento della memoria. Ma questo all’autrice non sfugge, visto che capisce le dinamiche:
Rincorrere la destra sul terreno della rilettura della storia, pensando probabilmente di contenerne in tal modo le spinte revisionistiche, e, contemporaneamente, utilizzare alcuni di questi temi per scopi politici, non ha reso un buon servizio proprio alla conoscenza e alla memoria.
E poi, il volume smaschera di getto il trucco retorico su fascismo e totalitarismo:
Proporre di mutare il paradigma memoriale dall’antifascismo all’antitotalitarismo e, nello stesso tempo, sostenere che il fascismo non sia stato un regime totalitario pare del tutto funzionale a riabilitare tout court il regime mussoliniano, e a ribaltare il verdetto che la storia della fine della Seconda guerra mondiale ha decretato.
In questo quadro è citato l’opaco incontro di Trieste del 1998 tra Violante e Fini. Giorgio Bocca lo commentò da fiero azionista:
La nostra storia è quella che è stata, non quella che farebbe comodo a uno che vorrebbe arrivare al Quirinale o a un altro che vorrebbe guidare il primo partito della destra. È davvero triste constatare che da questo penoso duetto l’ex fascista esce meglio dell’ex comunista[7].
In fin dei conti, dei due nessuno ebbe quello che voleva, ma il futuro brillante fu di Fini. Qui però ci vuole un accostamento fra quanto accaduto a Trieste nel 1998 e l’incontro, sempre a Trieste, di dieci anni dopo: quello del 2008 fra Berlusconi e Angela Merkel, in cui, già cominciata la crisi globale, furono poste le basi di una nuova sudditanza italiana.
Nel 2008 fu deciso anche come ostacolare il risarcimento dovuto alle vittime italiane di strage e deportazione durante la Seconda guerra mondiale. Si attuò un’operazione a tenaglia: da un lato un’azione legale tedesca, infondata e rovescista, davanti alla Corte internazionale di giustizia, per impedire la soddisfazione dei crediti sui beni di Stato della Repubblica federale; dall’altro l’avvio di una commissione mista di storici, finanziando con poco denaro tedesco iniziative culturali e fingendo che fossero risarcimenti. Da quel clima nasce il finanziamento, come detto, dell’Atlante delle stragi. Un caso di uso della storia politico, obliquamente giuridico e volutamente a scopo economico. Qui la scelta di fondo del volume rivela un limite notevole, e conferma che la separazione della memoria dalla giustizia non fa bene né all’una né all’altra. Una controprova? Immaginiamo crimini di oggi (in Ucraina, in Palestina, ovunque), trattati allo stesso modo fra molti anni: storici ucraini pagati dalla Russia, storici palestinesi pagati da Israele, per confezionare pignoli elenchi di stragi, con poca spesa, mentre i criminali sono rimasti impuniti e per le vittime e i familiari non ci sono stati risarcimenti; e tutto questo con applausi, felicitazioni nelle sedi culturali e ricevimenti nelle ambasciate.
Fra i punti più alti del libro, invece, l’ottima attualizzazione che tiene conto della posizione di Giorgia Meloni, ora alla presidenza del consiglio ma già prima ben presente: al momento dell’incontro di Trieste del 2008, per esempio, era nel governo. Adesso la presidente, quasi a tirare le fila, a raccogliere una rete già tesa, loda Violante, cita Del Noce e Galli della Loggia, ricorda la Osoppo, attinge al clima degli anni Novanta e piega tutto a suo uso. Sulla sua posizione, Gramigni osserva:
Non solo contiene una lettura distorta della storia ma chiarisce anche qual’è l’orizzonte cui guarda questa destra: non più tanto la legittimazione del fascismo-regime, quanto la riabilitazione del fascismo saloino e della sua eredità raccolta dal neofascismo italiano[8].
Partigiano, portami via ha qualche limite, perché tratta la questione memoriale e le sue manipolazioni staccandola troppo dal resto. Ma anche così, è bene frequentare questo libro robusto e orientato, per aprire certe sottocartelle crittate, che hanno l’etichetta ingannevole e sono piene di cose interessanti sul presente.
[1] Paola Gramigni, Partigiano, portami via. La stampa e l’uso politico della Resistenza, con prefazione di Lidia Piccioni, L’asino d’oro edizioni, Roma 2025, pp. 79-85.
[2] Ivi, pp. 80-81, nota 80.
[3] Ivi, p. 82, nota 83.
[4] Ivi, p. 50.
[5] Leonardo Paggi (a cura di), La memoria del nazismo nell’Europa di oggi, La Nuova Italia, Firenze 1997.
[6] Raffaele Romanelli, Claudio Pavone. Storia e diritto, in Marcello Flores (a cura di), Mestiere di storico e impegno civile. Claudio Pavone e la storia contemporanea in Italia, viella, Roma 2019, pp. 22-23.
[7] Gramigni, Partigiano, portami via, cit., p. 146, che cita Giorgio Bocca, Violante e Fini rimandati in storia, «la Repubblica», 15 marzo 1998.
[8] Gramigni, Partigiano, portami via, cit., p. 152.



