di Gioacchino Toni
 Tra i saggi che compongono il volume curato da Anna Chiara Corradino e Serena Guarracino, L’estasi del martirio. Metamorfosi del piacere e del dolore nell’esperienza estetica (Mimesis, 2025), dedicato alla rappresentazione moderna delle pratiche BDSM e delle dinamiche di potere ad esse correlate, il contributo di Mirko Lino, Il corpo agonico e agonistico nel rape and revenge movie. I Spit on Your Grave (1978) e Revenge (2017), affronta la rappresentazione del corpo della final girl nel genere rape-revenge.
Tra i saggi che compongono il volume curato da Anna Chiara Corradino e Serena Guarracino, L’estasi del martirio. Metamorfosi del piacere e del dolore nell’esperienza estetica (Mimesis, 2025), dedicato alla rappresentazione moderna delle pratiche BDSM e delle dinamiche di potere ad esse correlate, il contributo di Mirko Lino, Il corpo agonico e agonistico nel rape and revenge movie. I Spit on Your Grave (1978) e Revenge (2017), affronta la rappresentazione del corpo della final girl nel genere rape-revenge.
Associato ai film di exploitation che hanno conosciuto un certo successo negli anni Settanta del secolo scorso, tale genere è solitamente caratterizzato da prodotti di scarsa qualità, da scene di cruda e insistita violenza e dal ricorso a uno schema narrativo di causa-effetto piuttosto semplice: al violento stupro subito da una donna nella parte centrale del film fa seguito un’altrettanto violenta vendetta condotta dalla donna stessa o da una persona ad essa legata.
Last House on the Left (L’ultima casa a sinistra, 1972) di Wes Craven e I Spit on Your Grave (Non violentate Jennifer, 1978) di Meir Zarchi, secondo lo studioso, rappresentano il modello formale su cui si è consolidato il genere rape-revenge. In tali film la visione e la condotta moderna-progressista delle giovani donne entra in collisione con un retrogrado conservatorismo maschilista che giunge a manifestarsi attraverso la violenza sessuale a cui, in alcuni casi, segue l’omicidio. Maggiori sono le violenze e le umiliazioni subite dalla vittima, maggiore sarà agli occhi degli spettatori la legittimazione della violenza a cui potrà ricorrere la sua vendetta.
Se, come nel caso di I Spit on Your Grave, la vendetta è consumata direttamente dalla vittima, così come se fosse attuata da un’altra donna, si può parlare di “rivendicazione femminista”, mentre nel caso, come in Last House on the Left, spetti a un uomo il ruolo di vendicatore, allora si dovrebbe parlare di un’istanza di “riaffermazione maschile/patriarcale”.
A partire da tali modelli, il binomio “stupro-vendetta” è stato costantemente riarticolato nel corso del tempo, come dimostrano i remake delle pellicole degli anni Settanta di Craven e Zarchi, realizzati rispettivamente da Dennis Iliadis nel 2009 e da Steven R. Monroe nel 2010, che hanno proposto attualizzazioni in linea con il torure porn del nuovo millennio che, almeno nel cinema più convenzionale, in linea con l’immaginario statunitense post 11 settembre, tende a proporre una violenza vendicativa amplificata.
Nuove modalità di sviluppo del rape and revenge caratterizzano invece alcuni film associabili al Feminist New Wave Cinema, come Revenge (2017) di Coralie Fargeat e Promising Young Woman (Una donna promettente, 2020) di Emeral Fennel, opere che decostruiscono il modello del genere a partire dai suoi meccanismi voyeuristici. In questi casi, infatti, la rappresentazione violenta dello stupro, spesso sfumata, tende a farsi metafora di una più generale e diffusa propensione allo sfruttamento maschile del corpo e dell’identità femminile oltre l’atto dello stupro.
Al fine di comprendere l’evoluzione narrativa ed estetica del rape and revenge movie, lo studioso indaga la «costruzione del mito cinematografico della vendicatrice femminista» approfondendo la «rappresentazione del corpo agonico della vittima e del suo riscatto agonistico attraverso la vendetta», guardando dunque come l’estetica del martirio nel rape and revenge movie rappresenti «una condizione necessaria per la re-iscrizione sul corpo femminile dei discorsi politici sui generi sessuali» (p. 161).
L’autore propone dunque un’analisi comparata tra I Spit on Your Grave (1978) di Meir Zarchi, come esempio di cruda rappresentazione della violenza carnale anni Settanta, e Revenge (2017) di Coralie Fargeat, primo rape and revenge movie girato da una donna regista collocabile nell’ambito della recente Feminist New Wave Cinema in cui la vendetta prende di mira, oltre gli uomini che hanno materialmente commesso il crimine, la rape culture propria della società patriarcale.
Nonostante i due film appartengano a periodi storici così distanti, entrambi mostrano i corpi delle protagoniste ricoperti di sangue, lividi, ferite e posture che richiamano la simbologia cristologica della passione che però sviluppa una rigenerazione corporea e identitaria della vittima in carnefice.
Il film di Zarchi, nella parte centrale, mette gli spettatori di fronte a una cruda e prolungata sequenza che mostra lo stupro inflitto in un paesaggio agreste a una giovane ed emancipata ragazza proveniente dalla città ad opera di un gruppo di retrogradi abitanti di una comunità rurale, mostrando così come la contrapposizione uomo/donna si carichi, qui, anche dell’opposizione rurale/cittadino, leggibile come scontro tra un immaginario progressista emancipato e uno retrogrado e conservatore.
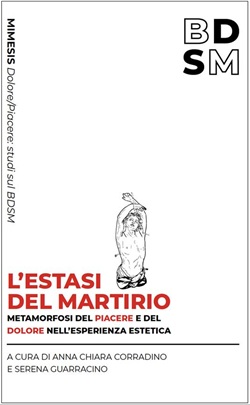 In generale le scelte stilistiche adottate da Zarchi ribadiscono la crudeltà della violenza esibita piuttosto che indurre a un’identificazione del pubblico con la vittima. «Nonostante le scene di sesso siano caratterizzate dalle pose e dai movimenti innaturali dei violentatori, che non nascondono affatto la simulazione, tutta la sequenza è impregnata di un disturbante eccesso di realismo, dato dall’assenza di artifici filmici» (p. 164). L’assenza di stilizzazione «mostra lo stupro nella sua radicale essenza punitiva, il cui fine è quello di riportare la donna alla più totale passività, di mantenere il potere sessuale attraverso l’umiliazione fisica e zittire la minaccia della sua insubordinazione sociale e culturale» (p. 165).
In generale le scelte stilistiche adottate da Zarchi ribadiscono la crudeltà della violenza esibita piuttosto che indurre a un’identificazione del pubblico con la vittima. «Nonostante le scene di sesso siano caratterizzate dalle pose e dai movimenti innaturali dei violentatori, che non nascondono affatto la simulazione, tutta la sequenza è impregnata di un disturbante eccesso di realismo, dato dall’assenza di artifici filmici» (p. 164). L’assenza di stilizzazione «mostra lo stupro nella sua radicale essenza punitiva, il cui fine è quello di riportare la donna alla più totale passività, di mantenere il potere sessuale attraverso l’umiliazione fisica e zittire la minaccia della sua insubordinazione sociale e culturale» (p. 165).
Una volta subita violenza, in I Spit on Your Grave, la protagonista si trova a dover ricomporre il corpo martoriato per potersi trasformare in vendicatrice: il corpo agonico, messo in scena senza artifici filmici, si trasforma dunque in corpo agonistico votato a una vendetta che invece ricorre ad artifici filmici. «L’esplosione di violenza finale segna dunque il percorso di trasformazione, dalla passività della vittima femminile all’azione castratrice della vendicatrice femminista. La ragazza diventa un’icona modellata sulle aspirazioni e sui discorsi del femminismo della seconda ondata applicati al cinema di exploitation» (pp. 167-168).
Per quanto Revenge riprenda il modello della vendicatrice del film di Zarchi, ne rovescia l’impianto narrativo concedendo maggiore attenzione alla vendetta piuttosto che allo stupro. Quest’ultimo viene decisamente diluito attraverso artifici formali e simbolici sottraendolo all’osservazione voyeuristica dello spettatore conferendo così maggiore importanza alla rinascita corpo-identitaria della vittima.
Tramite una stilizzazione gore del martirio, nel film di Coralie Fargeat la figura della donna «si trasforma radicalmente, assumendo la morfologia di una guerriera femminista, di cui viene esibita tutta l’inesauribile resistenza del corpo» (169). Non più oggetto ipersessualizzato ma soggetto guerriero femminista e così lo schema proposto dalla regista converte lo schema stupro-vendetta in morte-resurrezione.
A riprova di come in Revenge la vendetta della donna, oltre a scatenarsi contro chi ha materialmente commesso lo stupro, prenda di mira più in generale la mentalità maschilista, oltre alla denuncia della complicità tra uomini dei personaggi maschili del film, provvedono simbolicamente la sequenza in cui la protagonista cava letteralmente gli occhi a uno degli aguzzini, come atto di ribellione allo sguardo voyeuristico maschile, e la scena in cui la donna fa saltare le cervella di un altro uomo, che allude evidentemente alla necessità di distruggere l’immaginario con cui gli uomini guardano alle donne.
La protagonista del film, sottolinea lo studioso, non subisce un processo di mascolinizzazione, bensì accetta lo scontro sul territorio della mascolinità per smantellarne il mito. «Ai corpi ipertrofici degli action heroes del passato, alle gonfie geometrie muscolari dei vari ‘Rambo’ e ‘Commando’, Revenge contrappone l’ipersessualizzazione dell’eroina e la sua irriducibile tenacia vendicativa» (p. 171). Non a caso alla reincarnazione della violentata corrisponde la progressiva de-virilizzazione del violentatore.
Mentre in I Spit on Your Grave la vendetta della protagonista «poggia sulla lascivia dell’incontro tra eros e thanatos e insiste su un’iconografia prossima ad alcuni mitologemi classici del femminile», la protagonista del rape-revenge movie del nuovo millennio «infiamma la rivincita del genere femminile portando allo stremo l’inesauribilità dei corpi, ed esibisce con la lente dell’eccesso del gore lo smembramento del machismo intrinseco al cinema action. Questa fantasia sanguinolenta si fa allora portavoce del desiderio di giustizia sociale rispetto allo stupro e a ogni forma di sfruttamento psicologico della vittima femminile» (p. 172).
Appropriandosi dei miti del cinema pop, il film di Coralie Fargeat «riflette una visione critica al modello di empowering postfemminista tipico di quella che Ariel Levy ha definito raunch culture [Female Chauvinist Pigs, Free Press 2005]: la tendenza alla condivisione di atteggiamenti che incentivano l’ipersessualizzazione come strategia di autoaffermazione femminile» (pp. 173-174).



