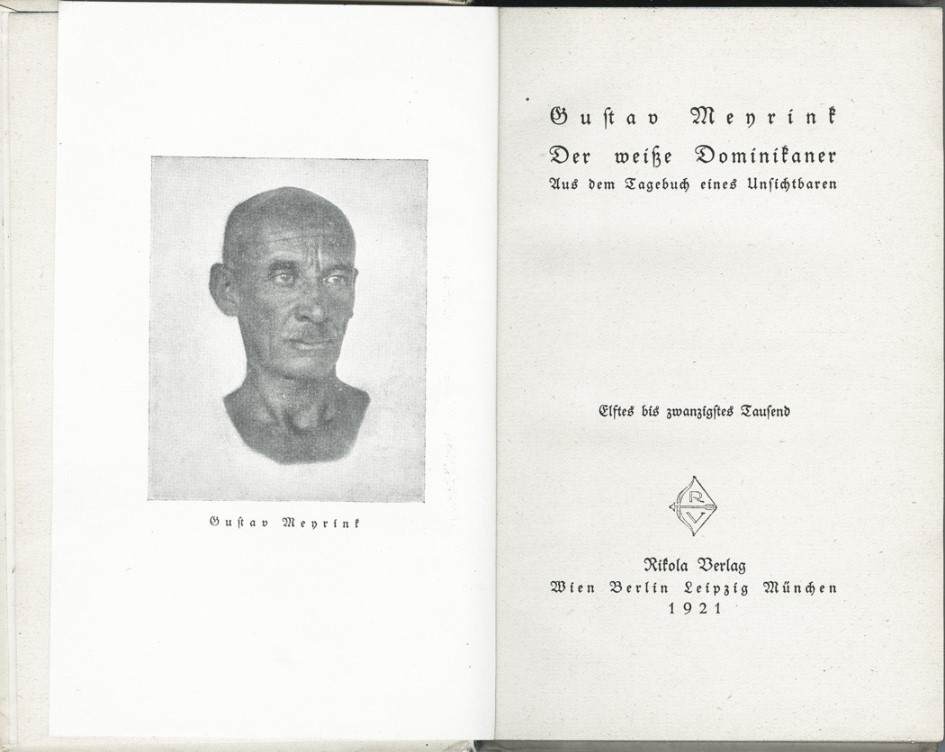di Franco Pezzini
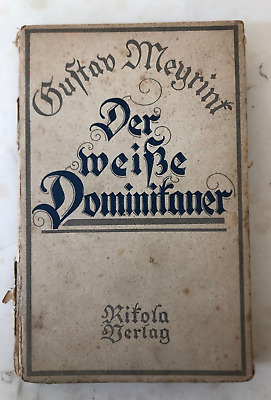 (Per le parti precedenti, cfr. qui)
(Per le parti precedenti, cfr. qui)
Per amare Ofelia (1921)
Come al solido Il golem è seguito il sapienziale e meno letterariamente compatto Il volto verde, così al romanzesco La notte di Valpurga segue ora il più straniatamente iniziatico Il domenicano bianco – forse meno fluido sul piano narrativo ma considerato da qualche critico come il più profondo, il più esoterico e il più “autentico” dei romanzi dell’autore. Sicuramente un testo di grande suggestione espressionista, e che trasfonde in un contesto mitteleuropeo provocazioni stavolta del remoto Oriente. Ora la tradizione sapienziale scelta da Meyrink e liberamente, entusiasticamente richiamata è il taoismo, sia pure (come al solito) entro un tessuto di forte sincretismo: si tratta di nuovo d’una storia di iniziazione e – marginalmente – d’amore.
La tecnica di Meyrink nei suoi romanzi consisteva invariabilmente nel trovare innanzitutto una base storica al suo racconto. Nel caso che abbiamo sott’occhio, la storia del Domenicano bianco è costruita intorno ad articoli pubblicati da un sinologo austriaco oggi dimenticato, il professor Pfitzmaier, scienziato erudito e molto versato nello studio del taoismo [ci si riferisce plausibilmente al linguista, sinologo e jamatologo austriaco August Pfitzmaier, 1808-1887]. Può forse rivestire un qualche interesse l’accennare al fatto che il buon professore […] fu delicatamente pregato di scegliersi per il futuro altri argomenti; il che spiega come mai gli articoli scritti in seguito da Pfitzmaier trattassero problemi assolutamente differenti. La sua epoca e il suo ambiente non erano maturi per gli insegnamenti del Tao; ed i suoi articoli venivano giudicati un po’ troppo fantasiosi.
In ogni caso, Meyrink ebbe occasione di leggere alcuni degli articoli di Pfitzmaier e vi scorse immediatamente la possibilità di trarne un romanzo. Amici di Meyrink mi hanno detto sino a che punto egli si fosse entusiasmato per la lettura degli articoli, al punto tale che si sentì immediatamente in dovere di cercar di entrare in contatto tramite la chiaroveggenza con l’antica tradizione del Tao. Fece ancora di più: riuscì a identificarvisi al punto di esser capace di penetrare i segreti di quella tradizione e di integrarsi nel suo solco. [Gérard Heym, “Il domenicano bianco”, in AA. VV., Meyrink scrittore e iniziato, cit.].
Der weiße Dominikaner (Il domenicano bianco, Rikola Verlag, Vienna 1921) inizia con una suggestiva introduzione proprio sul piano della scrittura. Riflettendo su quei casi in cui l’immaginazione rifiuta di seguire la traccia che il narrante vorrebbe percorrere, per esempio a proposito del nome del protagonista, come se una sorta di antenna del telegrafo mentale cogliesse “altro”. Come nel caso di chi si è alzato durante il sonno per delineare soluzioni narrative non raggiunte in stato di veglia, e che a quel punto crea sonnambulicamente: si parla di risveglio dell’inconscio, ma se succedesse a Lourdes verrebbe ravvisato un intervento della Madonna. “Ciò non significa che la Madre di Dio non sia altro che l’inconscio, no, l’inconscio è la ‘Madre’ di ‘Dio’”. Così per il protagonista della storia che qui si dipana, Christopher Taubenschlag cioè Cristoforo Colombaia: il narratore è convinto che sia esistito davvero, il nome si è insinuato nella storia che sta scrivendo e che si trasforma in una sorta di lotta con Colombaia. Si domanda dunque il perché di tale intromissione, del resto Colombaia potrebbe impadronirsi in futuro della mano d’un altro. Una forza disincarnata che vuole assumere aspetto umano? Una sorta di Io scisso dello scrittore? Una figura sorta nel suo inconscio per autonomizzarsi? Colombaia stesso risponde, usando qualcosa come la scrittura automatica, ma dandogli del Lei in tono beffardo: non è forse lo scrittore stesso una “scissione di quel Grande Io che si chiama Dio?”. E un successivo messaggio confonde ancor più lo scrivente: “Ogni individuo è una ‘Colombaia’, ma non tutti sono dei ‘Cristofori’. La maggior parte dei cristiani si illude soltanto. Nel vero cristiano le colombe bianche entrano ed escono in volo”. Da allora lo scrittore rinuncia a risolvere il mistero: Colombaia potrebbe essere una sua precedente incarnazione, ma preferisce pensare che a guidargli la mano sia stata una forza libera da strutture e forme, che immagina come un vecchio alto di aspetto giovanile. Qualcuno che vive – in fondo come Pernath e Hauberrisser al termine dei rispettivi itinerari – “al di là del tempo e dello spazio”, e che al sopraggiungere della morte dello scrittore coglierà il retaggio di quella vita. E passa al racconto di Colombaia…
 Così si chiama il narrante del romanzo, nel senso che in città tutti lo chiamano così: dai ragazzini che lo precedono per le strade cantilenando il suo nome quando accende i lampioni, agli adulti. Diverso è il caso del nome Cristoforo, vergato su un foglietto appeso al suo collo quando da bambino era stato trovato abbandonato davanti alla Chiesa di Santa Maria. Costruita, si dice, dal domenicano Raimondo di Pennaforte: e sull’altare è la scritta “Flos florum – come tale mi manifesterò fra trecento anni”. La tavoletta colorata che vi hanno inchiodato sopra si stacca e cade, ogni anno, sempre il giorno della festa di Maria. Ma in certe notti di luna piena, la chiesa proietta un’ombra bianca che è quella stessa di Pennaforte, il Domenicano Bianco.
Così si chiama il narrante del romanzo, nel senso che in città tutti lo chiamano così: dai ragazzini che lo precedono per le strade cantilenando il suo nome quando accende i lampioni, agli adulti. Diverso è il caso del nome Cristoforo, vergato su un foglietto appeso al suo collo quando da bambino era stato trovato abbandonato davanti alla Chiesa di Santa Maria. Costruita, si dice, dal domenicano Raimondo di Pennaforte: e sull’altare è la scritta “Flos florum – come tale mi manifesterò fra trecento anni”. La tavoletta colorata che vi hanno inchiodato sopra si stacca e cade, ogni anno, sempre il giorno della festa di Maria. Ma in certe notti di luna piena, la chiesa proietta un’ombra bianca che è quella stessa di Pennaforte, il Domenicano Bianco.
In senso proprio, il personaggio eponimo sarebbe dunque un monaco occidentale, identificabile nel canonista Raimon di Penyafort (c. 1175 circa – 1275), religioso dell’Ordine domenicano e giurista spagnolo, proclamato santo da papa Clemente VIII nel 1601 e assurto a patrono dei canonisti. Un personaggio un po’ misterioso: volendo far conoscere di sé il meno possibile, nascose ogni documento relativo alla sua nascita. Visto che le cronache coeve attestano la sua morte intorno ai cent’anni, doveva essere nato intorno al 1175. Eppure al domenicano biancovestito si sovrappone oniricamente nel romanzo un altro profilo monastico.
Numerose biografie dei grandi maestri del Buddhismo mahayâna, e la storia di numerosi monasteri del Tibet, menzionano i “Monaci bianchi”. Questi monaci – perché tali erano effettivamente – appartenevano a un ordine la cui origine è poco nota, ma potrebbe situarsi in Persia o nel nord dell’India, ed esercitarono una profonda influenza in tutti i paesi ove veniva praticato il Buddhismo mahayâna […] Trasformarono la forma prima del buddhismo in ciò che oggi chiamiamo il Buddhismo mahayâna. Erano i più grandi maestri di conoscenza esoterica che mai la storia dell’umanità abbia conosciuto. Erano i Grandi Istruttori, di cui si parlava con la massima venerazione; può darsi che Meyrink abbia pensato a quei monaci quando concepì il personaggio o il ritratto psichico del Domenicano bianco: un monaco che avrebbe raggiunto il grado più alto dell’iniziazione, uno dei “Monaci bianchi” che avrebbero lasciato la terra mantenendo però un corpo psichico immortale. [Gérard Heym, “Il domenicano bianco”, in AA. VV., Meyrink scrittore e iniziato, cit.].
Il piccolo Cristoforo, finito all’orfanotrofio, a dodici anni deve affrontare la prima confessione. Come apprenderà però con spavento il cappellano, a ricevere la confessione del ragazzino è un misterioso monaco bianco che gli chiede il nome – ma la prima volta il piccolo non sa rispondere, la seconda dimentica il nome prima di pronunciarlo e alla terza agitatissimo il nome Cristoforo viene come buttato fuori da una voce interiore. Il monaco misterioso lo annota allora nel Libro della Vita e gli rimette i peccati passati e futuri.
Il Domenicano bianco è, da un certo punto di vista, alla base di tutta la storia nel romanzo; è lui a scrivere nel Libro della Vita il nome del bambino – Cristoforo Colombaia – che è destinato a diventare un iniziato, il che è indispensabile per chiunque debba impegnarsi nella via del Tao. Secondo la leggenda cinese, si trova sempre, all’inizio della vita del candidato, qualcuno che lo informa del destino futuro, anche se egli è troppo giovane per comprenderlo. [Gérard Heym, “Il domenicano bianco”, in AA. VV., Meyrink scrittore e iniziato, cit.].
Quella notte il ragazzino esce e rientra misteriosamente dall’orfanotrofio (è in sostanza sonnambulo), riportandovi fiori alpini raccolti sui monti: ma al ripetersi più volte dell’episodio i responsabili lo puniscono a botte senza capire dove sia stato.
Un giorno Cristoforo si reca al monastero dal cappellano e vi trova un anziano signore che poi lo adotterà: e lo conduce a casa propria, dove sul portone campeggia il nome “Barone Bartolomeo von Jöcher, lampionaio onorario”. Il ragazzino non capisce come un nobile possa fare il lampionaio, scoprirà che un antenato lo era stato e in seguito era stato elevato di rango: non tutti i membri della famiglia avevano materialmente esercitato tale attività, ma il ragazzino dall’indomani dovrà svolgere quel ruolo umile assumendosene la responsabilità. Accesi i lampioni la sera, dovrà spegnerli al mattino.
Il barone presenta un enorme gozzo sul lato sinistro del collo, sotto la barba, ma anche un’aria da fanciullo inerme. Nella grande casa semivuota al limite di una città non nominata, ma circondata da un fiume come da un cappio (si tratta di una versione misticamente trasfigurata della città bavarese di Wasserburg am Inn), il vecchio e il ragazzino vivono in un paio di stanze sotto il tetto. La prima sera il barone raggiunge il ragazzino, per insegnargli a pregare: non con le parole, ma con le mani giunte, per lasciar sprigionare una fiamma dalla punta delle dita… e il mattino successivo, pur avendo vagato nel sonno, non si ritrova a letto vestito e con gli stivali impolverati.
La descrizione della casa […] è interessante: è un mandala della famiglia […] verso l’iniziazione finale quale viene realizzata da Cristoforo Colombaia in persona. Il suo sonnambulismo indica che il corpo psichico è già nettamente staccato dall’involucro fisico; senza questo fenomeno non sarebbe possibile giungere ad un elevatissimo grado di iniziazione su questa via. [Gérard Heym, “Il domenicano bianco”, in AA. VV., Meyrink scrittore e iniziato, cit.].
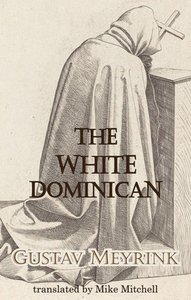 La casa si trova all’inizio di Via dei Fornai; quella vicina è (recita l’insegna) la “Fabbrica dell’ultimo riposo” di Adone Mutschelknaus, un artigiano un tempo definito sull’insegna “Maestro tornitore e fabbricante di casse da morto”. La domenica è uso recarsi in chiesa con la moglie Aglaja e la figlia Ofelia – che a Cristoforo piace fino a fargli palpitare il cuore. La descrizione di Adone – barba rossastra, naso adunco e aureola di capelli sul cranio calvo tale da dar l’impressione che “sia passato attraverso un vello rognoso e abbia dimenticato di pulire i pezzi rimastigli appiccicati” richiama ai profili grotteschi dei racconti di Meyrink. Il ronzio del suo tornio echeggia ogni giorno, e una sera il tornitore supplica Cristoforo di non accendere il lampione lì sotto. Per l’onore della sua consorte e la carriera di sua figlia come artista, nessuno deve vedere cosa ritirerà da lui un cliente quella notte. Ci si attenderebbe qualche scoperta scandalosissima, ma il ragazzino – non dovrà raccontare nulla al barone – si trova coinvolto nel caricare nottetempo su un carro banali gerle di coperchi di legno.
La casa si trova all’inizio di Via dei Fornai; quella vicina è (recita l’insegna) la “Fabbrica dell’ultimo riposo” di Adone Mutschelknaus, un artigiano un tempo definito sull’insegna “Maestro tornitore e fabbricante di casse da morto”. La domenica è uso recarsi in chiesa con la moglie Aglaja e la figlia Ofelia – che a Cristoforo piace fino a fargli palpitare il cuore. La descrizione di Adone – barba rossastra, naso adunco e aureola di capelli sul cranio calvo tale da dar l’impressione che “sia passato attraverso un vello rognoso e abbia dimenticato di pulire i pezzi rimastigli appiccicati” richiama ai profili grotteschi dei racconti di Meyrink. Il ronzio del suo tornio echeggia ogni giorno, e una sera il tornitore supplica Cristoforo di non accendere il lampione lì sotto. Per l’onore della sua consorte e la carriera di sua figlia come artista, nessuno deve vedere cosa ritirerà da lui un cliente quella notte. Ci si attenderebbe qualche scoperta scandalosissima, ma il ragazzino – non dovrà raccontare nulla al barone – si trova coinvolto nel caricare nottetempo su un carro banali gerle di coperchi di legno.
Il laboratorio, dov’è pronta un po’ di birra per dissetare anche il ragazzino (che Adone tratta come un uomo adulto), è ingombro tra statue, bare, un ritratto nudo della moglie del tornitore da giovane, anche di polli e conigli. Ma nelle giustificazioni di quell’uomo compulsivamente agitato al far rilevare la propria povertà, il ragazzo è colto da un sottile orrore. Adone, la cui memoria si accende e si spegne, si presenta come un idiota, impazzito quando il padre per punirlo l’aveva chiuso per ventiquattr’ore in una bara di metallo: e nei fatti la sua è una mente disturbata, con un laboratorio come un baraccone da film espressionista e racconti personali dove realtà, manipolazione subita e fantasia sembrano mixarsi. Parla del regista Paride che dà lezioni di recitazione a sua figlia, ma già era stato direttore artistico di sua moglie e anzi aveva favorito il loro matrimonio; di Aglaja che l’aveva sposato sacrificando tutto, perché commossa dalla desolazione del poverino alla morte del padre (sì, il tiranno psicopatico che aveva sepolto vivo il figlio traumatizzandolo per sempre), ma che prima aveva avuto successo ed era stata sul punto di diventare regina in Arabia; di Ofelia nata prodigiosamente dopo soli sei mesi di gravidanza; del professor Amleto, fratello di latte di Paride e autore di un dramma che Ofelia dovrebbe interpretare – l’Amleto di Shakespeare trasfigurato nella follia o un sottoprodotto onirico di questo “professor Amleto” (se davvero esiste). Il fatto è che nel dramma Ofelia dovrebbe morire annegata, il padre non lo accetta e dunque cerca di far cambiare il finale – dietro rilascio di un titolo di credito all’autore… Insomma un intero teatro del delirio, ben raccordabile al mondo sovraeccitato dei racconti ma più in generale a un intero orizzonte di fantasie espressioniste tra delirio e follia.
 La notte Cristoforo sogna di essere sepolto vivo, con mani e piedi bloccati, ma di riuscire a far saltare il coperchio della bara gonfiando il petto (più Tarantino che Dreyer, insomma, anche se è inevitabile pensare alle scene del Vampyr). Si ritrova allora “su un bianco e solitario sentiero di campagna” senza fine, così lui torna a desiderare di rientrare nella bara. Che però ora è disturbantemente “morbida al tocco come carne e aveva braccia e gambe, mani e piedi come un cadavere”: viene da pensare a certe trovate di opere del surrealismo pittorico, Leonora Carrington o Remedios Varo. Quando poi sta per rientrarvi, Cristoforo si accorge di non proiettare ombra e anzi di non avere neppure corpo: e al chiudersi del coperchio sulla bara ha la sensazione di svegliarsi. Ma è ora, gli pare, di andare a spegnere i lampioni, per cui provvede; tornando, poi, ha la sensazione di salire su una montagna; e solo rientrando in città si accorge di tornare ad avere un’ombra. Peccato che i bambini in strada non lo notino, che lo attraversino come una bolla d’aria, e oltretutto il giorno prima era inverno – ora sembra estate… Le immagini richiamano da vicino quelle dei trucchi scenici dei film espressionisti.
La notte Cristoforo sogna di essere sepolto vivo, con mani e piedi bloccati, ma di riuscire a far saltare il coperchio della bara gonfiando il petto (più Tarantino che Dreyer, insomma, anche se è inevitabile pensare alle scene del Vampyr). Si ritrova allora “su un bianco e solitario sentiero di campagna” senza fine, così lui torna a desiderare di rientrare nella bara. Che però ora è disturbantemente “morbida al tocco come carne e aveva braccia e gambe, mani e piedi come un cadavere”: viene da pensare a certe trovate di opere del surrealismo pittorico, Leonora Carrington o Remedios Varo. Quando poi sta per rientrarvi, Cristoforo si accorge di non proiettare ombra e anzi di non avere neppure corpo: e al chiudersi del coperchio sulla bara ha la sensazione di svegliarsi. Ma è ora, gli pare, di andare a spegnere i lampioni, per cui provvede; tornando, poi, ha la sensazione di salire su una montagna; e solo rientrando in città si accorge di tornare ad avere un’ombra. Peccato che i bambini in strada non lo notino, che lo attraversino come una bolla d’aria, e oltretutto il giorno prima era inverno – ora sembra estate… Le immagini richiamano da vicino quelle dei trucchi scenici dei film espressionisti.
Avendo filosoficamente concluso di essere morto, Cristoforo decide di tornare a casa a deporre la verga del lampionaio prima di imputridire. Il barone però lo vede, e indicando i fiori che ha in tasca gli domanda se sia stato sulla montagna: è bello, anche lui ci va. Del resto anche il ragazzo c’era già stato, solo non lo ricorda – si è stancato? In montagna no, risponde il ragazzo, ma era faticosa la strada bianca di campagna. Già, concorda il barone, difficile sopportarla: “La maggior parte degli uomini ha più paura di questa strada di campagna che della tomba” dove credono di trovare pace. Ma quella bara è il corpo, la vita, e nascere sulla terra è venire sepolti vivi. Mentre la strada bianca è senza fine, e il sole sul monte è eterno. “Eternità e infinito sono due cose diverse. Solo per colui che cerca l’eternità nell’infinito e non la ‘fine’, solo per costui infinito ed eternità sono la stessa cosa”. E la pace è soltanto nel sole lassù: il ragazzo non ha visto il sole sul monte, è sceso prima dell’alba, con l’ombra che lo precedeva verso la valle. Allora il barone spiega che chi scorga il sole cerca solo l’eternità ed è perduto per le peregrinazioni – come i Santi della chiesa, che il mondo perde restando orfano; mentre lui lo esorta a proseguire il suo peregrinare. Ma il fatto che il ragazzo si fosse ricoricato nella bara significa per un po’ di tempo dovrà ancora condividere la sorte dei sepolti vivi. Il barone non mostra di conoscere il vicino tornitore, ma spiega di essere anche lui “in parte sepolto vivo”. Ha sentito uomini lamentarsi dell’ingiustizia del destino cercando consolazione nella dottrina orientale del Karma o in una imperscrutabile volontà divina, ma senza trovarla… “Non attribuire tanta importanza alla vita, ma considera i sogni in modo più serio, allora le cose si semplificheranno, allora il sogno diventerà la tua Guida, invece di rimanere un buffone in abiti arlecchineschi avvolto in quegli stracci che sono i ricordi del giorno”. E lo esorta a considerare che “Non esistono spazi vuoti” e se, a fronte del desiderio di peregrinare, la terra imprigiona i piedi, tuttavia lo spirito creatore “troverà altre vie, e ciò che in lui non ha bisogno di piedi per camminare, andrà avanti a dispetto della terra, a dispetto degli ostacoli”. Se la forza aspirante del retaggio divino dell’uomo manifestasse una volontà e non riuscisse a concretizzarla lascerebbe “uno spazio vuoto nel Regno delle Cause!”. Come un malato guarisce meglio e più velocemente per forza dello spirito che con le medicine – e la malattia è una sfida a cacciarla con la forza dello spirito, a tornare padrone della materia come prima del peccato originale – così ogni evento della vita ha uno scopo grande, di far risorgere ogni volta fino a divenire Re. Anche la morte, come il sonno, è solo una breve sosta. Un lavorio avviato va portato a compimento. “Noi viviamo soltanto affinché la nostra anima raggiunga la perfezione”: chi si manterrà fermo su tale obiettivo sarà partecipe di una pace singolare,
e il suo destino muterà in maniera incomprensibile. Per colui che agirà come se fosse immortale, non per conquistare quanto desidera – questo è un obiettivo per coloro che spiritualmente sono ciechi – bensì per erigere un tempio alla propria anima, costui, anche se dovesse aspettare migliaia di anni, vedrà sorgere il giorno in cui potrà dire: io voglio e ciò che voglio apparirà, si manifesterà senza bisogno di attendere il tempo di una lenta maturazione.
Allora sarà giunto il momento in cui avrà termine il lungo cammino di peregrinazione. A quel punto potrai guardare il sole in faccia senza bruciarti gli occhi. Potrai dire: ho raggiunto una meta perché non ne ho cercata alcuna.
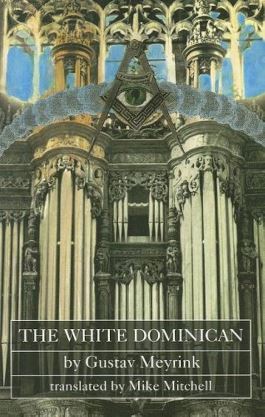 Il ragazzo per ora non capisce – capirà da adulto – ma resta perplesso notando che ora il barone ha il gozzo sul lato destro invece che sul sinistro: anche il busto di Dante sullo scaffale si trova a destra invece che a sinistra, e lui prende a notare con spavento come tutto sia irreale all’intorno… risvegliandosi agitato.
Il ragazzo per ora non capisce – capirà da adulto – ma resta perplesso notando che ora il barone ha il gozzo sul lato destro invece che sul sinistro: anche il busto di Dante sullo scaffale si trova a destra invece che a sinistra, e lui prende a notare con spavento come tutto sia irreale all’intorno… risvegliandosi agitato.
È ormai mattino, e scopre che il barone l’ha sostituto, per la prima volta da tanti anni, a spegnere i lampioni per lasciarlo riposare. Ovviamente il gozzo e anche il busto di Dante sono tornati ai loro posti… e il barone conosce il vicino tornitore e anche (lo osserva triste) la signorina Ofelia. Ma quando Cristoforo chiede perché nel sogno il barone avesse “la parte sinistra del collo girata dall’altra parte”, comincia ad abbozzare una spiegazione. “[…] imparare a sognare è il primo gradino della saggezza”, di lì viene anche l’arte vera: “Il sogno è il punto d’incontro tra lo stato di veglia e il sonno, ed è anche il punto d’incontro tra la vita e la morte”. Quanto a lui, non può arrivare a dire che lui e il suo doppio onirico siano la stessa persona, ma – diciamo – rispetto ad altri si trova più a suo agio in quella dimensione, dove è visibile e persistente pur non potendovi ancora appartenere del tutto perché ancora vivo nel mondo. Cristoforo poi non ha portato nel sogno il ricordo della forma del proprio corpo terrestre (infatti i bambini lo attraversavano come aria): chi ha le tecniche, può costruirsi lì un secondo corpo poi percepibile da altri, e può “evocare un fantasma”. Spesso chi diventa visibile nell’altro Regno manifesta però solo una parte di sé, come una mano fantasma. Ma solo entrambe le parti assieme formano un tutto, come solo Sigfrido sa unificare le due parti della propria spada spezzata. Il mondo terreno è un riflesso dell’altro, ciò che là è destra qui è sinistra. Però quanto ha appreso del sogno è frutto del sapere del Cristoforo che è nel ragazzo: il colloquio con il doppio del barone era in realtà un colloquio con se stesso.
Il narrante Cristoforo, con un sorriso, sta ora ricordando come reliquie i ricordi del proprio passato, ma su un elemento non può giocare come con altri: qualcosa da cui “si sprigiona la dolce forza seduttrice di Madre Terra, ed essa mira al mio cuore”. La porta con sé “come fosse una goccia di sangue del mio cuore coagulatasi in cristallo”: quella del “lasso di tempo che per me si chiama Ofelia e significa una breve primavera e un lungo autunno” dove ospita anche il sé d’un tempo, “per metà bambino per metà ragazzo”.
Con lo scarto di anni che permette di non essere più troppo coinvolto, rivede dunque la città fiorita dove lui dalla finestra aperta sente le voci dei vicini ripetere lo scambio teatrale: quella del padre – per Amleto – e della giovane Ofelia. Segue il silenzio, con i dubbi di lui (alla ringhiera delle scale, davanti alla finestra aperta) se Ofelia si affaccerà e se lui riuscirà a lanciarle una rosa: ma quando le tendine si aprono, è la madre Aglaja che si affaccia e lo scorge raccogliendo la rosa che lui ha troppo precipitosamente lanciato. Però in fondo questo permetterà a Cristoforo maggiore libertà.
In strada incontra quel grottesco figuro dell’attore Paride, grasso e col naso da avvinazzato. Questi cerca di avvicinarlo ma Cristoforo, che teme lui possa indovinare la sua missione al cimitero per rubarvi delle rose, scappa via.
All’alba ha spento i lampioni e si siede di nuovo sulla ringhiera: se si coricasse nel letto finirebbe con l’addormentarsi, e rischia di far cadere giù le tre rose bianche per la ragazza. Fantastica di precipitare lui stesso di sotto, e che lei giunga intenerita al suo capezzale a baciarlo… poi si vergogna sentendosi sciocco, “ma l’idea di soffrire per Ofelia gli appare dolce”. Ma Ofelia ha diciannove anni, lui due di meno: lo bacerebbe solo come un bambino ferito… no, punta a un’altra fantasticheria, un ipotetico incendio nella casa davanti. E lui, eroico, raggiunge l’amata dalla finestra salvandola mentre già giace a terra priva di sensi, e la copre di baci. Ma poi torna alla realtà: se le rose cadessero in strada? E se lei non individuasse che è lui a indirizzargliele? Ora oltretutto gli dispiace di averle rubate dal cimitero, tra l’altro bianche e non rosse…
Ma poi il sole sorge, lei compare, raccoglie le rose. Lui, travolto dal senso del ridicolo, fantastica di lanciarsi giù… ma poi i loro occhi si incontrano. “Entrambi vorremmo dire qualcosa e non possiamo, ognuno di noi vede che l’altro non osa”, poi Ofelia sparisce lasciando però a lui una enorme gioia. E sa che si incontreranno senza bisogno di dirselo, nel giardinetto di fronte alla casa.
Ora Cristoforo ricorda una conversazione colta la notte – lui stava sognando l’amata – tra il barone e il cappellano giunto a trovarlo. Parlano anche del tipo d’istruzione che Cristoforo dovrà ricevere. Non a scuola, dove il barone giudica si deformi l’intelletto “fino a far inaridire il cuore”: mentre a casa lo interpella su cosa lo interessi per sporgergli poi libri mirati. Ma poi non controlla che lui li legga davvero: ciò che lo spirito vuole resti impresso nella memoria lo rammenterà, “perché esso sarà fonte di gioia”. Il cappellano teme che un bambino lasciato così a se stesso finisca col naufragare, ma il barone obietta: “Come se la maggior parte degli uomini finisse diversamente”. E innalza un peana alla varietà e alla mancata uniformazione dei pensieri (in questo senso – ma è esplicito – va inteso qui il suo rifiuto dell’uguaglianza). Poi, lui che aveva insegnato a Cristoforo a pregare con le dita, torna ai gesti di mani e dita nell’Ultima cena di Leonardo:
Per ogni discepolo raffigurato, la missione cui è chiamata la sua anima è accennata simbolicamente dalle mani e dalle dita; tutti hanno la mano destra nell’atto di compier qualcosa, sia che posi sul tavolo […] sia che essa sia collegata con la mano sinistra. Solo nel caso di Giuda Iscariota è la sinistra a essere in movimento, mentre la destra è chiusa! Giovanni Evangelista, di cui Gesù disse che “sarebbe rimasto” – per cui tra i discepoli correva voce che non sarebbe morto – ha entrambe le mani giunte, ciò significa: egli è un magnete che non è più tale, è un anello nell’eternità, ha smesso di peregrinare.
Tali posizioni delle dita hanno un significato tutto particolare! Esse racchiudono i più profondi misteri delle religioni.
E il barone spiega come nella loro famiglia si tramandi la leggenda di una venuta dall’Oriente del capostipite, il lampionaio Cristoforo Jöcher, portatore del “segreto di evocare, per mezzo di una speciale articolazione delle dita, gli spettri dei defunti e di farli strumento del suo volere”. Sarebbe stato membro dell’antichissimo ordine detto ora Schi-Kiai, “il dissolvimento con il cadavere”, ora Kieu-Kiai, “il dissolvimento con la spada”. Nel senso che “per mezzo della capacità di rendere spiritualmente vive le mani e le dita, gli adepti dell’Ordine sarebbero spariti dalla tomba insieme al proprio cadavere e altri si sarebbero trasformati nella terra in spade”. Quando però cita un’ipotetica somiglianza tra questo e la Resurrezione di Cristo il cappellano obietta che vi vede piuttosto un carattere massonico – del resto i grandi artisti erano uniti da vincoli corporativi portatori di segni segreti come posizioni delle dita e gesti della mano dei loro personaggi, o per altre scelte tematiche (configurazione delle nubi, scelta dei colori). Per quanto la Chiesa ottenesse in parecchi casi il giuramento che si astenessero dall’usare tali simboli, spesso gli artisti lo eludevano. La convinzione che l’arte sia creatura del diavolo andrebbe intesa proprio in riferimento a simili segreti antiecclesiali: e un grande pittore confessava a “un amico spagnolo l’esistenza di un vincolo segreto”. Il barone conferma, conosce quella lettera: ma anche se dotato di un alto grado di iniziazione, quell’artista era solo un cieco. Sicuramente massone, nel senso di muratore della corporazione, ma massoni saranno poi architetti, pittori, scultori, orefici, cesellatori: “conoscevano solo i riti esteriori che comprendevano unicamente in senso etico”. Insomma non c’entrava il potere della Mano Sinistra: dovevano solo custodire certi segreti in forma simbolica, finché i tempi non fossero diventati maturi. Però nessuno di loro riusciva ad procedere avanti in un’iniziazione o a ricevere spiegazioni, perché la
chiave è nascosta nella pratica dell’arte stessa. Essi non capirono che l’arte cela un senso più profondo che dipingere semplicemente immagini o creare opere poetiche, e cioè quello di risvegliare nell’artista stesso una sorta di straordinaria sensibilità tattile e percettiva, che in primo luogo si manifesta come “giusto senso dell’arte”. Anche oggi un artista, nella misura in cui il lavoro gli ha risvegliato i sensi interiori, potrà resuscitare quei simboli nelle sue opere, ma non avrà più bisogno né di apprenderli dalla bocca di un essere vivente, né di far parte di questa o quella Loggia! Al contrario: mille volte più chiaramente di una bocca umana parla la “bocca invisibile”. Che cosa è l’arte vera se non l’attingere all’eterno Regno dell’Abbondanza?!
Poi parla degli artisti che frequentano temi oscuri: morte, follia, abiezione… Nel cervello di un artista “la spiritualità, l’elemento magico ha conseguito il predominio sulla materia”: negli artisti “diabolici” l’elemento magico diventa più pesante del cervello e dunque influisce maggiormente, mentre negli “Unti”, in cui lo spirito ha vinto la bestia, è lo spirito a pesare di più. Ma in entrambi l’equilibrio si è spostato a favore di un elemento non materiale, “mentre nell’uomo comune pesa soltanto l’elemento animalesco”. Ma cos’è la forza che usa gli artisti come strumenti per custodire i riti simbolici della magia?
Glielo dico io: è la stessa che una volta creò la Chiesa. Essa edificò nello stesso tempo due colonne viventi, una bianca e l’altra nera. Due colonne viventi che si odieranno reciprocamente finché non capiranno di essere i pilastri sui quali poggerà il futuro arco di trionfo.
Anzi interpreta il passo del Vangelo di Giovanni (21, 25) dove si accenna a molto altro che dovrebbe essere scritto, ma non basterebbe il mondo a contenerne i libri in riferimento a cose non tramandate che restano sempre vive a dispetto dei limiti di una trasmissione a voce: lo spirito le richiamerà continuamente “sussurrandole e creando nuove menti d’artista che vibreranno quando esso lo vorrà, e nuove mani per scrivere ciò che comanderà”. Per questo, secondo lui, la Chiesa iniziata con Pietro non potrà che terminare con Giovanni: morirà e risorgerà come Gesù. In spirito di rispetto verso una funzione ecclesiale che non si confonde con limiti e indegnità di chi la riveste, e cosciente dei dubbi nutriti anche da tanti preti cattolici, rimarca tuttavia che pochi cercherebbero la santità con la radicalità di fede di yogi e sadhu dell’India. “Mi creda: le vie della Resurrezione sono più numerose di quanto supponga la Chiesa!”.  Quanto alla profezia apocrifa sulla sequenza dei papi (la cosiddetta profezia di Malachia, insomma, dove si cita anche il Flos florum che qui campeggia sull’altare della Chiesa di Santa Maria), l’ultimo sarà un Giovanni, immagine dell’Evangelista e del Battista patrono dei massoni: comunque la verità si manifesterà sempre, come cade sempre la tavoletta colorata a copertura della scritta sull’altare della chiesa di Santa Maria. “Deduco dalla sua espressione che anche a lei non garba il fatto che ci sia un mistero sacro di cui si sono appropriati gli avversari della Chiesa e di cui la Chiesa cattolica non sa nulla”: ma tanto non sanno cosa farne, non ne capiscono il senso… Dove il dialogo è interessante, e corrosivamente meyrinkiano: ne deriva una scarsa stima per le grandi agenzie iniziatiche d’epoca…
Quanto alla profezia apocrifa sulla sequenza dei papi (la cosiddetta profezia di Malachia, insomma, dove si cita anche il Flos florum che qui campeggia sull’altare della Chiesa di Santa Maria), l’ultimo sarà un Giovanni, immagine dell’Evangelista e del Battista patrono dei massoni: comunque la verità si manifesterà sempre, come cade sempre la tavoletta colorata a copertura della scritta sull’altare della chiesa di Santa Maria. “Deduco dalla sua espressione che anche a lei non garba il fatto che ci sia un mistero sacro di cui si sono appropriati gli avversari della Chiesa e di cui la Chiesa cattolica non sa nulla”: ma tanto non sanno cosa farne, non ne capiscono il senso… Dove il dialogo è interessante, e corrosivamente meyrinkiano: ne deriva una scarsa stima per le grandi agenzie iniziatiche d’epoca…
Alla domanda del cappellano su come abbia appreso queste cose, il barone risponde in modo evasivo: alcune hanno a che fare con la sua vita, altre gli sono state suggerite, altre ancora tramandate per eredità. E il cappellano ricorda le strane voci circolanti sul padre del barone. Considerato un eccentrico, inventore di una macchina per far nascere la fede nei miracoli nei cani da caccia: e il barone ridendo conferma, era stravagante, saggio e coltissimo. Aveva passato gli ultimi anni in un piccolo castello di campagna, salvo tornare a morire in città. Ma ora il barone, undicesimo della famiglia Jöcher, spiega al cappellano di aver adottato, in assenza di figli, il ragazzo Cristoforo – che reca il nome previsto profeticamente per il dodicesimo della stirpe ed è sonnambulo come tutti gli Jöcher. Certo, gli spiace che non si tratti di un figlio del suo sangue, latore della relativa eredità spirituale… ma a quel punto il cappellano reca una notizia delicata che teme riapra una vecchia ferita nell’amico. La cui moglie era scomparsa – abbandonandolo – quindici anni prima, era affogata poi nei fiume e aveva lasciato un trovatello… appunto Cristoforo, che ora ha sentito di nascosto i discorsi dei due vecchi – scoprendo così l’identità dei genitori. Proprio dalla tomba della madre, senza saperlo, ha sottratto le rose bianche per l’amata..
Egli è tornato in tal modo nella catena delle nascite corporee della famiglia, nella quale la condizione di adepto dell’ordine taoista è ereditaria – eredità in mancanza della quale Cristoforo Colombaia non avrebbe potuto essere iniziato. Suo padre è un uomo colpito da una deformità, un iniziato di second’ordine, di una saggezza profonda ma che presenta le lacune tradite dalla deformità del corpo fisico.
È importante la sottolineatura del carattere ereditario della condizione di adepto: giacché il fondatore di una schiatta è un adepto del grado più elevato, che si ritroverà solo nell’ultimo della stirpe, mentre tutti i membri intermedi non saranno che iniziati di second’ordine. L’iniziazione finale dell’ultimo membro della stirpe conferisce simultaneamente la più alta iniziazione ai membri intermedi del gruppo familiare, posti tra il fondatore e l’ultimo appartenente – nel caso in questione Cristoforo Colombaia. Siamo in presenza di una importantissima concezione estremo-orientale; anche in un grado inferiore, come ad esempio ne Il Sogno del Padiglione Rosso, l’eroe, Pao Yu, dice: “Se mi faccio monaco, sette generazioni di miei avi andranno in paradiso”.
Nel caso di Cristoforo Colombaia, però, l’accento è posto sul sangue delle stirpi, che sono stirpi d’iniziati per diritto di nascita. Questa concezione, che suppone che talune stirpi abbiano per nascita il diritto di accedere all’iniziazione più elevata – quella stessa iniziazione che può naturalmente esser raggiunta anche da persone che non appartengono a queste famiglie, ma che sono comunque predestinate ad essere scelte – è molto antica, ed è fondamento del sacerdozio ereditario nell’antico Egitto e nei paesi della valle dell’Eufrate. Secondo le informazioni in nostro attuale possesso, sembra che queste famiglie siano giunte in Cina in epoca arcaica e vi abbiano fondato la civiltà cinese. Sono queste le famiglie che hanno ricevuto l’appellativo di “discendenti degli dei” e che restano completamente al di fuori della “Kor-wa”, come i tibetani chiamano la “ruota delle esistenze”. [Gérard Heym, “Il domenicano bianco”, in AA. VV., Meyrink scrittore e iniziato, cit.].
Come Cristoforo Colombo, il quasi omonimo Cristoforo Colombaia dovrà trovare il suo Nuovo Mondo.
(11-continua)