di Gioacchino Toni
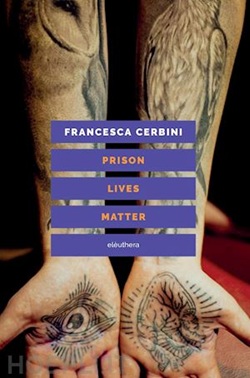 Francesca Cerbini, Prison lives matter. Etnografie del carcere tra Sud e Nord globale, elèuthera, Milano 2025, pp. 208, € 18.00
Francesca Cerbini, Prison lives matter. Etnografie del carcere tra Sud e Nord globale, elèuthera, Milano 2025, pp. 208, € 18.00
Prison lives matter di Francesca Cerbini mette in luce l’importanza della ricerca etnografica nell’affrontare il carcere e chi si trova a viverlo. Il luogo di prigionia viene indagato come manifestazione di repressione per eccellenza e laboratorio «in cui la creazione ad hoc di utili nemici più o meno immaginari, persone deprivate della benché minima umanità in nome della nostra sicurezza e libertà, fomenta la costruzione di una società militarizzata, sotto controllo e marcatamente diseguale» (p. 8). Gli uomini e le donne che si ritrovano reclusi in tali strutture sono presi in considerazione dall’autrice come soggetti reali, tra Sud e Nord globale, non di rado espressione «di quelle frange della popolazione per lo più razzializzate, escluse dai benefici del sistema produttivo e finanziario legale e dall’esercizio di una cittadinanza spendibile per l’acquisizione di diritti» (p. 8).
L’approccio etnologico con cui Cerbini guarda all’universo carcerario, focalizzato, come detto, sulle esperienze dei soggetti che lo vivono e sulla loro visione del mondo, la induce a ritenere che il concetto di istituzione totale, a cui si è fatto a lungo riferimento, non si riveli oggi utile a definire tale universo anche alla luce del fatto che sembra essersi dissolta la distinzione netta tra ghetto urbano e prigione, tanto da presentare inedite forme ibride di autogestione o co-gestione fra Stato e detenuti.
A partire dalle etnografie condotte nell’ultimo decennio negli istituti di pena del Sud e del Nord globale, Cerbini propone un radicale cambio di prospettiva che, scardinando l’univocità del “penitenziario ideale”, sinonimo di ordine e disciplina, consente di individuare connessioni ed elementi di continuità tra “dentro” e “fuori”, tra carcere e società, manifestando le tante forme di violenza con cui si attua la governance nei confronti dei soggetti sottoposti, in un modo o nell’altro, a restrizioni di libertà.
Diversi studi etnografici condotti nelle carceri del Nord hanno mostrato come i penitenziari, con i loro piccoli e grandi aggiustamenti e adattamenti all’ambiente circoscritto e circostante, attraversati da resistenze e addomesticazioni, finiscano per scardinare l’idea di carcere come sinonimo di ordine e disciplina, come «istituzione governata esclusivamente dalle autorità statali con un controllo chiaro, se non assoluto, sui confini dell’istituzione, sui suoi flussi, sull’irreggimentazione di tempo, spazio e popolazione» (p. 174).
Ad essere scardinato è il concetto stesso di «ordine come prodotto della razionalità statale e disordine come risultato del governo dei reclusi», e con esso l’assunto «occidentalista, di stampo evoluzionista, che vede nell’agire autonomo dei reclusi (e ancor più delle recluse, costrette da modelli di genere molto più vincolanti e regolatori della loro esperienza carceraria) l’inesorabile sopravanzare della giungla nel “giardino ordinato” del penitenziario classico» (p. 174).
Diversi studi, debitamente riportati dall’autrice, «non si sono limitati a mettere in discussione la netta distinzione tra pubblico (lo Stato) e privato (autogoverno), formale e informale, dentro e fuori, legale e illegale; a denunciare i colpevoli – i reclusi – o un colpevole – lo Stato – pur mostrando i limiti strutturali di un sistema, la sua violenza inaudita e la disuguaglianza sociale che il carcere incarna a partire dalla selezione iniqua di coloro che vi soggiornano» (p. 174).
Da tali studi non deriva una visione edulcorata di ciò che accade nelle prigioni, “post-coloniali” e non – l’autogoverno carcerario lungi dal rappresentare una sorta di “riscatto” degli ultimi –, bensì emerge come i gruppi umani che le vivono abbiano trovato modalità efficaci di sopravvivenza, si siano dotati di regole in maniera da evitare per forza di cose massacrarsi tra loro.
L’apporto più importante delle etnografie esplorate dall’autrice «è consistito proprio nella restituzione di un ventaglio di pratiche di governo del penitenziario difficilmente ascrivibili a formule univoche e cristallizzate». Tale restituzione, sottolinea Cerbini, «è stata possibile operando un passaggio preciso: dal pensare il carcere come un’istituzione con le sue luci e ombre al pensarne il funzionamento partendo dai soggetti che lo vivono, o meglio dalla loro “visione del mondo”» (p. 176).
L’approccio etnografico, nel suo tentativo di comprendere «le dimensioni trans-locali e trans-carcerarie», si è rilevato utile a «pensare l’incarcerazione al di là della retorica ufficiale autolegittimante e delle semplicistiche narrazioni post-coloniali che considerano le prigioni del Sud globale sfrenate e barbariche in contrapposizione alle prigioni (in teoria) ordinate e controllate del Nord globale, sia per sovvertire i concetti binari, assolutisti che ne fanno da corollario» (p. 177).
Ciò che è emerso, puntualizza Francesca Cerbini, è «un carcere diverso non in ragione delle discrepanze, delle mancanze del carcere del Sud globale a beneficio implicito (o esplicito) delle carceri del Nord. Tale cambio di prospettiva è stato possibile ripercorrendo all’inverso il cammino della deumanizzazione di carcerati e carcerate, riconoscendo che colonia, post-colonia, “razza”, e povertà hanno un legame profondissimo che conforma un continuum della violenza dalle molteplici varianti spazio-temporali» (p. 178).
Con l’approccio etnografico si sono aperte inedite possibilità comparative in cui le differenze mostrano «come localmente si declinino le spinte globali universalizzanti che dall’economia finiscono per influenzare la politica, l’attività legislativa, e con essa la mobilità e l’immobilità a cui le persone sono costrette», mentre le similitudini permettono di sottrarre «“unicità”, “peculiarità” e sensazionalismo a quelle realtà penitenziarie che si discostano in modo più o meno eclatante dal carcere “ideale”» (p. 179).
Le ricerche etnologiche evidenziano, dunque, «cosa accade nell’antipanottico, ossia mostrano contesti, relazioni, poteri che a uno sguardo poco allenato alle alternative teoriche decentrate sembrano alludere soltanto all’indisciplinatezza di un modello penitenziario. Certe caratteristiche invece non sono “esotismo” né una brutta copia, né una situazione sfuggita di mano, quanto più probabilmente conformano un complesso di pratiche, esperienze e circostanze che rimettono in discussione il concetto di ordine e caos, o meglio tutto ciò che sappiamo sul carcere» (p. 179).



