di Sandro Moiso
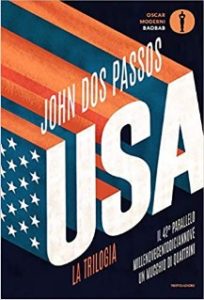 John Dos Passos, USA La trilogia: Il 42° parallelo; Millenovecentodiciannove; Un mucchio di quattrini, Mondadori 2019, pp. 974, 35,00 euro
John Dos Passos, USA La trilogia: Il 42° parallelo; Millenovecentodiciannove; Un mucchio di quattrini, Mondadori 2019, pp. 974, 35,00 euro
Non sono molti coloro che ancora ricordano che John Dos Passos (Chicago 1896 – Baltimora 1970) fu definito da Jean-Paul Sartre come il più importante autore della sua epoca. Sicuramente assimilabile per importanza ad altri due autori della cosiddetta “generazione perduta”, Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald, Dos Passos li superò entrambi per la novità delle sue narrazioni “collettive” e per lo sperimentalismo stilistico che contraddistinse le sue opere maggiori: Manhattan Transfer (1925) e la trilogia americana, ora riproposta integralmente da Mondadori in un unico volume, formata dai tre romanzi Il 42° parallelo (1930), Millenovecentodiciannove (1932) e Un mucchio di quattrini (1936).
Nato casualmente in un albergo di Chicago, come figlio illegittimo, dal rapporto tra John Randolph, avvocato di successo di origine portoghese, e Lucy Madison, figlia di una ricca famiglia del Maryland; segnato dalla partecipazione, come volontario, al primo conflitto mondiale, da cui trasse l’ispirazione per il suo primo romanzo Iniziazione di un uomo (1917), scritto a caldo immediatamente dopo il rientro in patria, e il successivo Tre Soldati (1921) che rimane, insieme ad Addio alle armi (1929) di Hemingway e Fuoco! (1933) di William March, una delle testimonianze più importanti della letteratura nordamericana sui traumi e le sofferenze causate dal primo macello interimperialista, Dos Passos si andò radicalizzando sempre più avvicinandosi al Partito Comunista statunitense.
Sono di questo periodo più radicale, sia dal punto di vista politico e che letterario, le sue opere maggiori e il suo appassionato libello dedicato alle vicende destinate a portare nel 1927 alla sedia elettrica i militanti anarchici di origine italiana Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti: Davanti alla sedia elettrica (Facing The Chair. Story of the Americanization of Two Foreign Workers, 1927).
Ed è proprio delle diverse forme dell’americanizzazione ovvero della formazione della società americana a cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, e dei destini singoli e collettivi che ne conseguono che si occupa la trama, strutturalmente complessa, della Trilogia USA.
Storie di donne e di uomini, di illusioni e delusioni, di vittorie parziali e sconfitte totali, che vedono coinvolti personaggi tratti sia dalla fantasia che dalla realtà storica contemporanea dell’autore, da John Reed a Henry Ford. Storie che si incrociano in tempi diversi nei tre romanzi oppure che corrono su binari lontani senza mai incontrarsi, ma tutte destinate a dare un ritratto veritiero e profondo, soprattutto sul piano psicologico e dell’immaginario, di quel melting pot culturale e di classe da cui sarebbe nata l’immagine moderna degli Stati Uniti e dell’American Way of Life.
Un ritratto spietato, a tratti disperato, che non lascia spazio a molte speranze, anche se soprattutto nel terzo ed ultimo romanzo della trilogia si affaccia qualche bagliore di luce alla fine del tunnel.
Ma è la scelta stilistica a colpire, ancor prima della trama, o delle trame: un montaggio narrativo ispirato sia alle avanguardie europee dei primi anni venti, che Dos Passos aveva frequentato più o meno direttamente, attraverso la frequentazione dell’abitazione di Gertrude Stein, durante il suo soggiorno parigino di quegli anni, e al montaggio cinematografico ideato dal regista sovietico Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, che l’autore avrebbe conosciuto frequentando la libreria “Shakespeare & Company” di Sylvia Beach situata sulla Rive gauche parigina.
Proprio nella stessa libreria l’autore americano aveva acquistato l’Ulysses di James Joyce che lo avrebbe ispirato per la struttura espositiva sia di Manhattan Transfer che dei tre successivi romanzi.
Tra i fondatori della rivista culturale di estrema sinistra “The New Masses”, Dos Passos entrò presto in conflitto con la progressiva stalinizzazione della sinistra americana e proprio a partire dalla guerra civile spagnola1, durante la quale lo stalinismo fece eliminare il suo traduttore e amico spagnolo José Robles Pazos2 , inizio ad allontanarsi dalla Sinistra tout court e avvicinandosi, nel corso dei decenni successivi a posizioni sempre più conservatrici.
Cessava in questo modo la fase più importante e creativa dello scrittore statunitense che, proprio per i motivi appena addotti, iniziò a subire quasi da subito gli attacchi di Ernest Hemingway e di certa critica leftist con l’intento, poi riuscito, di cancellarlo o quasi dalla storia della letteratura americana.
Atteggiamento certamente stupido e ideologicamente sovradeterminato che riuscì per parecchi anni a rimuovere l’importanza dello scrittore dal panorama letterario. Simile a quello usato, ma per motivi formalmente più fondati, nel secondo dopoguerra nei confronti di un altro gigante della letteratura mondiale: Louis-Ferdinand Céline.
I romanzi della trilogia furono publicati per la prima volta in Italia nella collana “I grandi narratori di ogni paese” della mondadoriana Medusa nel 1936 (The Forthy Second Parallel, nella traduzione di Cesare Pavese), nel 1938 (The Big Money sempre nella traduzione di Pavese) e nel 1951 ( Nineteen-Nineteen nella traduzione di Glauco Cambon), mentre per molti anni è rimasto disponibile nelle librerie, prima di scomparire per un lungo periodo di tempo, soltanto Il 42° parallelo.
Sinceramente, dopo aver conservato per anni i tre testi nelle edizioni original, non avrei mai creduto di vederli ricomparire tutti insieme in una così bella e curata edizione, in cui l’Introduzione di Cinzia Scarpino e la Nota alla traduzione di Sara Sullam rendono giustizia sia alla grandezza della scrittura di Dos Passos che all’importanza dell’opera di Cesare Pavese in quanto traduttore e rinnovatore della soffocante cultura letteraria italiana della sua epoca. Per tutti questi motivi c’è da essere veramente grati alla collana “Oscar moderni – Baobab” di Mondadori per la riscoperta e riproposizione di un autentico classico della letteratura moderna.
Proprio Cesare Pavese ebbe a dire:
La poesia di Dos Passos sta in questo modo asciutto di percepire e rendere le cose. «Joe non riuscì a guardare il film»; e questo è il punto più introspettivo di una narrazione tutta fatti esterni, inesauribilmente e nitidamente esposti, con un distacco che è giudizio morale. Attraverso questo suo orrore di tracciar svolazzi psicologici in una vita dove basta guardare e accumulare le mille parvenze per giudicare, Dos Passos si è fatto uno stile, nella sua umile oggettività ricchissimo di sfumature: sono mezzi gesti, mezze parole, oppure colori odori suoni, pieni di significato, gioiosi nella loro energia espressiva; una novità nella poesia americana, se non si risalga fino a certe pagine d’impressioni, ai jottings (appunti) disseminati nelle prose e versi di quell’altro enfant terrible di questa cultura, che è Walt Whitman.3
Una scrittura cinematografica come poche altre, dove lo scavo psicologico non si trasforma in dozzinale psicologismo, ma in cui sono gli atti, ancor prima delle parole o dei pensieri, a rendere visibile il carattere e l’etica dei personaggi. Una scrittura cinematografica che proprio nei sintetici Cine-giornali, distribuiti lungo tutto l’arco dei romanzi e realizzati con un autentica ed efficacissima tecnica di cut up di notizie e titoli di giornali, riesce a dare al lettore l’idea e la ricostruzione di un’intera epoca.
Un capolavoro del ‘900, non solo americano, che tutti gli amanti della grande letteratura dovrebbero leggere oppure riscoprire.
Dos Passos dedicò alla stessa, alla rivoluzione messicana e a quella bolscevica una serie di scritti contenuti poi in J.Dos Passos, Introduzione alla guerra civile (Journeys Between Wars), pubblicato in Italia nel 1947 nella collana “Arianna” ancora una volta dalla casa editrice Mondadori ↩
Si veda in proposito Ignacio Martínez De Pisón, Morte di un traduttore, Ugo Guanda Editore, Parma 2006 ↩
C. Pavese, John Dos Passos e il romanzo americano, saggio pubblicato su “La Cultura”, gennaio-marzo 1933, ora in C. Pavese, La letteratura americana e altri saggi, Einaudi, quinta edizione 1962, pag. 120 ↩



