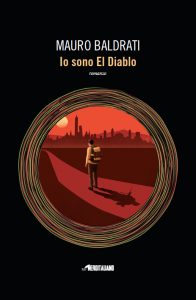di Mauro Baldrati
 Questo capitolo fu stralciato dal mio romanzo Io sono El Diablo, pubblicato da Fanucci nell’ottobre 2018, perché distraeva il flusso di lettura, lo sviava. Non per il testo in sé, ma in rapporto al romanzo stesso. Io, dopo una discussione con l’editore e con l’editor, e dopo diverse riletture e riflessioni, ho concordato. In effetti era come se stessi seguendo un sentiero e a un certo punto prendessi una derivazione faticosa senza sapere dove mi stava portando.
Questo capitolo fu stralciato dal mio romanzo Io sono El Diablo, pubblicato da Fanucci nell’ottobre 2018, perché distraeva il flusso di lettura, lo sviava. Non per il testo in sé, ma in rapporto al romanzo stesso. Io, dopo una discussione con l’editore e con l’editor, e dopo diverse riletture e riflessioni, ho concordato. In effetti era come se stessi seguendo un sentiero e a un certo punto prendessi una derivazione faticosa senza sapere dove mi stava portando.
Però sono affezionato a questo testo. Per scriverlo mi ero ispirato a Suttree, un capolavoro di Cormac McCarthy, l’uomo del fiume. Ma non solo. Dietro c’è anche il cosiddetto “fatto vero”.
Nei primi anni ’70 a Mezzaluna (RA), la cittadina dove ho ambientato i romanzi Avventure di un teppista e Il mio nome è Jimi Hendrix, vivevano i fratelli Cipolla. Il primogenito, colui che aveva dovuto ingoiare tutte le gelosie e le umiliazioni per la nascita del principino, era Il poveretto, mentre il secondo era Il signore.
Cipolla il signore era un broker assicurativo. Viaggiava su auto di grossa cilindrata, vestiva con la giacchetta e la cravatta, portava orologi d’oro, era cordialone, espansivo, e offriva spesso da bere nel bar della sezione P.C.I.
Cipolla il poveretto era sempre al verde, una mina vagante che il sabato sera cercava di scroccare il biglietto del cinema, un caffè, una birra, le sigarette. Tutti cercavamo di evitarlo.
Un giorno Cipolla il poveretto sparì dalla circolazione. Venimmo a sapere che si era costruito una capanna di giunchi in riva al fiume Lepre, dove viveva di pesca “a manaccia” (cioè catturava i pesci lungo le sponde a mani nude), e, si diceva, di piccoli furti negli orti e anche qualche gallina. I contadini protestavano, ma erano tempi morbidi, di “vivi e lascia vivere”, e Cipolla il poveretto ci passò tutta l’estate.
Ogni tanto andavamo a trovarlo. Era diventato selvatico, con la barba lunga, gli occhi spiritati.
Pensavo soprattutto a lui mentre scrivevo questo capitolo.
L’inglese, durante le sue peregrinazioni nella periferia bolognese, va a trovare l’amico Giac che vive in una capanna nella golena del fiume Reno.
***
Non fu lungo il tratto fino al ponte sul fiume.
Il traffico era diminuito ma le auto e i camion lo sfioravano come missili imbolsiti nei passaggi dove il marciapiede era interrotto per lavori.
Prima del ponte girò a sinistra, entrò in un isolato di edifici con cortili, un piccolo giardino coltivato a rose rosse e bianche.
Raggiunse la golena, superò il grande ponte di pietra della ferrovia affiancato da due colossi di cemento bianco, i viadotti futuribili di forma arrotondata che costituivano le piste dei treni ad alta velocità.
Un pensionato che stava tagliando un tronco con una sega a motore lo vide.
Alzò un braccio, gridò
“è là! E’ arrivato!”
Si addentrò nel tratto selvaggio del Reno, con avvallamenti, piccoli acquitrini creati dalle piene, fiancheggiò una montagna di terra e pietre ricoperta di papaveri, canneti. La terra sembrava levigata dal passaggio della piena, con depositi di erba secca, tronchi, qualche sacco di plastica.
Superò la carcassa di un’auto bruciata, portata in quel sentiero chissà come e perché.
Lo vide in lontananza, accucciato dietro al tavolino traballante. Era ligio agli orari Giac. Pranzo a mezzogiorno, cena alle sei, alle cinque quando la luce calava alla svelta. Ora aveva finito di pranzare e stava prendendo il sole che bucava le nuvole in viaggio nel cielo stracciato.
L’inglese si avvicinò. Giac lo salutò con una mano.
Gli stessi vestiti larghi e infangati di sempre, gli scarponi da lavoro con la punta di ferro, la faccia di un colore marrone, di chi sta sempre all’aria aperta, la barba di una settimana.
Notò subito qualcosa di insolito accanto alla postazione-cucina, col tavolo scassato, le sedie di plastica da campeggio: un palo alto tre metri con una piastra inclinata in cima.
“Inglese. Ti fai vedere. Ogni tanto.”
Giac intercettò il suo sguardo. “Visto? Sai cos’è?”
“Circa” disse l’inglese, osservando il palo.
“Me l’ha regalato un tipo, uno che si interessa di ecologia, quelle storie lì. Si chiama pannello fotovoltaico. Prende la luce del sole e la trasforma in elettricità. Non è fico?”
“Fico” convenne l’inglese.
“Guarda qua!” gridò Giac. Spostò degli arbusti scoprendo una tenda di plastica che nascondeva un frigorifero di piccole dimensioni. “Fa funzionare un frigo! Così tengo la roba quando è caldo. Il pannello l’hanno costruito loro, quelli ecologici voglio dire, in un corso, un laboratorio, così mi ha detto.”
Aprì lo sportello del frigorifero. L’inglese vide dei vasetti bianchi, una bottiglia di latte.
“Quando sei arrivato?” chiese.
“Da poco. Questo inverno è venuto un metro di neve. Se stavo qui morivo.”
L’inglese si sfilò lo zaino. Giac viveva sul fiume da aprile a novembre, poi si arrangiava. A 35 anni non aveva più il fisico per superare l’inverno, diceva, ed era costretto a trasferirsi in città. Aveva bisogna di un locale riscaldato. Così stava nel dormitorio pubblico. Un posto pieno di pazzi, di ubriachi. Ogni tanto in città si incrociavano, allora camminavano per le strade gelide e alla sera l’inglese lo invitava a cena nella mensa di Via Ugo Bassi dove cercava di aiutarlo nella paranoia distruttiva che gli creava la presenza di altre persone.
“Visto che hai il frigorifero, ho qualcosa per te” disse aprendo lo zaino. Prese le scatolette, il pane, le mele, il formaggio, le due bottiglie.
“Ehi, grazie, inglese. Il vino ce lo beviamo subito, che dici?”
Si frugò in tasca, tirò fuori un piccolo coltello a serramanico che usò per fare leva sotto al tappo a corona.
“Giac, mi sa che per oggi ho bevuto abbastanza.”
“Eh? Ma no, solo un bicchiere, non vorrai farmi bere da solo!”
Stappò la bottiglia, ma d’un tratto si immobilizzò, con lo sguardo fisso a terra. Sembrava teso come un cane da caccia, concentrato. Allungò un braccio, lentamente, prese il bicchiere di plastica che stava sul tavolino. Si inginocchiò, col bicchiere in mano capovolto. L’inglese seguì la linea della sua attenzione e individuò un ragno di discrete dimensioni sull’erba tagliata, col corpo giallastro, le zampe corte. Con un movimento fulmineo Giac coprì il ragno col bicchiere, poi inserì sotto il bordo un pezzo di cartone che portava sempre con sé, per le sue prede. Alzò il bicchiere così tamponato e lo agitò a lungo, come i baristi quando preparano i cocktails. Lo rovesciò, tolse il cartone e con una sorta di lenta curiosità, come i giocatori di poker quando scoprono le loro carte, guardò dentro. Sorrise, socchiuse gli occhi, si portò il bicchiere alla bocca e, con un gesto repentino, inghiottì il ragno. Restò con gli occhi chiusi, la faccia rivolta verso il cielo, finché iniziò a masticare piano, con movimenti circolari della mascella, senza aprire gli occhi.
L’inglese distolse lo sguardo.
Si girò verso il fiume, che si intravedeva gonfio al di là dell’intrico di canne, l’edera e la vitalba che ricoprivano gli alberi fino a soffocarli. Quello era uno dei motivi per cui Giac era seguito dai servizi sociali. Soffriva, affermavano, di una patologia che lo spingeva a divorare gli insetti. Sindrome di Renfield, dicevano. In realtà non mangiava insetti, ma solo ragni, e aveva una motivazione a suo modo lucida. Un giorno gliene aveva parlato, quando manifestò sorpresa assistendo per la prima volta alla scena.
“Io mangio due ragni alla settimana, talvolta tre” aveva detto. “Sono grato ai ragni, perché mi regalano la loro essenza. Assorbo la loro natura di aracnide, che scorre in me, nel mio sangue, sulla mia pelle. E gli insetti del bosco lo sanno. Per questo mi rispettano. Sentono l’aracnide. Mi lasciano in pace.”
Ed era vero. Giac sembrava immune alle punture di insetto. Neanche le zanzare con le zampe tigrate lo aggredivano. Questo gli permetteva di vivere in quel tratto di golena in estate. Un anno l’inglese era rimasto a Bologna fino al primo agosto. La golena del fiume, con la cappa di umidità, la temperatura di 40 gradi e gli insetti sembrava un tratto di giungla equatoriale.
Giac, il ragno.
Si girò. Giac, terminato il rito, aveva riempito due bicchieri di vino rosso.
L’inglese pensò alla patologia che gli avevano attribuito. Anche lui aveva mangiato insetti. Durante le marce congiunte con gli incursori del SAS nella giunga di Sumatra cercavano i tronchi caduti sotto ai quali proliferavano certi grassi bruchi gialli dal sapore dolciastro. Le cicale arrostiste erano croccanti come i gamberetti e i grossi ragni pelosi erano particolarmente ricchi di proteine.
Anche lui soffriva della Sindrome di Renfield?
Prese un bicchiere, chiedendosi se era quello che aveva contenuto il ragno. Bevve un sorso. Era un vino corposo, secco, quasi amaro.
Giac sistemò le bottiglie nel frigo. Poi sparecchiò e infilò i resti in un sacco di plastica.
“Chissà per quanto tempo mi lasceranno in pace” disse.
L’inglese non rispose. Ogni anno Giac se lo chiedeva.
“Stamattina è stata qui quella donna dei servizi sociali”.
Lo guardò di sbieco. Con quella luce, con un riflesso del sole nelle pupille contro lo sfondo scuro delle piante, l’inglese vide uno sguardo da aracnide. Vide il ragno nei suoi occhi.
“Beh, dice che il prossimo anno forse avrò una casa. Ma io… io non voglio una casa!”
L’inglese non replicò. Capiva le sue motivazioni. Neanche lui voleva una casa. Sempre lo stesso cubo dove rinchiudersi ogni sera. Dove svegliarsi ogni mattina. Aprire gli occhi e sentirla, sul tetto.
C’era sempre, sul tetto.
Ascoltare il suo fruscio, la stoffa che vibra frustata dal vento.
La bandiera nera della sventura.
“Vogliono a tutti i costi portarmi via da qui! Vogliono sottopormi al… come cazzo si chiama, TSO!”
“Che sarebbe?”
“Trattamento sanitario obbligatorio. Arrivano i pompieri, l’ambulanza, i poliziotti. Tutti per me. Vaffanculo.”
“Beh, potresti fare così” disse l’inglese. “In inverno stai nella casa, come essere al dormitorio, e l’estate torni qui.”
“Ma è proprio questo il punto!” esclamò Giac. “Non vogliono che stia qui. Per loro è inconcepibile.”
L’inglese guardò in direzione del gigantesco fico, vicino alla recinzione che delimitava la golena. Sotto la chioma compatta, nell’intrico di rami che scendevano fino a terra, Giac aveva ricavato la sua caverna. Tagliando i rami interni aveva creato lo spazio per una tenda a igloo, mimetizzata da foglie e rampicanti, invisibile dall’esterno. Ogni giorno al calare del sole si ritirava nella tana e vi restava fino all’alba. La postazione si trovava sopra un piccolo rilievo, teoricamente fuori portata dalle piene.
“Giac, il problema, per loro, è che tu non dia nell’occhio.”
Non dare nell’occhio.
Mai.
Era la teoria del Crotalo Muthafucka
uno specialista.
“Per dire, se ti beccano che fai razzie negli orti…”
“Ma non lo faccio più da due anni!” lo interruppe Giac. “Mi regalano tutto, ho più di quanto mi serve. Io sono il buon selvatico. Tra un po’ porteranno i bambini a vedermi, come allo zoo.”
L’uomo ragno.
L’uomo selvatico.
L’inglese ripose il bicchiere sul tavolino, mentre Giac cercava di richiudere la bottiglia.
“Non si chiude con questo tappo. Vuol dire che la berremo stasera a cena.”
L’inglese guardò alle sue spalle, verso i ponti della ferrovia.
Si udiva, in lontananza, il fragore della cascata.
L’acqua precipitava schiumando sui gradoni sotto le arcate.
“Stasera la berrai tu. Io devo andare.”
Giac sistemò la bottiglia accanto alla tenda che proteggeva il frigorifero.
“Devi andare? Devi sempre andare tu. E dove?”
Dove? L’inglese finse di non avere sentito.
“Invece tu resti qui, per un po’. Ho bisogno del tuo aiuto.”
Balzò in piedi, scattante sotto ai vestiti larghi e fangosi. Guardò verso il fiume, con le mani sui fianchi. “Oggi è la giornata del pesce. Tu vieni con me a tirare su la lenza. Lascia lo zaino qui, nessuno lo tocca.” Spostò gli arbusti, scoprì un varco vicino al baule. L’inglese sospirò rassegnato. “Andiamo, ora, vediamo cosa mi ha riservato fratello fiume.”
Si incamminò verso la boscaglia imboccando la traccia di un sentiero che spariva nell’erba alta, seguito dall’inglese. Penetrarono nell’intrico di erbacce, ortiche, Giac come apripista incurante dei semi uncinati che si attaccavano ai vestiti e ai capelli, l’inglese dietro, spinto dai ricordi di altre boscaglie, altre sterpaglie, fino al fiume dove l’acqua correva veloce con piccoli vortici e onde schiumeggianti. La sponda era fangosa. Giac saltò nell’acquitrino affondando con gli enormi scarponi n. 48, regalo di un pensionato di tre taglie più grosso.
L’inglese si fermò, preoccupato per gli amati anfibi.
“Vieni, devi aiutarmi a tenere la lenza in acqua.”
Si inginocchiò accanto a un paletto infisso nella mota, saggiò la tensione di un filo di nylon che mandava impercettibili riflessi.
L’inglese si tolse anfibi e calzini e camminò sul fango gelido a piedi nudi. Raggiunse Giac, che stava recuperando la lenza. Dall’acqua emerse, sguazzando furiosamente, un pesce verdognolo lungo quanto una mano.
 “Ecco, tieni ferma la lenza in modo che possa staccarlo” disse Giac.
“Ecco, tieni ferma la lenza in modo che possa staccarlo” disse Giac.
L’inglese afferrò la lenza e la tenne in tensione, mentre Giac, con cura meticolosa, liberava la bocca del pesce. Poi lo gettò in acqua.
“Dico, perché lo liberi se l’hai appena pescato?” chiese l’inglese.
“Perché è troppo piccolo! Recupera la lenza ora.”
L’inglese tirò la lenza, arrotolandola ai suoi piedi come aveva fatto Giac. Emerse un altro pesce, più o meno delle dimensioni del primo, che fu liberato. Continuò a recuperare mentre la lenza vibrava, sembrava attaccata a qualcosa di pesante. Tirò finché, con gran sguazzare, apparve un grosso pesce squamoso di forma tozza.
“E’ una carpa!” esclamò Giac. “Tienila in tensione che la stacco.”
Appoggiò il pesce sulla sponda, poi si abbassò mettendo il naso quasi a contatto con la bocca della carpa, come se volesse baciarla. Lentamente estrasse l’amo. Buttò la carpa tra l’erba, dove iniziò a dibattersi goffamente.
“Forza, tira ora, ce n’è almeno un altro!”
Riprese a recuperare la lenza vibratile, che si spostava verso il centro del fiume. Due giri e venne fuori un pesce scuro, con la testa enorme.
“Un pesce gatto! Bello! Tienila ferma!”
Giac lo liberò, facendo attenzione a non ferirsi con le pinne acuminate del pesce gatto. Lo lasciò scivolare accanto alla carpa, poi recuperarono tutta la lenza, rimettendo in acqua altri due pesci.
Giac sembrava frenetico, spinto da una grande fretta di inginocchiarsi di fronte ai due pesci agonizzanti. L’inglese lo vide abbassarsi toccandoli con la fronte, mentre prendeva il coltello dalla tasca e a bassa voce bisbigliava:
“Grazie, grazie di avermi donato la vostra libertà.”
Poi sollevò la carpa tenendola per le branchie e le conficcò la lama del coltello in gola, sventrandola con un secco fendente. Strappò le interiora ancora pulsanti, le gettò in acqua, mentre il pesce piegava la coda in un ultimo guizzo. Ripeté l’operazione col pesce gatto, con la testa bassa, le sopracciglia aggrottate, e da quella posizione, con quella luce, l’inglese vide di nuovo il volto di un aracnide, gli occhi di un ragno. E quando parlò udì la voce di un aracnide.
Aveva voce un aracnide?
“Inglese, per piacere
metti la lenza dentro a quel sacchetto
così non crea danni agli animali
che passano sulla sponda.”
(con voce di aracnide)
L’inglese eseguì. Intanto Giac lavava i pesci.
Tornarono nella selva, l’inglese scalzo, con gli anfibi in mano, saltellando sulle radici e sui rovi, Giac avanzando come un machete umano fendendo l’erba, coi due pesci in mano.
Sbucarono nello spiazzo dove Giac mangiava. Infilò i due pesci in frigorifero, mentre l’inglese si asciugava i piedi infangati con la carta da cucina.
“Andiamo ad accendere il fuoco ora!” disse.
Si buttò a capofitto nella boscaglia, girò a sinistra aprendosi la strada a calci in uno sbarramento di rovi finché uscirono in prossimità della sua caverna. Sulla destra, a una decina di passi, spostò dei rampicanti, scoprì la collinetta di terra dove aveva sistemato un forno, ricavato da un pozzetto per fognatura. Di fianco al forno c’era una piccola catasta di legna da ardere, rami e tronchi portati dalla piena. Erano stati tagliati a misura, pezzi regolari.
“I pensionati” disse Giac prevenendo la sua domanda. “Sono venuti con una sega a motore a tagliare i rami.”
Andò nell’antro sotto al fico, tornando con carta di giornale e una scatola di fiammiferi. Posizionò nel forno dei rami secchi e li accese con la carta. Un fumo bianco uscì dalla copertura, dove era stato aperto un buco. Giac faceva vento col giornale. Presto le fiamme iniziarono a guizzare. Quando il forno fu sufficientemente caldo inserì due grossi ciocchi.
“Adesso vai a prendere i pesci, con due piatti. Tra un po’ li mettiamo dentro. Impiegheranno circa due ore a cuocere a fuoco lento.”
L’inglese eseguì.
Tornò alla postazione del frigorifero, dove c’era anche il suo zaino.
Poteva andarsene ora, tornare verso la città. Aveva passato fin troppo tempo con Giac. Era rimasto fermo troppo a lungo. Guardò l’uomo inginocchiato accanto al forno, l’uomo ragno di fango che agitava il giornale, allungando il collo.
L’eremita.
Una specie di ragno ermafrodita.
Giac stesso lo disse
mentre erano seduti accanto al forno
a gambe incrociate.
Gli aveva offerto il pesce gatto
per cui l’inglese aveva capito
che era la carne migliore.
“No, voglio la carpa”
aveva detto l’inglese.
“Ma la carpa è piena di spine.
Tu prendi il pesce gatto, alla carpa ci penso io.”
“Voglio la carpa, punto e basta.”
Ora stava cercando di mangiare quella carne stopposa
con un forte sapore di fango
disseminata di centinaia di spine di ogni dimensione.
“Se solo potessi costruire una capanna.”
L’inglese valutò che non c’era altro di commestibile
nel mezzo pesce che era avanzato.
Addentò il pane arabo
arrostito nel forno.
Bevve un bicchiere del vino secco Sangiovese.
“Sarei a posto, con una capanna.
Starei qui anche in inverno.
Al diavolo la casa, la città, il dormitorio.”
Gli uccelli cantavano da ogni direzione
col massimo dell’energia
un concerto prima del calo serale.
“Certe volte…”
disse Giac, con lo sguardo fisso sulle braci morenti
“penso: e se avessi… qualcuno con me?”
“Qualcuno?”
“Sì… un… una compagna, qui con me.
Talvolta ci penso, e vuoi sapere cosa concludo?”
“Sì.”
“Che è impossibile.
Nessuna donna vivrebbe come me.
E vuoi sapere un’altra cosa?”
“Dimmela.”
“Non m’importa.
Non ne sento il bisogno.
Mi stupisco da solo, ma è così.”
Un debole riflesso rosso
sulla sua faccia marrone
solcata da reticoli di rughe.
“Inglese, vuoi sapere cosa penso?”
“Dimmi cosa pensi, Giac.”
“Penso che noi umani siamo fuori posto.
Siamo l’unica specie che non può vivere in inverno senza costruire un cubo di pietra o di legno dove stare col corpo ricoperto di stracci o di pellicce rubate agli animali che invece vivono così come sono nati in tutte le stagioni.
Perché noi no?
Che diavolo significa?”
“Forse non significa nulla, Giac.
Non c’è per forza un significato.”
“E invece deve esserci!
Com’è possibile che siamo così deboli e indifesi?
Non ha senso.”
“Forse un tempo eravamo diversi.”
“E chi lo dice? Quelle storie sulle scimmie?
Se fosse vero ci saremmo evoluti al contrario
verso la debolezza e la malattia.
Noi siamo fuori dal mondo.
Io cerco di vivere come loro”
disse, indicando il bosco.
“Ma non è possibile.
Se resto qui in inverno muoio.
Invece i topi, i serpenti scavano un buco in terra
e qui passano l’inverno.
Gli uccelli stanno sui rami.
Alcuni muoiono, altri no.
E comunque non devono uccidere un altro animale
per rubargli la pelle.
Vuoi davvero sapere cosa penso, inglese?”
“Voglio saperlo, Giac.”
“Noi non siamo di qua.
Questo non è il nostro dannato mondo.”
“Cioè siamo venuti dallo spazio?
Vuoi dire questo?”
“Deve essere così.
Altrimenti qui regna la follia.”
“E’ una teoria, Giac.”
“E’ così. E io sto cercando di mutare, capisci?”
“Credo di sì.”
“Sto cercando, e lo sento.
Sento che sto mutando.
Lo sento, capisci?
Per questo non esiste
una donna della specie umana
che potrebbe vivere con me.
Io potrei vivere con una cagna
o una pecora
ma cosa sarebbe di loro durante l’inverno?
Dovrei abbandonarle.”
Restò immobile, in una fissità totale, per molti minuti.
Gli uccelli ora tacevano
nella quiete della sera che si annunciava.
Solo qualche trillo lontano
dal folto del bosco.
“Ora vado, Giac.”
Ancora un minuto di immobilità nell’aracnide
prima di girarsi
e rispondere.
Nei suoi occhi era sceso come un velo
rendendoli vitrei, opachi.
“Te ne vai, inglese? Tu te ne vai sempre.
Sei fuori posto, sempre. Come tutti. Come me.”
“Vero.”
Si alzò, facendo crocchiare le giunture delle caviglie e dei ginocchi.
“Perché non dormi qui?
Ho una tenda monoposto.
Ho visto che hai il sacco con te.”
Gli occhi avevano ripreso luce
roteavano verso il bosco già buio.
D’un tratto, un pensiero:
Potrebbe piantarmi il coltello nella gola
dopo avermi ringraziato
e mangiarmi per prendere la mia essenza
o quello che è?
Concluse che sì, avrebbe potuto farlo.
Anche se forse non l’avrebbe fatto.
“Non posso, Giac. Ci vediamo presto.”
Restò in piedi di fronte a lui, sovrastandolo.
Anche Giac si alzò
sbattendo le palme sui pantaloni chiazzati di fango.
“Allora torna a trovarmi.
Se vieni in giugno avrò raccolto la frutta.”
Lo sapeva.
La golena era disseminata di alberi da frutto
ciliegi, albicocchi, fichi.
“Verrò, puoi giurarci.”
“Ti aspetto allora.”
Le braccia lungo il corpo
la faccia marrone immobile.
Osservò l’inglese girarsi e camminare
verso la postazione del pannello fotovoltaico
dove recuperò lo zaino.
Poi Giac il ragno guardò il fiume,
che aveva già catturato la notte
e la tratteneva nella sua rete di foglie e rami e spine
sulla superficie magnetica dell’acqua nera.
[In apertura: Salgado; all’interno: Ricardo Stuckert]