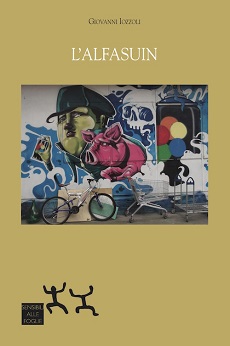 Giovanni Iozzoli, L’Alfasuin, Edizioni Sensibili alle foglie, Roma, 2018, pp. 128, € 13,00
Giovanni Iozzoli, L’Alfasuin, Edizioni Sensibili alle foglie, Roma, 2018, pp. 128, € 13,00
[Oggi, 9 gennaio, cade l’anniversario di una delle tante stragi antioperaie che furono tra gli atti fondativi di questa Repubblica: il 9 gennaio del 1950, a Modena, sei lavoratori furono ammazzati a sangue freddo – fucilati e mitragliati – dalle forze dell’ordine intervenute per sgomberare i presidi sindacali alle Fonderie Riunite. Era la prima volta che la Polizia interveniva militarmente in città dentro un conflitto sindacale. Piuttosto che ricordare quegli eroici martiri con una nota commemorativa (di cui la rete è comunque ricca), preferiamo parlare del presente, di coloro i quali quei morti li stanno concretamente onorando oggi, ai giorni nostri, probabilmente senza neanche conoscerne la storia: perché il miglior ricordo, fuori dalle retoriche celebrative, è la lotta degli uomini e delle donne che si stanno battendo per riportare diritti e speranze dentro fabbriche e magazzini, usando il loro coraggio e i loro corpi contro lo sfruttamento e la repressione che informano il lavoro e i rapporti sociali nell’Italia di oggi. Pubblichiamo quindi un breve estratto del romanzo L’Alfasuin, appena uscito, centrato sulle lotte nel comparto agroalimentare e sul disvelamento delle retoriche del “Made in Italy”, dietro le cui vetrine scintillanti si nasconde il marcio della precarietà più odiosa ed estrema. I proletari di oggi onorano con la loro resistenza il ricordo dei proletari di 58 anni fa – G.I.].
***
«Una dinastia di prosciuttai milionari. Una famiglia mafiosa in cerca di rispettabilità. Centinaia di lavoratori giunti da ogni parte del mondo, per disossare e rifilare cosce di maiali. Dove possono incrociare tutti costoro i propri destini? All’Alfasuin, storica azienda modenese del prosciutto, padrona di un territorio fondato sulla centralità dei salumi e sulla pace sociale. Un passato glorioso e mitizzato, un presente indecifrabile: lungo l’arco di vent’anni i protagonisti si agitano frenetici dentro un modello e un mondo che si va sgretolando. Dalla retorica dell’“eccellenza italiana”, emerge una crudissima realtà: il vero preziosissimo maiale di cui “non si butta via niente” è il lavoro vivo, sempre più spremuto, sfruttato e impoverito. Fino al giorno in cui gli schiavi del prosciutto decidono di alzare la testa. E il tempo della crisi diventa il tempo della rivolta».
***
Un primo incidente si verifica all’alba del secondo giorno di blocco dei cancelli. Si è formata una lunga fila di camion, tra cui Tir e autoarticolati, che arriva quasi all’uscita della tangenziale. La Celere è pronta con i manganelli e gli scudi. Un gruppo di dirigenti della cooperativa esce deciso dall’ingresso automezzi, scavalca bestemmiando le tre file di dipendenti seduti davanti ai cancelli per impedire il passaggio dei camion, scalcia e spintona tutti quelli che si trovano davanti. Poi la squadretta di capetti si sposta verso il vicino drappello di polizia, gesticolando, indicando il blocco, sbracciandosi; i funzionari cercano di mediare, non hanno ancora ricevuto l’ordine di caricare e per il momento non interverranno. I capetti alzano le braccia e se le sbattono sui fianchi. Poi uno di loro, il più deciso – Abdallah riconosce essere il tizio sbrigativo e volgare che lo ha assunto – si piazza con le spalle al muso ringhiante del primo camion della fila, fermo a motore acceso, proprio in faccia al picchetto che ostruisce l’entrata; comincia a fare segno all’autista di avanzare dietro di lui, ruotando le braccia nell’aria. L’alba sta spuntando – sono le cinque – ma è ancora buio e i fanali accecano i manifestanti seduti a terra. Lentissima, come una fila di elefanti, i camion cominciano ad avanzare sotto la guida del dirigente furioso e isterico.
– Avanti, avanti, per Dio! Via, via… – a calci, pugni e spintoni il capo crea un cuneo nel picchetto; i manifestanti hanno avuto tutti l’ordine di non reagire alle provocazioni, urlano e insultano, qualcuno sputa, ma si limitano alla resistenza passiva; intanto i camion sono arrivati a pochi centimetri dalla prima fila, dove tutti sono spaventati, con gli occhi semiaccecati dai fanali, pronti ad alzarsi e a scappare; la Polizia resta a guardare. Ancora pochi centimetri di pressione, i paraurti sono quasi in faccia ai manifestanti, i primi cominciano ad alzarsi e arretrare. Il picchetto è sfondato. Tutti si muovono disordinatamente, con i pneumatici quasi addosso ai corpi; altri capetti continuano a spintonare e urlare, spalleggiati da alcuni autisti scesi dai mezzi in fila – si vede che stanno difendendosi il loro posto di garanti dell’ordine aziendale, come i cani difenderebbero l’osso. Passato il primo camion, gli altri seguono. Quel giorno il picchetto non ha retto. Si è arrivati a un soffio dall’investimento.
Nella rabbia e nella delusione, gli scioperanti si ricompattano nel piazzale, sotto gli occhi vigili della Digos:
– stamattina abbiamo mollato. Non dobbiamo. Perchè è una gara a chi dura di più.
Sadik è da 5 anni in quella cooperativa. E’ il più sindacalizzato di tutti. Si tira dietro una buona metà dei dipendenti, qualcuno anche delle altre società che lavorano in quel sito.
– Se loro capiscono che non siamo disposti ad andare fino in fondo, abbiamo perso tutto. E al primo cambio appalto ci faranno anche fuori.
Sono una cinquantina, tutti annuiscono. Abdallah è in prima fila, anche se è l’ultimo arrivato. A quarantacinque anni si è stancato di essere prudente.
– Qua c’è anche la polizia che ci sente. Noi non ci nascondiamo, non ci vergogniamo, non abbiamo paura. Dobbiamo andare fino in fondo. La signorina lì, quella è una giornalista, lo scriva, lo scriva per favore, domattina noi siamo di nuovo qua davanti. Ci devono ammazzare.
Ci devono ammazzare.
E alle 4 della mattina successiva i lavoratori sono di nuovo in blocco davanti ai cancelli, seduti per terra, con i primi camion che arrivano e il solito plotoncino di celere con le visiere abbassate, pronte a colpire. Sadik, che si è fatto pure un paio di anni all’università prima di finire facchino, prova persino a discutere con i poliziotti con un piccolo megafono:
– è una vergogna che vi mandino qui, alle 4 di mattina. Invece di andare ad arrestare i criminali, vi mettono davanti ai cancelli delle fabbriche. In questo modo la polizia viene usata per fini privati, dentro una vertenza sindacale. Ma la polizia – gli stipendi, gli straordinari, i mezzi – li paghiamo tutti noi, con le tasse. Perché dovete venire qui a bastonarci? Perché vi schierano a favore dei padroni?
Alle 7,30 arriva l’indicazione di sospendere il blocco in entrata e in uscita delle merci. Tra un po’ una delegazione sarà finalmente ricevuta per trattare un accordo. Come richiesto al tavolo, non ci saranno solo i dirigenti della cooperativa, ma anche un avvocato in rappresentanza della committenza. Gli operai esultano, è già un risultato, visto che fino ad allora la multinazionale della logistica proprietaria del magazzino aveva rifiutato ogni coinvolgimento. Sadik dà indicazione ai suoi compagni:
– adesso ci mettiamo di lato, a fianco del cancello di entrata e lasciamo passare i mezzi. Tra un po’ comincia l’incontro e noi aspettiamo notizie in diretta. Se la trattativa va avanti, li lasciamo discutere. Ma se qualcosa va storto, se fanno i furbi, se non vogliono darci niente, allora pronti a riprendere il blocco, non entra e non esce più nessuno.
Il presidio nel parcheggio diventa meno teso, più rilassato, qualcuno porta i caffè nei thermos, le bandiere e i bidoncini vuoti usati come tamburi, vengono ammucchiati all’ingresso, si formano capannelli etnici tra filippini, albanesi, maghrebini e nigeriani. Si ride e si discute. Alcuni capi sono usciti fuori e gironzolano nella zona del presidio per sentire che aria butta e magari provare a tirarsi dietro qualcuno dei loro.
All’improvviso la situazione cambia, tutto precipita.
Dal tavolo di trattativa arriva la notizia che l’avvocato del committente non s’è visto e non si sa se parteciperà; i dirigenti della cooperativa danno l’idea di voler solo tergiversare, per cercare di guadagnare tempo – forse avevano delle spedizioni importanti proprio per stamattina e volevano ammorbidire il presidio. C’è delusione, la gente si sente presa in giro. Comincia a montare l’agitazione.
I capetti tornano tutti dentro, avvisati al cellulare, con le guardie giurate schierate sulla linea del cancello – si capisce che il clima sta cambiando. C’è rimasto solo un camion dentro, da far uscire, un pesante autoarticolato che ha già completato il carico e sta aspettando i documenti. Lo guida un tizio biondiccio e tarchiato, che è in attesa a motori accesi. Il capo delle spedizioni gli urla di chiudere lo sportello e partire – alle bolle penseranno dopo. Contemporaneamente Sadik, che è in delegazione al piano di sopra, dà un occhiata dalla finestra della palazzina e impartisce l’ordine telefonico di riprendere il blocco. Subito comincia un movimento disordinato e vociante davanti ai cancelli. Abdallah è tra i primi ad accorrere. Gli scioperanti si chiamano tra loro, agitano le braccia, urlano in quattro o cinque lingue diverse per attirare l’attenzione dei capannelli più lontani e più distratti.
– Vai, cazzo, vai – il capo delle spedizioni sbatte la mano aperta contro lo sportello, l’autista ingrana la marcia. E’ questione di secondi, deve uscire prima che quei disgraziati si schierino davanti al cancello.
L’autista ha un attimo di esitazione. I primi ad arrivare si stanno già piazzando, si guardano intorno e invocano rinforzi. Abdallah corre e strilla agitando le braccia. E’ contento che la lotta riprenda e non gliene frega niente del lavoro che probabilmente perderà, urla contro la sua vita, sente sulla schiena il fruscio della bandiera del suo sindacato annodata come un mantello; l’autista rallenta, è perplesso o accelera e si infila nell’unico varco ancora libero o si ferma, il capetto lo sta inseguendo a piedi, bestemmia rosso in faccia e continua a picchiare coi pugni sullo sportello:
– Vai, vai per Dio.
Il camion accelera ed è costretto a virare a destra, appena varcata la soglia del cancello. Abdallah è lì, con le braccia allargate e una specie di sorriso rabbioso in faccia. Il veicolo inchioda all’improvviso. Nessuno vede più Abdallah.
È finito sotto.
L’autista scende con le mani nei capelli. I colleghi dell’egiziano accorrono e ognuno urla frasi senza senso, sono urla solitarie, nessuno sa che fare.
Qualcuno si infila sotto al camion e comincia a tirare fuori il corpo di Abdallah. Il capetto che incitava l’autista lo ha preso per una spalla e lo ha trascinato via, dentro il magazzino, per sottrarlo alla rabbia della gente che da lì a poco sta per esplodere. Un altro dirigente è salito sul camion e ha cominciato lentamente a spostare il mezzo, riportandolo in retromarcia verso la soglia del cancello; qualcuno degli scioperanti è salito sul predellino e batte i pugni sul vetro, gridandogli di non spostare il camion, tutto deve rimanere com’era. La Polizia ha chiamato subito il 118, c’è un furore incredulo, tutti si toccano, si abbracciano, si spintonano, maledicono i padroni e le guardie, molti piangono e si guardano intorno come in un sogno bizzarro e cattivo. Abdallah è morto sul colpo.
I segni dell’urto sono tremendi, gli occhi riversi verso l’alto, una gamba piegata in modo innaturale. I colleghi lo osservano attoniti, ipnotizzati, con le mani in faccia, qualcuno con le lacrime agli occhi tira fuori il cellulare e trova il coraggio di filmare: – devono vedere quello che ci fanno, devono vedere tutti, come ci hanno ridotto.
Abdallah è riverso a terra, schiacciato e impotente, come le loro vite da 6 euro lordi all’ora.



