di Lorenza Ghinelli
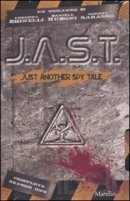 [La casa editrice Marsilio ha deciso di promuovere J.A.S.T., romanzo scritto a sei mani da Simone Sarasso, Daniele Rudoni e Lorenza Ghinelli, con un “Blog Tour”: un giro promozionale effettuato non sul territorio, ma su blog e siti letterari, con una tappa ogni giorno. Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa, già tentata con successo negli Stati Uniti ma nuova per l’Italia. Su Lorenza Ghinelli, autrice dell’estratto che pubblichiamo, torneremo molto presto.] (V.E.)
[La casa editrice Marsilio ha deciso di promuovere J.A.S.T., romanzo scritto a sei mani da Simone Sarasso, Daniele Rudoni e Lorenza Ghinelli, con un “Blog Tour”: un giro promozionale effettuato non sul territorio, ma su blog e siti letterari, con una tappa ogni giorno. Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa, già tentata con successo negli Stati Uniti ma nuova per l’Italia. Su Lorenza Ghinelli, autrice dell’estratto che pubblichiamo, torneremo molto presto.] (V.E.)
Episodio 2 — Aisha goes to Africa
Written and directed by Lorenza Ghinelli
Il passato di Aisha 1.0
Taraqi, Sud Ovest di Zaranji ” Afghanistan ” 1980
Prima suggestione: tutto è del colore del sale.
Niente verde. Nessun albero. Nessuna costruzione, diavoleria umana, persona, animale.
Niente.
L’udito si affaccia sull’orlo di un baratro.
Nessun rumore.
Infinito spazio: lunare e terroso.
Se il silenzio potesse urlare, se nella mente si potessero accendere le casse armoniche di questa terra, allora sentireste la voce di Omar Faruk Tekbilek: Yunus.
Ma le casse sono spente, adesso.
L’aria è fredda. Pesante. Si accartoccia, cade e spacca. Spacca la terra. E la terra è un mosaico.
La steadycam si arrampica su creste verticali: sempre più alte, a graffiare il cielo.
Il firmamento sanguina. Rosso arteria che sa di nero.
Il sole, sbranato dall’Hindu Kush, fa la terra di vetro.
Benvenuti nel “carosello del mondo antico”.
Benvenuti in Afghanistan.
Violato nei secoli dai nomadi dell’Asia centrale, da Indoariani e Unni Bianchi, da Medi, Persiani, Greci. Violato dall’Impero Kushan. Violato e convertito: al buddismo dall’Impero Maurya, allo Zoroastrismo dai Sasanidi. All’Islam dagli Arabi. Violato dai Britannici. Violato dai sovietici.
Violato e sopravvissuto.
Perché l’Afghanistan è donna.
****
Lo sguardo del narratore plana. Appena cento passi dal suolo.
Dal colore, planando, al bianco e nero. Al seppia.
1980. E l’aria è sempre fredda.
Nel sale una strada, pare tracciata a gesso.
Sulla strada, nessuno. Due escavatori cingolati Gehl, nuovi di zecca, i rostri affondati nell’unica miniera salina che l’occhio può percepire. Lo sguardo segue la strada, dalla miniera fino alla sola luce che non provenga dal cielo. Luce dietro una finestra. Finestra di casa. Casa occidentale…
Assurdo.
Come un canotto nelle fauci dell’oceano.
Dall’altra parte del vetro, in un corridoio di calce, una linea di fumo sale al soffitto, vi scivola sopra. La camera segue a ritroso la nebbia grigia, trova una mano. Con un Arturo Fuente acceso tra pollice e indice.
La mano è di Hassan: quarant’anni, barba curata.
Occhi immensi e fissi.
Se ne sta schiena al muro, sopra uno sgabello costoso. Lungo gli spigoli dello sgabello è narrata, a colpi di coltello, la festività di Id’ul’azha, in cui si celebra Abramo che sceglie. Che sceglie d’immolare il figlio.
Hassan è il padrone di casa. E della miniera.
Con l’altra mano, freneticamente, snocciola il tasbi, il rosario dell’Islam. Le labbra ripetono la frase più sacra: “Lailahailllallah”.
Non c’è nessun dio all’infuori di Dio.
Le pareti di calce respirano l’Arturo Fuente, lo mischiano all’aria di casa: incenso alla mirra, tikka’kabab e pilaw con riso fritto, montone e spezie.
Ma in fondo alle narici, dopo il sigaro e il cibo, resta l’odore del sangue. Fresco.
Di femmina che soffre e spinge.
Un urlo che strappa. Una voce minuta, l’accento tagiko:
“Ancora. Ancora, più forte!”
Dietro la parete, la stessa che regge Hassan, due femmine.
Una liquida di sangue e sudore, l’altra che traffica con le mani nel sesso della prima.
In mezzo al sesso, la testa. Ha già i capelli.
Lotta.
Sfonda.
Fa strepitare.
La madre urla. Più forte.
Hassan sussulta, le sue dita falciano l’aria, ficcano il sigaro fra le labbra avide.
Aspira, Hassan. E pensa.
Pensa al suo paese. Lo sente urlare nella testa.
Il suo paese lotta. Sfonda. Fa strepitare la terra.
E la terra, pure lei, urla. Ancora più forte.
Hassan pensa che dal 1900 ogni governante è stato deposto nel sangue. Pensa a Sardar Mohammed Daod e a tutta la sua famiglia: squartati dalla Rivoluzione a metà ’78.
Pensa a Taraki, primo ministro della Repubblica Democratica dell’Afghanistan da sei mesi appena e già schiavo dei Russi.
Pensa alla riforma che restituisce la terra ai contadini, all’abolizione dell’ushur, la decima ai latifondisti.
Pensa alla jihad, urlata dalle gerarchie ecclesiastiche.
Pensa alla lotta armata. Ai mujaheddin.
All’aria sempre più serpica. Che puzza di morte.
Un altro urlo. E poi un altro ancora, questa volta acuto: Jamiat si è svegliato.
Hassan dà l’ultima boccata al Fuente, cammina nella caligine stagna del corridoio fino alla stanza del figlio. Lo prende in braccio. Jamiat smette di frignare all’istante.
“Tua madre, Fadwa, sta bene. Inshallah. Avrai un fratello”.
****
Hassan ha il piccolo in braccio.
Accende il Sony a colori.
Gli occhi torvi di Brenev lo fissano dallo schermo.
Le sopracciglia boschive.
Presidente dell’URSS dal 1964: colpo di stato magistrale, MADE IN KGB.
Brenev è muto; il volto si deforma, si accartoccia su se stesso.
Stampato. Su una bandiera rossa in spalla ai mujaheddin. “Allah u Akbar”, il televisore non dice altro.
Alle spalle dei miliziani, un T52 ribaltato fuma inerme. Carico di cadaveri sovietici.
Jamiat frigna di nuovo.
Hassan non conosce storie, se non quella del suo paese. Torna a pensare a voce alta: “Vedi quell’uomo, Jamiat? È russo. Guardalo bene: ha invaso la tua terra. I suoi uomini hanno addestrato e armato il popolo afgano. Hanno costruito scuole, pozzi, ospedali. Ma qui da noi, in questo kenarab, le differenze non si vedono. Si vedono solo le regole che ci hanno imposto. Come se avessimo bisogno di qualcuno che ci insegni a essere afgani…
“Tu sei afgano, Jamiat. Tu sei afgano e Pashtun. I Pashtun sono forti, ragazzo mio. Se li ricorda anche Alessandro Magno.”.
“Gli occhi di Hassan sono fessure: “Alcuni Pashtun mi fanno vergognare, Jamiat… gettano fango sulle nostre risha, le nostre radici. Sta crescendo una mala pianta, Jamiat, proprio in seno al nostro paese. Nel nostro watan i sovietici non sono graditi: nessuno può arrogarsi il diritto di piombare in casa di un altro e dirgli come deve educare i suoi figli e le sue mogli. Come deve radersi la barba.
“Ma il vero problema non sono i russi, figlio mio… Sono gli americani. Dietro ogni guerra c’è sempre l’America. Ricordalo. “Creature dell’inferno, ecco cosa sono gli americani… hanno armato e addestrato molti dei nostri fratelli.
“Tutti ci addestrano.
“Tutti ci comandano.
“E ci fanno ammazzare fra di noi, come si fa coi cani.
“I mujaheddin… Sai come li chiamano i mujaheddin, gli americani? Combattenti per la libertà li chiamano”.
Jamiat sente la stretta del padre farsi più forte, nervosa, protesta piangendo.
Hassan allenta la presa. Punta i piedi, lo fa trotterellare sulle ginocchia.
Jamiat torna muto.
“Io sono Pasthun. E anche tu lo sei. Come tutta questa famiglia e i tuoi e i miei nonni.
“Non combatterò mai per gli americani. E neppure per i russi. E non crederò mai, MAI, nei combattenti per la libertà”.
Nella mente di Hassan la storia della sua terra, le parole di quegli anni: della radio, prima. E poi della tv. Della gente, nelle strade.
Fermento di polvere, caos e morti ammazzati.
La bobina che si riavvolge nella mente di Hassan è bloccata dalla voce monocorde della giornalista alla televisione: “Gli Stati Uniti d’America, sostenuti dall’opinione pubblica mondiale, protestano contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan; hanno inoltre annunciato il taglio di ogni fornitura di grano e di tecnologie, assieme alla ferma intenzione di boicottare le XXII Olimpiadi che si terranno a Mosca il 19 luglio…”.
Hassan stritola il telecomando, lo scaglia contro il muro.
“A nessuno importa dell’Afghanistan”.
Pensa a Carter. E a Usama Bin Laden.
Il nome dice poco, questo tizio non va in tv. Questo tizio è ricco sfondato, la sua famiglia ha fatto i soldi con l’oro nero. Finanzia mujaheddin, Usama. È amico degli Yankee.
Fa confluire in Afghanistan denaro, armi e soldati da mezzo mondo, persino dalla Cina. E li addestra a due passi dalla casa di Hassan, al confine col Pakistan.
Hassan l’escalation del conflitto l’ha vissuta in diretta: quattro volte, nell’ultimo mese, un fratello Pashtun gli ha chiesto di nascondere nei T.I.R. carichi di sale diretti a Kabul gruppi di dieci, quindici mujaheddin. Le prime tre Hassan ha rifiutato.
Non si tratta di prendere posizione.
Per Hassan si tratta di non fare terra bruciata attorno a sé. Si tratta di non tradire il proprio sangue. Si tratta di proteggere la famiglia. Di proteggere gli affari.
Pashtun e mujaheddin, non erano loro a tessere le fila del gioco; tutto era stato organizzato ad arte.
E mamma CIA finanziava l’operazione col commercio clandestino di oppio.
I grandi occhi neri di Jamiat fissano il padre. Solenni.
Poi, un fruscio; Hassan si volta all’istante, ritorna al reale.
Davanti a lui la serva tagika gli sorride bagnata di sudore.
Hassan le molla Jamiat, corre.
Fadwa gli sorride. Esangue. Ai seni turgidi e bruni succhiano minuscole labbra.
Voraci.
Tappa precedente: Booksblog
Tappa successiva: L’angolo nero



