di Gioacchino Toni
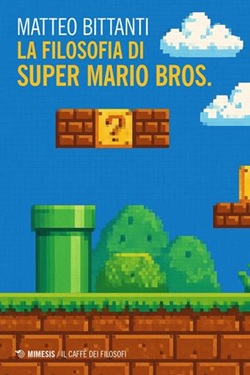 Matteo Bittanti, La filosofia di Super Mario Bros., Mimesis, Milano-Udine, 2025, pp. 278, € 18,00
Matteo Bittanti, La filosofia di Super Mario Bros., Mimesis, Milano-Udine, 2025, pp. 278, € 18,00
Nascosto dietro l’incubo del 1984 orwelliano è arrivato, senza che fosse percepito, quell’addomesticamento seducente huxleyano che, un poco alla volta, abbiamo imparato a conoscere. Volendo indicare un anno simbolo in cui “la fregatura” ha iniziato a insinuarsi tra noi, si può guardare al 1985. «Un salto. Un suono metallico. La prima moneta raccolta. Così comincia Super Mario Bros.: con un gesto elementare che diventa cultura. Non è solo un videogioco. È un congegno simbolico che nel 1985 prende possesso del televisore, come in Poltergeist. Da quel momento la cultura scorre in orizzontale, come lo schermo: avanti, sempre avanti. Si cade, si ricomincia. Mario insegna una logica dell’azione che cambia riflessi, aspettative, desideri. Altro che passatempo: è un manuale operativo mascherato da intrattenimento» (p. 7). Così si apre il volume con cui Matteo Bittanti guarda al videogame della Nintendo ripercorrendo quattro decenni di mutazioni politiche, tecnologiche, estetiche e sociali.
Bittanti guarda a Super Mario Bros. indagandone le meccaniche (le regole e i comandi prestabiliti), le dinamiche (le strategie, le appropriazioni e gli usi collettivi) e le estetiche (gli aspetti emotivi, gli immaginari e le istituzionalizzazioni che ne derivano). «La meccanica del salto anticipa l’ideologia della performance. La dinamica della ripetizione racconta la precarietà del presente. L’estetica della nostalgia digitale ci mostra come guardiamo al passato per decifrare l’hic et nunc. Mario è un pretesto per comprendere il mondo che abitiamo: un linguaggio che trapassa media, contesti, istituzioni (p. 8).
L’autore evidenzia quanto della nostra contemporaneità è stato programmato (anche) da Super Mario Bros. a partire dalla sua uscita a metà degli anni Ottanta. «Super Mario Bros. non è semplicemente un videogioco. È un ordigno culturale, esploso in un anno cruciale – il 1985 – che segna una mutazione radicale nella forma della cultura, nella struttura dello sguardo, nella grammatica dell’azione» (p. 9). Dopo aver dimorato, alla sua nascita, negli spazi pubblici delle sale giochi, Mario si è trasferito nello spazio domestico dei gamer e da lì è iniziata la sua – e in qualche modo la nostra – nuova vita.
La filosofia Nintendo passa dalla disciplina punitiva della sala giochi a una pedagogia della scoperta, alternando difficoltà e ricompense, calibrando la frustrazione come leva per la meraviglia. […] Super Mario Bros. inocula una nuova logica dell’esperienza: non più rappresentare un mondo, ma programmarne la percorribilità. […] È l’avvento di un design che educa al vettore unico – produci, supera, procedi – e marginalizza i gesti di ritorno, manutenzione, ripensamento (pp. 9-10).
Bittanti guarda a Super Mario Bros. come a una macchina ideologica che introduce un modo di pensare basato sulla ripetizione rituale dell’ostacolo, sull’illusione della scelta, sulla performatività del fallimento. Lo studioso mette in relazione le meccaniche del gioco con gli eventi storici, culturali o mediali di metà anni Ottanta, quando si passa dalla rappresentazione spettacolare alla simulazione integrale, evidenziandone le risonanze strutturali. Nel suo presentarsi come sistema chiuso, sorvegliato e ottimizzato, in cui la fantasia è ridotta a puro codice, il videogame può essere visto come paradigma formale della contemporaneità.
Lo studioso mette in relazione il videogame della Nintendo con la percezione dell’invasione tecnologica giapponese vissuta dagli statunitensi a cui Hollywood darà immagine con Trappola di cristallo (Die Hard, 1988). È in tale contesto che, mentre gli adulti guardano con timore alla tecno-invasione giapponese, i più giovani si lasciano sedurre dal buffo e simpatico idraulico baffuto, dal nome italiano e dalla veste di lavoro blu e rossa progettato in Giappone e destinato a conquistare il mercato videoludico occidentale.
Il personaggio Mario è anonimo, privo di identità: un mero corpo operativo, uno strumento di movimento duttile che si limita ad agire: «è l’emblema del lavoratore postindustriale: sempre pronto, sorridente, flessibile, fungibile, fungino » (p. 20). Un proletario che salta e corre in silenzio: «ogni gesto è funzionale e automatico, privo di significato sociale o politico. Mario incarna così un’immagine della nuova working class, isolata e atomizzata, impegnata in un movimento continuo e ripetitivo, senza prospettiva di emancipazione collettiva o trasformazione sociale» (p. 86).
I videogiochi portatili che si diffondono negli anni Ottanta riscrivono l’esperienza videoludica trasformandola in una sequenza di gesti cronometrati. «Il videogioco entra così nella sfera dell’addestramento motorio, della ripetizione ritmica, del compito eseguibile» (p. 24) e funge da addestramento al pigiare convulso, ossessivo e ansiogeno degli smartphone. Dopo l’era della passività dello spettatore televisivo, l’universo dei videogame Nintendo proietta e attiva l’utente nel cyberspace.
Quando, a metà degli anni Ottanta, Super Mario Bros. viene messo sul mercato, il dibattito culturale è attraversato dalla figura del cyborg, di cui Mario rappresenta una versione depotenziata, disinnescata, tranquillizzante, compatibile e commerciabile. Lo stesso gamer, sostiene Bittanti, nonostante il suo entrare in simbiosi con il dispositivo tecnologico, resta un’ibridazione addomesticata all’interno di un sistema di regole rigidamente chiuso. Super Mario Bros. è permeato della medesima retorica procedurale dell’efficienza che si ritrova nel protagonista di Wall Street (1987) di Oliver Stone e che caratterizza il neoliberismo perseguito da Reagan giunto a inaugurare il suo secondo mandato in concomitanza con l’uscita del videogame della Nintendo.
Mario non protesta, non si organizza, non si sottrae. Corre, salta, raccoglie, ripete. È la personificazione ludica del soggetto neoliberista: sempre in movimento, disponibile 24/7, instancabile per necessità non per scelta. Il piacere dell’autosorveglianza, la gratificazione della prestazione, la trasparenza assoluta delle metriche. […] In Super Mario Bros. il tempo non accompagna l’azione: la incalza. Non è uno sfondo, ma un meccanismo di costrizione. Il timer in alto a destra non misura il gioco: lo governa. Ogni livello inizia con un conto alla rovescia che procede inesorabile. Non si guadagna tempo: lo si consuma. […] Si apprende per fallimento iterativo, ma senza catastrofe. La punizione non è l’espulsione dal gioco, ma il ritorno all’inizio. (pp. 39-40).
Super Mario Bros. riflette dunque la logica della prestazione neoliberista in cui l’errore viene percepito come carenza di ottimizzazione e codifica in forma ludica la logica Just-In-Time divenuta un dogma proprio negli anni Ottanta. «Il tempo, da risorsa, diventa pressione. […] Il tempo non è denaro: è debito da estinguere a ogni ciclo. La linea deve scorrere senza attrito. […] A differenza della fabbrica, però, qui la macchina sei tu: manodopera e algoritmo, in sincrono con un flusso progettato altrove. […] Non ci sono tempi morti. La morte è reset, non pausa. Il futuro non esiste: solo il frame successivo. Tempi postmoderni» (pp. 43-44).
Nel corso degli anni Ottanta Nintendo partecipa pienamente a quella corsa verso l’immateriale a cui si indirizza il capitalismo caratterizzata dalla prevalenza del marchio sulla produzione materiale e delle proprietà intellettuali sulla manodopera umana, insomma, come sintetizza efficacemente Bittanti, l’impresa si trasforma in piattaforma. «Super Mario Bros. è il sottoprodotto di un capitalismo che ha espulso la “zavorra” della forza lavoro. L’opera non coincide tanto con il gioco, quanto con la sua persistenza algoritmica: ogni livello è un asset pronto a essere ricombinato. Giocare significa accumulare capitale ludico. L’interazione è estrazione» (p. 45).
L’anno in cui nasce Super Mario Bros. è il medesimo in cui Microsoft introduce il sistema Windows provocando un vero e proprio cambio di paradigma: l’utente «non accede più a un mondo rappresentato, ma si muove in un contesto codificato, sezionato, operabile» (p. 47) in cui è tenuto a operare senza necessità di capire. Allo stesso modo Super Mario Bros. non presenta al gamer alternative ma protocolli: all’utente non è concesso di esplorare ma è tenuto ad attraversare, anziché creare deve limitarsi a eseguire, non deve imparare a programmare ma a obbedire operativamente. Insomma, si tratta di un apparato pedagogico che, scrive Bittanti, «forma soggettività compatibili con il sistema – docili, performanti, prevedibili» (p. 48) mantenendole nell’illusione di avere accesso a ogni cosa con immediatezza e semplicità.
Con gli anni Ottanta compare anche il mito della flessibilità a cui è tenuto l’essere umano a partire dall’ambito lavorativo e Super Mario Bros. contribuisce, a suo modo, ad addestrare il gamer alla prestazione intermittente, alla temporalità, alla vulnerabilità e all’instabilità. Mario assume a tutti gli effetti il ruolo di freelance hero della gig economy ludica che anziché ricevere un salario viene ricompensato per le sue prestazioni in moneta contante da raccogliere lungo il percorso in situazioni pericolose.
In questa struttura, il denaro non è mai accumulabile a lungo termine: esaurita la partita, l’intero capitale scompare. La moneta perde la funzione di riserva di valore, riducendosi a carburante per il prolungamento temporaneo della prestazione. Il ciclo è autopoietico e coercitivo: per continuare a esistere, Mario deve continuare a lavorare; per lavorare, deve rischiare la vita; per rischiare la vita, deve mantenere un ritmo produttivo crescente. Ne risulta un modello di alienazione totale, in cui il soggetto è interamente subordinato alla logica del sistema, e in cui la “ricompensa” coincide con la mera possibilità di reiterare la fatica (p. 55).
Il videogame «ha anticipato e reso familiari le logiche della prestazione modulare, dell’incentivo puntiforme e del controllo metrico, logiche poi estese alla vita economica tramite app, gamification e lavoro gratuito/connesso» (p. 57). Il capitalismo delle piattaforme ha ludicizzato il lavoro in chiave estrattiva e disumanizzante attraverso punteggi e inviti a partecipare a mission sempre più complesse del tutto prive di orari e tutele. Lo stesso sound design del videogame è pianificato per orientare il comportamento del gamer ad agire in funzione delle ricompense. «L’ambiente acustico si configura così come un dispositivo biopolitico: una macchina di addestramento che allinea il comportamento dell’utente a schemi di efficienza e accumulazione, manipolando il principio di piacere per massimizzare la produttività in gioco» (p. 70).
Super Mario Bros. è contraddistinto dallo scorrimento laterale continuo ma solo verso destra dello schermo, uno scorrimento orizzontale irreversibile che non ammette di tornare indietro e induce il gamer a percepire tanto la presenza di un fuoricampo da scoprire avanti a sé, quanto il consumo definitivo di ciò che già ha attraversato, dunque lo abitua a una visione lineare orientata: «l’avanzamento irreversibile educa a vedere il mondo come un percorso obbligato – procedere, superare, produrre – dove non c’è spazio per fermarsi, ripensare o sistemare ciò che si è lasciato» (p. 60). Il gamer è tenuto ad agire secondo una logica prettamente colonialista: penetrare in un territorio straniero, annientare gli indigeni ed estrarre ricchezze a proprio beneficio.
Se Jean Baudrillard ha descritto la contemporaneità come un regime di segni in cui la rappresentazione non copia il reale ma lo produce, Super Mario Bros. ha presentato un ambiente interattivo ove il reale è sostituito dalla perfetta esecuzione di un modello che non chiede al gamer di scoprire un mondo, ma di conformarsi a un codice già completo e dato.
Nei viaggi coloniali come nei mondi digitali, il controllo dello spazio passa attraverso il controllo del sapere cartografico, che legittima l’appropriazione e la conquista. Così il videogioco, travestito da intrattenimento, riproduce una grammatica del dominio: la progressione non si misura nella profondità dei personaggi o della trama, ma nella capacità di attraversare, mappare e possedere nuovi territori. In questo senso, Nintendo offre ai giocatori un’esperienza che riecheggia i miti fondativi della modernità coloniale, trasformando lo spazio virtuale in un campo di esplorazione e di potere simbolico. […] Super Mario Bros. diventa un punto di contatto tra la superiorità tecnologica giapponese e le fantasie coloniali euroamericane, producendo un ibrido culturale che legittima sia il determinismo tecnologico sia l’espansione imperiale (p. 65).
L’ideologia veicolata da Super Mario Bros., sostiene Bittanti, deve essere ricercata nell’assegnazione di un ruolo attivo al gamer-colonizzatore. Questo videogame riproduce in formato digitale e ludico «una genealogia di pratiche e immaginari imperiali: l’esplorazione è inseparabile dalla conquista, il paesaggio è ridotto a risorsa estetica e funzionale, la frontiera si espande costantemente» (p. 66). La logica colonialista con cui la discussa mostra “Primitivism” in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern (MOMA, 1985) confrontava opere d’avanguardia occidentali con manufatti di lontane civiltà del tutto decontestualizzati, è rintracciabile anche in Super Mario Bros. visto il suo ridurre l’Altro a mero ostacolo deprivato di soggettività il cui valore risiede meramente nel piacere ludico del superamento con annessi punteggi guadagnati.
Bittanti mette in relazione la sintassi modulare e temporanea, la ripetitività e l’assenza di profondità narrativa di Super Mario Bros. con la grammatica visiva e della logica valoriale di MTV diffusasi negli anni Ottanta. Tanto i gamer compulsivi che i teledipendenti di MTV del decennio anziché leggere il mondo lo attraversano in sequenza, adottando un modello cognitivo destinato a diffondersi e potenziarsi nei primi decenni del nuovo millennio.
Al pari della tv interattiva, il game della Nintendo coinvolge il pubblico senza cedere controllo: quella concessa all’utente è una partecipazione ridotta a finzione in cui i dispositivi agiscono da sistemi di addestramento all’obbedienza a schemi rigidamente predefiniti. Ciò che offre Nintendo, a partire dalla metà degli anni Ottanta, è insomma un vero e proprio ecosistema tecnologico votato alla fidelizzazione: la corporation nipponica non vende un game ma una piattaforma dotata di tecnologie, regole e contenuti in esclusiva, quello che esercita non è tanto un controllo tecnico, ma culturale. Se si pensa che i blocchi che Mario manda in frantumi sono esseri pietrificati, allora si coglie come il gioco proponga una retorica della violenza utilitaristica che prevede la cancellazione di tutto ciò che intralcia il procedere. «La violenza diventa produttiva, l’annientamento si converte in guadagno. […] Super Mario Bros. innesta una gamification del massacro» (p. 99).
Dopo aver mostrato come le meccaniche organizzano l’azione, Bittanti guarda alle modalità di fruizione, alle dinamiche prodotte dall’universo ludico a livello sociale, culturale e tecnologico. L’introduzione sul mercato della console Nintendo ha contribuito a trasformare l’apparato televisivo da medium lineare con la sua logica di flusso a finestra interattiva su mondi virtuali con annessa logica del feedback. Nello stesso periodo si diffonde il videoregistratore, altra tecnologia domestica che permette di rompere con il flusso dettato dal sistema televisivo. A partire dagli anni Ottanta l’ambiente domestico assume un’inedita centralità ludico-creativa e, mentre il cinema si dimostra incapace di appropriarsi della logica performativa dei videogame, l’universo ludico inizia a mostrarsi utile nel training per l’intelligenza artificiale. Il passaggio dei videogame dalle sale giochi collettive agli spazi domestici privati in compagnia della tv, ormai inevitabilmente collegata al videoregistratore, riflette un’epocale trasformazione sociale che comporta anche la ridefinizione delle pratiche dell’intrattenimento.
Anziché guardare alle meccaniche o alle trame e ai personaggi, Bittanti concentra la sua attenzione sulla dimensione tecnica e materiale delle piattaforme, vero e proprio generatore di forma e senso degli artefatti culturali. Il Nintendo Entertainment System (NES), come tutte le piattaforme, non è un semplice dispositivo elettronico neutro, ma piuttosto «un artefatto tecno-culturale che traduce in silicio valori come affidabilità, accesso, proprietà» (p. 118). Se in Giappone compare proponendosi come dispositivo a metà via tra il giocattolo e il computer, una volta giunto negli Stati Uniti il NES tende ad affrancarsi dal registro del giocattolo infantile per collocarsi nell’orizzonte della cultura di massa adulta. «In questo senso, l’intrattenimento è una legittimazione ideologica: permette a Nintendo di occupare il cuore dell’economia culturale statunitense, dove entertainment significa Hollywood, MTV, la televisione via cavo» (pp. 118-119). Un intrattenimento (domestico) che, sottolinea lo studioso, sottrae tempo ad altre forme di socialità (pubblica). «È la comunità ridotta a circuito elettronico, il legame sociale trasformato in competizione ludica. […] A partire dagli anni Ottanta la linea di confine tra gioco e lavoro si assottiglia: il controller diventa insieme strumento di svago e dispositivo di addestramento alla produttività cognitiva» (p. 119).
Se gli anni Sessanta sono stati attraversati dall’idea di sabotare il sistema-macchina per il suo produrre alienazione, gli Ottanta sono stati percorsi dal desiderio di abitarlo. Alla società dello spettacolo si sostituisce la società ludo-disciplinare e se la tv catturava lo sguardo, il NES cattura il gesto. «Politicamente, significa spostare il controllo dal flusso dei contenuti (palinsesto televisivo) alla gestione di un ambiente chiuso (ecosistema Nintendo). Culturalmente, è un passaggio decisivo: non si acquista un videogioco, ma si aderisce a una forma di cittadinanza ludica sotto l’egida di una multinazionale» (p. 121).
Se il Family Computer nipponico si presenta come progetto politico-tecnico mirante a rendere domestico il computer, il NES statunitense guarda invece all’intrattenimento come a una pratica disciplinante al pari della pressoché coeva diffusione dell’aerobica sugli schermi televisivi: in entrambi i casi si tratta di dispositivi fondati su protocolli di ripetizione, frazionamento e misurazione del tempo.
L’universo dei videogame, sottolinea Bittanti, non può essere analizzato attraverso gli approcci e le categorie con sui si guarda a media tradizionali. «La televisione è flusso. Il cinema è sequenza. Super Mario Bros. rompe entrambi: è loop e controllo». Dalla televisione questo videogame «eredita la bidimensionalità, la frontalità, la grana luminosa dello schermo CRT. Ma ne sovverte il principio fondamentale: la passività. […] Il tempo non è scandito da una sceneggiatura, ma dal gesto». Rispetto al cinema, invece, il videogame rinuncia alla trama, alla psicologia e ai dialoghi producendo una nuova forma di agency. «La narrazione non si sviluppa nel tempo, ma nello spazio. Non ci sono scene, ma livelli. Ogni passaggio non racconta, sfida. Ogni mondo non dice, struttura. È la conversione del racconto in architettura interattiva» (p. 143).
Per quanto il ricorso ai videogame come palestra per le macchine abbia radici lontane, l’utilizzo di videogame come Super Mario Bros. per allenare gli algoritmi, con la sua pianificazione sequenziale, cambia le carte in tavola. Ricorrendo a una retorica procedurale, i videogame argomentano attraverso regole: a confrontarsi con esse è direttamente una macchina, non un essere umano. «Così, Mario non smette di produrre effetti disciplinanti: allena non più le dita dei bambini ma le reti neurali delle macchine. Quella che era una promessa ludica diventa un addestramento invisibile per sistemi che guideranno auto, esploreranno pianeti, gestiranno elezioni, lanceranno missili nucleari sulle nostre città» (p. 154).
Nell’ultima parte del volume, Bittanti passa dettagliatamente in rassegna interventi artistici volti a trasformare il congegno ludico in materiale simbolico. Nel ricostruire le motivazioni che hanno a lungo escluso i videogame dai circuiti deputati a conferire uno statuto artistico, lo studioso ricorda come questi siano stati distribuiti, fruiti e valutati in un contesto prettamente commerciale. Quand’anche un videogame ha conquistato la presenza in un contesto espositivo, ad ottenere legittimazione non è il gioco in sé ma, piuttosto, la manipolazione, l’uso, che ne fa un intervento artistico postumo. Soltanto quando il videogame cessa di adempiere allo scopo per cui è stato pensato e realizzato sembra potersi aprire all’artisticità. Con riferimento a Super Mario Bros., Bittanti individua quattro modalità principali di disattivazione che possono comunque intersecarsi: la sottrazione funzionale (cancellazione delle regole e degli obiettivi del gioco) a cui ricorrono, ad esempio, lo statunitense Cory Arcangel e la canadese Myfanwy Ashmore; la riduzione iconica (riduzione del gioco a immagine astratta, anti-narrativa) a cui si rifanno, tra gli altri, lo statunitense Ben Fry e il greco Miltos Manetas; il deragliamento procedurale (esplicitazione dei limiti del codice in modo da rivelare la natura di macchina e sistema, apparato e dispositivo del gioco) utilizzato, ad esempio, dallo statunitense Alexander Galloway e dal cubano Rewell Altunaga; la ricontestualizzazione curatoriale e infrastrutturale (ricontestualizzazione del gioco così da ridefinirne statuto e funzionamento) a cui ricorrono lo statunitense Patrick LeMieux e artisti già citati come Arcangel e la Ashmore. Tutti questi interventi artistici compiuti su Super Mario Bros., nota lo studioso, aggirano le logiche predefinite dei videogame adottando strategie di appropriazione, sabotaggio e riscrittura: il dispositivo ludico viene trasformato in oggetto concettuale, in immagine critica, in gesto espositivo. È interessante notare come diversi interventi artistici contrastino l’insistenza sul fallimento individuale centrale in molti videogame.
La realtà che si vive oggi, conclude Bittanti, non è stata prevista dall’universo videoludico, ma è stata (anche) da questo programmata. Super Mario Bros. ha «insegnato a considerare l’errore una routine, la ripetizione un destino, la vittoria un checkpoint provvisorio. È così che Mario si è insinuato nella cultura: trasformando il gesto in pensiero, la pratica in metafora, la frustrazione in pedagogia» (p. 243).



