di Sandro Moiso
 Fernando Rosas, Mário Artur Machaqueiro, Pedro Aires Oliveira (a cura di), L’Addio all’Impero 1975: l’indipendenza delle colonie portoghesi, edizione italiana a cura di Francesco Ambrosini, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2025, pp. 436, 27 euro
Fernando Rosas, Mário Artur Machaqueiro, Pedro Aires Oliveira (a cura di), L’Addio all’Impero 1975: l’indipendenza delle colonie portoghesi, edizione italiana a cura di Francesco Ambrosini, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2025, pp. 436, 27 euro
Le edizioni Mimesis sono state tra le poche in Italia, forse le uniche, a “celebrare” un cinquantenario talmente scomodo per l’Occidente da essere quasi del tutto rimosso dall’immaginario e dalla storiografia al di fuori del Portogallo. Naturalmente quello di cui si sta qui parlando è quello della Rivoluzione dei garofani del 1974 e dalla sue successive evoluzioni politiche, sociali, militari e “coloniali” avvenute nel corso dell’estate calda del 1975.
Un evento che, come ha già avuto modo di dire in altre occasioni chi qui scrive, a distanza di decenni e in tempi di guerra e di crisi sistemica dell’ordine occidentale, già allora si distinse, anche se per un periodo intenso ma breve, per l’allarme suscitato nei media internazionali e, almeno in parte, negli schieramenti all’epoca ancora definiti dalla suddivisone del mondo in due blocchi.
Una rivoluzione che, se aveva fatto scrivere ad una importate testata giornalistica britannica che: «Il capitalismo è morto in Portogallo», aveva avuto però i suoi effetti più sconvolgenti e duraturi in Africa, nei territori un tempo facenti parte dell’”impero” portoghese: Angola, Mozambico, Guinea Bissau e Capo Verde. Effetti che, tuttavia, hanno finito col riflettersi ancora sulla vita politica del Portogallo fino ai nostri giorni. Come ben spiegano alcuni dei saggi contenuti nell’opera collettanea appena pubblicata da Mimesis, ma la cui prima edizione uscì in lingua originale una decina di anni fa.
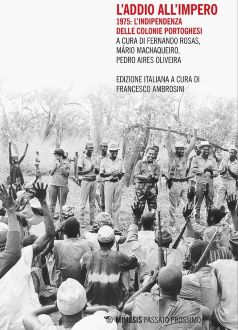 Una raccolta di saggi che oltre ad illustrare le vicende politiche e militari che si svolsero in quei paesi negli anni precedenti e successivi al verão quente (periodo formalmente compreso tra l’11 marzo e il 25 novembre 1975), affronta anche il problema dell’anticolonialismo tardivo della sinistra istituzionale portoghese e le ambiguità della stessa nei confronti dei problemi collegati alla resistenza dei popoli africani contro la dominazione lusitana su una parte del continente.
Una raccolta di saggi che oltre ad illustrare le vicende politiche e militari che si svolsero in quei paesi negli anni precedenti e successivi al verão quente (periodo formalmente compreso tra l’11 marzo e il 25 novembre 1975), affronta anche il problema dell’anticolonialismo tardivo della sinistra istituzionale portoghese e le ambiguità della stessa nei confronti dei problemi collegati alla resistenza dei popoli africani contro la dominazione lusitana su una parte del continente.
Una dominazione che, a differenza di altre, si era estesa ben prima del congresso di Berlino del 1884-1885 per la spartizione dell’Africa tra le varie potenze europee, essendo iniziata proprio a partire dalle prime esplorazioni atlantiche avviate dal regno portoghese, prima ancora della successiva espansione ispano-lusitana verso le Americhe, successive alla “scoperta” di Cristoforo Colombo.
Fatti, tutti, sospesi ancora oggi tra Storia e Mito che troppo spesso rimuovono dall’immaginario collettivo, formatosi attraverso i libi di storia euro-centrica in uso, il punto di vista e le sofferenze di quei popoli che in seguito furono definiti “sottosviluppati”, “primitivi” e “incivili”. Una visione della Storia e dell’Impero (portoghese) che fu però messa radicalmente e definitivamente in discussione dall’incontro tra i soldati portoghesi inviati a “governare” e sopprimere le rivolte dei colonizzati, prima, con le difficoltà e le sofferenze affrontate nella conduzione di quelle guerre e, successivamente, con i rappresentanti e i combattenti dei movimenti di liberazione con cui dovevano fare quotidianamente i conti.
Una situazione che fu alla base della rivoluzione del 25 aprile 1974, ribaltando i malumori e lo scontento non soltanto della truppa ma anche degli ufficiali sul destino politico del più longevo regime “fascista” d’Europa, finendo coll’affossarlo nel giro di pochissimo tempo, ma che successivamente tornò sui luoghi di origine contribuendo a liberare le colonie in tempi brevissimi e, in qualche modo, inaspettati sia per i Portoghesi nostalgici di un impero che da tempo non poteva più definirsi tale che per gli stessi movimenti di liberazione africani.
La forza dirompente che crea il cambiamento è il Movimento das Forças Armadas, costituitosi nella seconda metà del 1973 su iniziativa dei quadri intermedi delle Forze Armate. E’ in particolare nella Guinea Bissau che si è sviluppata la ribellione da parte dei militari coinvolti nella guerra coloniale, in opposizione all’ideologia “imperiale”, mettendo in discussione l’ordine su cui si basava lo stesso regime dittatoriale e aprendo la strada alle istanza democratiche. La pretesa del regime di Lisbona di difendere un anacronistico impero coloniale, obbligando i suoi soldati a combattere contro i movimenti indipendentisti, ha fatto scattare la scintilla dell’insurrezione che ha provocato l’abbattimento della dittatura.
A sua volta l’affermarsi del nuovo sistema democratico in Portogallo, seppure tra contrasti e posizioni differenti, determina e condiziona fortemente il percorso di concessione dell’indipendenza tramite negoziati ai territori coloniali. Viene impressa un’accelerazione a quel percorso, trovando un terreno di confronto con le realtà locali, grazie al ruolo che avevano assunto molti movimenti di liberazione, divenuti soggetti politici a livello internazionale, per mezzo delle reti transnazionali di sostegno alle istanze anticoloniali […] Rivoluzione e decolonizzazione sono dunque due fenomeni interconnessi e costituiscono i cardini della profonda trasformazione che investe il Portogallo e i suoi territori d’Oltremare alla metà degli anni Settanta. Ciò comporta grandi mutamenti per l’ex madre patria portoghese e ridefinisce anche la geopolitica mondiale, dato che tutte le ex colonie africane passano dall’orbita occidentale a quella sovietica. Si chiude definitivamente la pagina coloniale che il Portogallo aveva aperto cinque secoli prima1.
 Il sollevamento militare in chiave rivoluzionaria era stato successivo sia alle conseguenze della guerra in Vietnam, che proprio nel 1975 si chiuse definitivamente, sul morale e sulla scarsa disponibilità all’ubbidienza agli ordini e agli ufficiali delle truppe americane coinvolte che a quelle che, secondo alcuni autori, avrebbero prolungato la propria influenza dopo l’indipendenza algerina dei primi anni Sessanta sui soldati e sulla società francese, fino alla crisi del maggio del ’68 che determinò il definitivo allontanamento del generale De Gaulle dal governo del paese.
Il sollevamento militare in chiave rivoluzionaria era stato successivo sia alle conseguenze della guerra in Vietnam, che proprio nel 1975 si chiuse definitivamente, sul morale e sulla scarsa disponibilità all’ubbidienza agli ordini e agli ufficiali delle truppe americane coinvolte che a quelle che, secondo alcuni autori, avrebbero prolungato la propria influenza dopo l’indipendenza algerina dei primi anni Sessanta sui soldati e sulla società francese, fino alla crisi del maggio del ’68 che determinò il definitivo allontanamento del generale De Gaulle dal governo del paese.
Il riferimento alla Francia post-coloniale è reso possibile anche per le implicazioni che, in entrambi i casi, l’indipendenza delle colonie ebbe sull’immaginario e l’ideologia espressa dalle sinistre istituzionali di entrambi paesi fino al brusco risveglio causato dall’indipendenza dei popoli precedentemente “sottomessi”.
L’opposizione repubblicana alla Ditadura Militar e l’opposizione democratica liberale al salazarismo che le succedette […] criticavano la politica coloniale del regime dittatoriale in nome di un colonialismo riformista, umano, modernizzatore, che disprezzava il centralismo autocratico della gestione salazarista dell’Impero, gli abusi contro gli “indigeni”, l’abbandono dei coloni, i ritardi nell’educazione, nelle comunicazioni, nelle condizioni di vita ecc. Tuttavia non misero mai in discussione il colonialismo lusitano in sé, la legittimità della sua presenza, la coesione con la “madrepatria” e non si avvicinarono in nessun momento a niente di simile al riconoscimento del diritto dei popoli all’autodeterminazione e all’indipendenza.
In altre parole, per l’opposizione repubblicana, in conformità con tale prospettiva,la questione coloniale fu sempre un problema secondario, settoriale, per così dire, riguardo alla priorità nazionale della lotta anti-salazarista.
Si dà il caso che tale repubblicanesimo […] godrà sempre di enorme influenza politica e ideologica nei confronti dell’opposizione di sinistra, in particolare del PCP (Partito Comunista Portoghese) […] Tale determinante influenza ideologica e tattica si rivelò in modo chiaro nelle formulazioni programmatiche e nei discorsi contro la politica coloniale di tutti i momenti di unità delle opposizioni all’Estado Novo, dagli anni Trenta fino all’inizio dei Sessanta.
[…] Naturalmente, quel riformismo coloniale, così come l’ambito politico che lo alimentava […] verranno letteralmente sommersi dall’ondata di radicalizzazione politica e ideologica che caratterizzò le opposizioni al regime (quelle tradizionali e quelle che in tale momento emersero come nuove forze) alla fine degli anni Sessanta o all’inizio dei Settanta. Ma quell’atteggiamento2 era stato invece largamente presente, tra gli anni Trenta e Quaranta, come caratteristica dell’antifascismo portoghese3.
Attraverso queste poche righe è però possibile anche cogliere tutto il colonialismo travestito da perbenismo e umanitarismo che caratterizza ancora tante politiche ritenute progressiste, liberali e di “sinistra” ai giorni nostri. Questione di Gaza compresa4.
A queste osservazioni sul tardivo anticolonialismo dell’antifascismo portoghese vanno ricollegati i dissapori, se così vogliamo chiamarli, sull’arrivo nella madrepatria, durante l’”estate calda”, «di circa 550.000 “portoghesi” delle ex- colonie, molti dei quali amareggiati per le circostanze della fine del periodo imperiale, l’irrompere delle guerre civili in territori come Angola e Timor Est, e la instaurazione generalizzata dei sistemi politici “a partito unico” negli altri pesi africani di lingua ufficiale portoghese», fatto che determinò un cambiamento di atmosfera rispetto al processo di decolonizzazione5.
In una certa misura i rimpatriati delle ex colonie (i retornados) avrebbero rappresentato il “lato oscuro” della Rivoluzione portoghese. Successivi sondaggi di opinione effettuati tra il 1978 e il 2004 hanno riferito una percezione ricorrente: la generalità degli intervistati manifestava soddisfazione riguardo alla fine delle guerre coloniali, accettava l’inevitabilità della decolonizzazione, ma riteneva che questa fosse stata mal gestita. L’idea di una élite responsabile di errori di vario tipo, compresa l’indifferenza riguardo agli “interessi” dei portoghesi che abitavano nei territori dell’Oltremare, ha avvelenato il clima della politica in Portogallo per diversi anni e si è dimostrata persistente. Le sue radici affondavano nel retroterra di forti disaccordi che caratterizzarono tutto il periodo rivoluzionario, fomentati in larga misuta da esponenti politici generalmente schierati a destra, ma vi erano accese critiche […] rivolte da intellettuali “non allineati” o da elementi dell’area socialista6.
Quanto fino ad ora enunciato, però, non costituisce che una piccola parte di ciò che sarebbe necessario riassumere a proposito di un testo che si muove con ricchezza di dati, fonti e ricostruzioni storico-politiche e militari in un contesto in cui i fatti ricollegabili alla rivoluzione portoghese e all’indipendenza delle colonie lusitane sono inseriti via via sia nel panorama internazionale, ancora segnato dagli ultimi bagliori della guerra fredda, sia tra i diversi, ancorché simili, percorsi dei vari movimenti di guerriglia, di cui uno soltanto, trattato come gli altri in uno specifico saggio, rimase fuori dall’indipendenza: il FRETILIN (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente), movimento di liberazione di Timor Est, sorto come tutti gli altri movimenti indipendentisti dell’isola asiatica, nel 1974.
In questo caso, però, il fallimento dei sogni indipendentisti, realizzatisi soltanto a partire dal 1999, non fu dovuto a uno sforzo portoghese di impedire l’emancipazione della parte dell’isola facente parte dei possedimenti dell’Oltremare, ma ad un intervento diretto delle forze armate indonesiane che, dopo i primi interventi oltre confine nell’estate-autunno del 1975, occuparono la parte orientale dell’isola nel dicembre dello stesso anno. Intervento che oltre ad accondiscendere le mire espansionistiche del grande paese asiatico, continuava l’azione di repressione dei movimenti indipendentisti e “comunisti” iniziata nel 1965, con l’appoggio degli Stati Uniti, con l’eliminazione di almeno un milione di civili indonesiani accusati di essere “comunisti”7. Fu così che il FRETILIN e gli altri movimenti di liberazione nazionale si trovarono a combatter contro l’occupazione indonesiana per un altro quarto di secolo.
 Oggi, mentre il dominio occidentale sul mondo sembra essere giunto al suo prevedibile tramonto, e non soltanto in virtù della recente conferenza dei paesi asiatici tenutasi a Tianjin agli inizi di settembre oppure della sfarzosa parata militare cinese di piazza Tienanmen, il testo pubblicato da Mimesis si dimostra estremamente utile per comprendere il percorso del declino di un imperialismo, prima, portoghese e, poi, occidentale sempre più straccione nella sua ormai acclarata e sempre più insostenibile volontà di potenza. Destinata a concludersi, esattamente come quella dell’Estado Novo di Salazar e dei suoi successori, in nient’altro che in uno schianto di cui a far le spese saranno momentaneamente e prima di tutto i popoli e i giovani dei paesi e continenti coinvolti. Come i passeggeri di un tram a cremagliera rimasto privo di freni e strumenti di controllo.
Oggi, mentre il dominio occidentale sul mondo sembra essere giunto al suo prevedibile tramonto, e non soltanto in virtù della recente conferenza dei paesi asiatici tenutasi a Tianjin agli inizi di settembre oppure della sfarzosa parata militare cinese di piazza Tienanmen, il testo pubblicato da Mimesis si dimostra estremamente utile per comprendere il percorso del declino di un imperialismo, prima, portoghese e, poi, occidentale sempre più straccione nella sua ormai acclarata e sempre più insostenibile volontà di potenza. Destinata a concludersi, esattamente come quella dell’Estado Novo di Salazar e dei suoi successori, in nient’altro che in uno schianto di cui a far le spese saranno momentaneamente e prima di tutto i popoli e i giovani dei paesi e continenti coinvolti. Come i passeggeri di un tram a cremagliera rimasto privo di freni e strumenti di controllo.
F. Ambrosini, Nota introduttiva a F. Rosas, M. A. Machaqueiro, P. Aires Oliveira (a cura di), L’Addio all’Impero 1975: l’indipendenza delle colonie portoghesi, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2025, pp. 9-10. ↩
Rispetto per le “personalità della Repubblica” e necessità di riformare l’amministrazione delle colonie “senza arrecare pregiudizio all’unità dell’Impero” e della “dignità della patria e della sua estensione territoriale nell’Oltremare”. ↩
F. Rosas, L’anticolonialismo tardivo dell’antifascismo portoghese in F. Rosas, M. A. Machaqueiro, P. Aires Oliveira (a cura di), op. cit, pp. 32-34. ↩
Si veda in proposito: S. Moiso – G. Strippoli, Riti di passaggio. Cronache di una rivoluzione rimossa. Portogallo e immaginario politico 1974-1975, Edizioni Mimesis, 2024, pp. 127—128. ↩
F. Rosas, M. A. Machaqueiro, P. Aires Oliveira, Prefazione a L’Addio all’Impero, op. cit., pp. 23-24. ↩
Si veda in proposito: V. Bevins, Il metodo Giacarta. La crociata anticomunista di Washington e il programma di omicidi di massa che hanno plasmato il nostro mondo, Giulio Einaudi Editore, Torino 2021. ↩



