di Gabriella Bianco
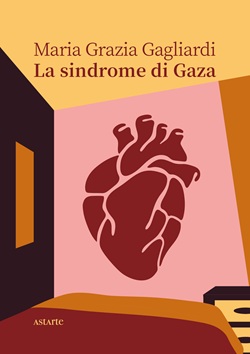 Maria Grazia Gagliardi, La sindrome di Gaza, Astarte Edizioni, Pisa, 2025, pp.165, euro 14,00.
Maria Grazia Gagliardi, La sindrome di Gaza, Astarte Edizioni, Pisa, 2025, pp.165, euro 14,00.
“Dal confine di Erez all’albergo sono poche miglia, il traffico rado, qualche carretto tirato da asini trotterella di lato incredibilmente veloce. Polvere e vento. Poi si sente l’odore del mare, i campi verdeggiano, le strade si popolano. Appaiono palazzi alti e non finiti, miriadi di costruzioni povere, tra le quali ne affiorano di più lussuose. Molte le case danneggiate: campeggia l’incuria, la miseria, la guerra. Il taxi imbocca una strada a quattro corsie. Un ospedale, un’università dagli eleganti archi islamici dipinti di un fresco azzurro-verde. Sul balcone di una palazzina la bandiera ONU, più avanti al semaforo la targa UNRWA e una moschea. ‘Sono entrata nella più grande prigione del mondo’ aveva pensato Elena” (pag.91).
Nel leggere il romanzo di Maria Grazia Gagliardi “La sindrome di Gaza” – Astarte edizioni – appena pubblicato, ci si interroga sul senso delle storie che questo libro racconta: che cosa le collega? qual è l’affinità che crea un’unità, una coerenza sotto l’esplicitezza delle trame? Perché narrare non è semplicemente raccontare storie, e le storie non sono né buone né cattive per il loro pathos, ma per come sono raccontate, cioè per l’individuazione di una voce che le connette. È certo che la scrittura sa più del suo autore ed anche del lettore. Questi ultimi come i personaggi sono in cammino verso una verità che non conoscono e che forse si delineerà alla fine della storia. Il troppo vicino scompare, più pensiamo di avvicinarci, più la verità si allontana da noi.
Il protagonista del romanzo, Amelio, si presenta subito come un “uomo senza qualità”, un superficiale cui preme portarsi a letto più donne possibili, eppure capiamo che nasconde un tormento rimosso perché Amelio digrigna i denti (soffre di bruxismo) ed è denominato il “digrignatore”.
L’altro doloroso protagonista di questa storia è il popolo palestinese.
Il giorno della morte di sua madre, Amelio bambino vede alla televisione un filmato sulla strage nel campo profughi di Sabra e Shatila. “Una mamma morta. Tante mamme morte. Quante mamme morte? Quanti bambini soli? Uomini cattivi col fucile avevano sparato senza pietà. Bombe e granate erano state lanciate. L’incontro con il dolore si fa in tenera età”. (pag. 20)
Da quel momento la storia personale di Amelio si intreccia giorno dopo giorno con la storia del popolo palestinese, anche se da cinico adulto “ ha accettato che la miseria è scontata e l’ingiustizia solo una coperta trasparente che avvolge l’umanità intera. Come abbia appreso queste regole, se glielo chiedete, non ve lo saprà spiegare; tuttavia, il dolore del mondo arriva a levigare gli animi quanto l’acqua torbida di un fiume arrotola i suoi ciottoli”. (pag.33)
Questo è un passaggio che dobbiamo tenere presente se vogliamo mettere insieme la trama e, come un puzzle, tornare indietro e ricomporla, facendo attenzione all’immagine che Amelio proietta di se stesso, perché la sua storia, anche se è una versione personale dei fatti e può sembrare secondaria rispetto alla grande Storia, la Storia dei popoli oppressi e perseguitati, ha una sua ragion d’essere. Siamo ciò che raccontiamo degli altri, ma anche ciò che raccontiamo di noi stessi.
In missione in Medio Oriente per svolgere un’indagine statistica, il digrignatore, incontra la collega Elena, anche “Elena digrigna i denti e come lui può azzannare” (pag. 30) e ne nasce una relazione amorosa. La loro storia d’amore e di sesso si svolge in contemporanea all’operazione Piombo Fuso dal 28 dicembre 2008 al 19 gennaio 2009, quando Israele bombarda Gaza uccidendo 1385 palestinesi e ferendone 5300. L’autrice ci presenta con cadenza inesorabile i bollettini di guerra di quel primo attacco sulla Striscia: i morti, i feriti, i bombardamenti.
Gagliardi lascia aperto il finale per la coppia – forse ormai coppia – Elena e Amelio, figli di un occidente scettico e indifferente. Anche la fine di Gaza non è stata ancora scritta, ci sorreggono la speranza, la pietà e l’indignazione, mentre “La vergogna continua”. (pag. 165)
In conclusione, come in ogni storia, bisogna imparare ad ascoltare il silenzio dell’opera. In questo romanzo il personale si mescola con il dramma di un popolo; il conteggio delle aggressioni sistematiche sulla popolazione di Gaza scandisce il ritmo della narrazione evitando che le vicende individuali prendano il sopravvento.
Gagliardi parla dei gazawi attraverso la storia e le statistiche, ma grazie a quei dati ci obbliga a ricordare il dramma di un popolo. Assediati dentro la Striscia di Gaza, molti dei suoi abitanti scendono al mare solo per provare a se stessi che esiste il tramonto, e lontano, oltre la riva, si stendono altre terre e altri destini. Questa angoscia viene condivisa chiaramente da Elena, quando si accorge che il suo visto è per un solo ingresso, non si contemplano uscite e ritorni. Se sopravvivi alle bombe ed ai fucili, sai che passerai tutta la vita in questa striscia assediata. Eppure, lontano dalla loro terra gli abitanti sentirebbero subito la mancanza delle fragole, dei limoni e delle arance di Gaza, dei suoi profumi. Niente può uguagliare camminare lungo il mare di Gaza e godere dei suoi tramonti, contemplando quell’immensità che ci rende consapevoli della nostra piccolezza, e al tempo stesso della quotidianità grandezza di un popolo. Anche loro, Elena e Amelio, come i gazawi, consapevoli dello scorrere del tempo e della vacuità di guerre feroci, in quel transito vorrebbero andare oltre l’orizzonte e aprire i confini, affinché tutti possano finalmente sentirsi ed essere liberi.



