di Sara Passannanti
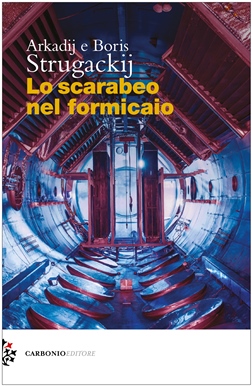 Arkadij e Boris Strugackij, Lo scarabeo nel formicaio, con una postfazione di Boris Strugackij, trad. Claudia Scandura, pp. 256, € 18,50, Carbonio, Milano 2024.
Arkadij e Boris Strugackij, Lo scarabeo nel formicaio, con una postfazione di Boris Strugackij, trad. Claudia Scandura, pp. 256, € 18,50, Carbonio, Milano 2024.
“Noi non avevamo scritto un giallo. Noi avevamo scritto una storia tragica sul fatto che, persino nel mondo più buono e giusto possibile, l’apparizione della polizia segreta porta inevitabilmente sofferenza e morte a persone che non sono colpevoli di nulla, per quanto nobili siano gli scopi di questa polizia segreta e per quanto onesti, corretti e per bene siano i collaboratori di cui si è dotata.”
Corre l’anno 2179. Maksim Kammerer, agente al servizio della Commissione di Controllo (COMCON), riceve l’incarico di trovare Lev Abalkin, esiliato dalla Terra che è tornato sul pianeta senza registrare il proprio ingresso. Tutto quello che Kammerer sa di Abalkin è che è un progressore, ovvero un esperto facilitatore nelle relazioni interplanetarie.
Inizia così a prender forma una detective story nella quale la caccia all’uomo si trasforma pagina dopo pagina in ricerca della verità e in cui più volte Maksim Kammerer (e noi con lui) si trova a chiedersi quale sia la parte del giusto, in un conflitto che travalica quello individuale tra fuggitivo e inseguitore.
Più di altri romanzi dei fratelli Strugackij, Lo scarabeo nel formicaio appare dialogico già nella sua costruzione: un dialogo in cui le domande hanno più rilevanza delle risposte e in cui le stesse risposte non hanno mai la forma di affermazioni, piuttosto di ipotesi; ma comunque un dialogo che rende vive le motivazioni dell’una e dell’altra parte. Gli autori mescolano le carte: una detective story scritta come una relazione investigativa dal taglio scientifico, schematico, in cui le ipotesi vengono scandagliate e tutti i passaggi di azione vengono precisati in modo analitico (con indicazione metodica di date, orari, durate e localizzazione: la frase di apertura del romanzo è proprio “Alle tredici e diciassette Sua Eccellenza mi convocò”); dall’altro lato, un romanzo nel romanzo che consta di un dossier scientifico vero e proprio, detto semplicemente “Rapporto di Lev Abalkin sull’operazione Mondo Morto”, la cui forma invece è libera e concepita per consentire agli psicologi di desumere dal testo le sensazioni soggettive e personali del suo autore.
Anche all’interno di ciascuno dei due blocchi narrativi c’è poi un continuo gioco di doppi.
Oltre alla contrapposizione Kammerer/Abalkin, il conflitto che innesca tutta la vicenda è quello tra i due monoliti Rudolf Sikorski e Isaak Bromberg. Entrambi sono a conoscenza del mistero che aleggia intorno ad Abalkin ma, mentre Bromberg, anziano storico ottimista, reputa Lev innocuo come uno scarabeo in un formicaio, Sikorski, a capo del COMCON, deve farsi carico della sicurezza mondiale e pertanto assume una postura sospettosa e valuta Lev come una possibile minaccia per la Terra.
Nel dossier, l’elemento del doppio è incarnato nella coppia formata da Lev Abalkin e Ščekn, un ranger appartenente alla specie dei testoni, alieni con l’aspetto di uomini-cane. Uno dei temi più affascinanti nel testo è la descrizione del rapporto tra le due diverse specie, umana e testona. Si tratta di una relazione complessa, perché presenta contemporaneamente elementi di trasparenza e di opacità: trasparenza nel momento in cui i testoni sono perfettamente integrati in un ambiente e perciò le loro azioni appaiono “naturali”; opacità perché tale disinvoltura è legata a un istinto che segue regole aliene diverse da quelle alle quali è sottomessa la razionalità umana e ha delle motivazioni che sono e restano incomprensibili. Lungo tutto il suo rapporto, Lev Abalkin si interroga sulle azioni del suo amico Ščekn, cerca di interpretarne i movimenti, senza mai raggiungere ipotesi soddisfacenti. E noi che leggiamo abbiamo l’impressione di un profondo non detto e non dicibile che separa i due, un buco nella comprensione reciproca talmente profondo che ci porta a chiederci se e in che misura sia possibile un’amicizia non solo tra due specie diverse (certo, questo ci interroga a maggior ragione), ma tra due qualsiasi individui diversi, perché le intenzioni e i pensieri profondi dell’altro rimangono per noi sempre e solo sul piano delle ipotesi e della fiducia.
E questo risulta ancora più interessante se messo nella prospettiva di una scrittura a quattro mani, in cui non è scontato che i due autori insieme vogliano e non vogliano le stesse cose.
La diversità di Abalkin e Ščekn viene resa non solo attraverso il loro dialogo – o l’assenza di esso nelle riflessioni di Lev – ma anche attraverso la differenza di percezioni tra i due, così dove Lev vede “una casa come un’altra”, “Ščekn la guarda fisso, la punta con un’attenzione vigile” attribuendole un pericolo definito “un odio fortissimo”. O ancora, in un altro passaggio, Lev dice nella lingua dei testoni di non vedere alcuna fossa e Ščekn replica “Non puoi vedere. Non sei capace.”
È curioso che nella postfazione al romanzo questo, che in fase di progetto non aveva ancora un titolo, venga chiamato provvisoriamente “Bestie”, che è la parola che usiamo in due casi: quando dobbiamo indicare un animale non umano che non sappiamo identificare e quando vogliamo connotare negativamente l’animale. Entrambe le sfumature di significato sono presenti nel modo in cui i terrestri si riferiscono ai Viandanti.
In effetti, la comprensione dell’altro, dei suoi bisogni e delle sue intenzioni, non è solo il nocciolo del romanzo nel romanzo, ma si erge a tema portante di tutto il testo e ne influenza la struttura. È il motivo per cui Lev Abalkin scappa e viene inseguito e, prima ancora, per cui parte dell’umanità, nonostante sia un’utopia in cui tutti gli abitanti della Terra convivono nell’interesse del bene collettivo, è così spaventata dai sarcofagi-incubatrici che i Viandanti hanno abbandonato sul pianeta. Il problema dell’inconosciuto si propaga e si somma a un’ulteriore questione che i due autori hanno particolarmente a cuore, ovvero il ruolo della polizia segreta, per quanto utopica sia la società in cui essa opera e per quanto nobili siano le intenzioni dell’istituzione.
La sintesi tra queste due tensioni ci conduce alla domanda che costituisce il nodo cruciale del romanzo, nodo che non ha soluzione: in che misura è possibile superare la paura dell’ignoto e assicurare la sicurezza e il bene dell’intera civiltà terrestre senza sacrificare la libertà e i diritti dell’individuo?
Questa domanda, come l’indagine di Maksim Kammerer, rimane un mistero aperto, che ammette nessuna o più risposte possibili. Ed è sul dubbio che sia o meno possibile trovare una risposta al dilemma che Lo scarabeo nel formicaio instaura con noi che lo leggiamo un dialogo profondo e durevole.



