di Giorgio Bona
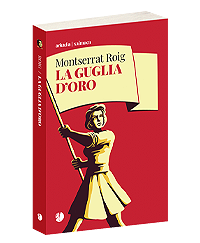 Montserrat Roig, La guglia d’oro, trad. Piero Dal Bon, pp. 250, € 18, Arkadia, Cagliari 2023.
Montserrat Roig, La guglia d’oro, trad. Piero Dal Bon, pp. 250, € 18, Arkadia, Cagliari 2023.
Montserrat Roig, nata a Barcellona nel 1946, scomparsa nel 1991 dopo una breve malattia, scrittrice e giornalista spagnola, è stata autrice di romanzi, racconti, reportage e articoli per i quali ha ricevuto diversi premi. Impegnata nelle lotte femministe e antifranchiste, ha militato in diverse organizzazioni, come il PSUC, dove nacque la sua amicizia con Manuel Vázquez Montalbán.
Nel 1980 si recò a Leningrado su invito della Casa Editrice Progresso di Mosca, per scrivere un libro sulla città durante l’assedio nazista. Nel corso di quel soggiorno iniziò una serie di incontri con i superstiti del terribile assedio, durato dall’8 settembre 1941 al 27 gennaio 1944. Quell’incarico rappresentò anche un periodo molto ricco e significativo per conoscere e apprezzare, parlandone con grande entusiasmo, la città e i suoi abitanti.
Monteserrat Roig consultò circa novemila pagine perché non voleva fornire documentazioni che potessero in qualche modo essere discutibili quando si presentò per la prima intervista al giornalista Abraham Burov, un uomo che era vicino ai settant’anni, di una freddezza metallica e che viveva ossessionato da quei novecento giorni in cui la città si trovava sotto il tiro delle forze naziste. Un passato che quell’uomo all’apparenza freddo riviveva giorno per giorno.
Non ho tralasciato un solo giorno dei 951 che vanno dal 22 giugno del 1941 fino al 27 gennaio del 1944, il giorno in cui definitivamente si ruppe l’assedio. Il fuoco d’artiglieria su Leningrado non cessò mai, dall’otto settembre.
Il libro riporta appunto la strenua resistenza dei civili, vicende legate agli assedi e alle battaglie epiche che si sarebbero combattute in tutto il territorio e che hanno contribuito a creare il mito di quella che ancora oggi i russi chiamano “La Grande guerra patriottica”.
La conquista di Leningrado, città della Rivoluzione, che doveva essere rapida, era uno degli obiettivi prioritari dell’Operazione Barbarossa delle truppe naziste. L’assedio non fu così breve e durò quasi tre anni. Quella che doveva essere un’operazione travolgente incontrò una grandissima resistenza perché all’Armata Rossa si unì una consistente partecipazione di persone civili.
Testimonianze vive portate nella chiave di un romanzo verità che rappresentò per i cittadini di Leningrado un periodo drammatico, con decine di migliaia di morti per fame, ferite di guerra, malattie, mentre i nazisti bombardavano caseggiati, scuole e ospedali per diffondere il terrore nella popolazione.
Il giorno 22 giugno 1980 era domenica e compivo trentanove anni. Non c’era su Leningrado neanche una nuvola, come era il primo giorno di guerra. Mentre guardavo il prato, i davanzali delle finestre, i ciottoli sulle strade, le panchine dei giardini e le aiuole dove crescevano i tulipani coperti da una cappa di pulviscolo, mi accorgevo che tutto era impregnato dal polline che veniva dagli alberi in primavera. La luce nordica, soave e biancastra, invadeva tutto quanto.
Vladimir Drujinin mi portò a vedere il nuovo balletto di Leningrado, diretto da Boris Eifman. Ricordo un pas de deus con musica dei Pink Floyd. Un uomo e una donna lottano per incontrarsi. I corpi, due ombre muscolose e rossastre, si allacciano fino a trasformarsi in una sola forma. D’improvviso l’uomo abbandona la donna per affrontare il mondo, dove ci sono la guerra e la distruzione. Litiga con i suoi fantasmi fino all’estenuazione, perché la donna lo osserva, dimenticata dal loro mondo privato. L’uomo cade nel vuoto e la donna, che non è rimasta segnata dalle forze esterne, lo raccoglie un’altra volta e lo salva. La tenerezza ha vinto sulla guerra. Però, prima, l’uomo voleva provare quello che c’era oltre il sentimento. Mentre assistevo al ballo, pensavo alla storia di due donne, Salì e Raìsa.
Salì conservava in ogni piega del volto screpolato e bruno, vestigia di una bellezza antica. Potevi indovinare, nei tratti della faccia e anche dei movimenti delle mani, una mescolanza di affinità e terrore. Le mani, a volte, si contraevano e si mescolavano subito dopo, come se facessero acrobazie tra il risentimento e la gioia di vivere. Sali aveva un’aria attiva, energica, anche un po’ sprezzante e timida. Non voleva parlare di sé stessa. Di tanto in tanto nascondeva, in una frase pronunciata a metà, quello che voleva tu indovinassi. Aveva nel portamonete una fotografia: mostrava una ragazza giovane, che era lei, come se si trattasse di un’altra persona. Passava molto tempo a guardare la ragazza dai grandi occhi neri, luminosi e pieni di illusione. La ragazza della fotografia aveva soltanto quindici anni e già andava ad alfabetizzare i contadini. Lavorò come infermiera durante l’assedio e i suoi occhi si intristirono.
La guglia d’oro nel racconto di quei giorni ancora vivi ci accompagna nel presente dentro la Russia degli anni Ottanta, quelli che anticipavano la Glasnost e la Perestrojka, che accompagnavano lo scioglimento dell’Unione Sovietica.
Nessuno si aspetti di leggere – si viene avvertiti – “un libro sul paradiso sovietico”, non si parla “di gulag e di ospedali psichiatrici. Di questo si fanno carico ogni giorno i giornali occidentali”.
In questo libro, innanzitutto, si respira un forte richiamo alla storia con uno dei fatti più terribili della seconda guerra mondiale e del novecento con l’assedio di Leningrado in primo piano raccontato con commozione da chi lo aveva vissuto in prima persona, fornendo fatti e luoghi ben precisi con aneddoti e vicende precise e dettagliate, quella che non si leggono sui libri di storia, aneddoti che calano nella vita vera.
Ci sono anche grandi richiami letterari, Dostoevskij, Puškin, c’è l’incanto davanti alla maestosità dei palazzi e dei monumenti ricchi della storia del paese.
Una visita sulla Piazza Rossa che secondo il russo antico si chiamava “Piazza bella” rappresenta il richiamo a un ricordo dell’infanzia e lega l’autrice a questo momento particolare.
Piazza Rossa, secondo il russo antico voleva dire “piazza bella”. Da piccola, credevo che i rossi fossero uomini di una razza malefica, di pelle rossa come il sangue. Questo me lo avevano insegnato le monache. E lì, in quell’immenso rettangolo, era nata tutta un’iconografia sbagliata dalla stessa radice.
Verso la fine di giugno, il consiglio militare del fronte del nord e le organizzazioni del partito della regione di Leningrado avevano elaborato un piano di fortificazione della città, dal lato sud fino all’istmo di Carelja. Nei mesi di luglio e agosto, sotto l’afa di un’estate molto calda, centinaia di migliaia di persone andarono a costruire una frangia di protezione che si stendeva per novecento chilometri. Erano studenti, scienziati, artisti, maestri e casalinghe. Uscivano con un badile e non riposavano neppure un secondo. Spesso dovevano scavare la trincea sotto la frusta dei bombardamenti nemici. L’idea era circondare Leningrado con anelli di protezione.
Con una scrittura attenta e lucidissima Montserrat Roig cerca di non mescolare e di tenere su due linee separate la narrazione reale con l’emozione. Ogni frase sembra il risultato di uno studio attento e meticoloso. Passato e presente si incontrano: il presente di quegli anni il passato, ovvero la storia, lo teneva per mano perché alla fine del viaggio dice
c’è una montagna che vedo ogni giorno. Così scomparve la guglia dorata dell’ammiragliato che segnalava, in gesto di sfida, il cielo di Leningrado. Scomparvero gli ubriachi delle notti bianche, le navi che scivolavano sulla Neva, la fortezza di Pietro e Paolo, il fratello di Lenin e i decabristi, le notti senza luna e i lampioni spenti… e il Tsinandali, il vino bianco della Georgia. Tutto svanì, rimasero soltanto le sensazioni.
Per dirla in breve.
No, non è vero: ci sono. Esistono. Li ho visti. All’altro lato c’è una metà di noi stessi. Per due mesi ho sognato di poter vivere senza frontiere.



