di Franco Pezzini
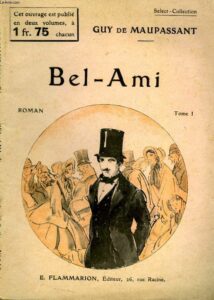 Il lettore distratto che si accosti a Bel Ami di Guy de Maupassant (1885) fatica senz’altro a realizzare che l’autore di questo gioiello del più spregiudicato realismo sia anche il padre di una serie di racconti fantastici tra i più conturbanti e sfuggenti della letteratura dell’ottocento: pensare che il rampante Georges Duroy condivida lo stesso universo dell’Horla sembra assurdo. Il fatto è che questo toro normanno che – si è detto – regge la penna come il remo, tanto netto nelle sue fotografie narrative, lavora idealmente a due livelli di sguardo: il primo, dell’occhio aperto e vitreo sulla realtà a forti tinte, spesso tossica, di una borghesia del secondo ottocento che ha occupato sgomitando tutti gli spazi possibili, ma ormai incapace d’imprese e di sorprese, ripiegata sulle caricature dei suoi grandi miti letterari (il viaggio, diventato la modesta gita con pranzetto fuori porta; l’amore, scipito in sesso e tedio; l’avventura, intravista nei saccheggi coloniali); il secondo, un occhio interiore allucinato, dischiuso da ferite d’infanzia mai composte, disagi d’ambiente e malattie strazianti in ultimo veneree. Penoso pensare che il secondo tipo di sguardo finisca con l’imporsi rabbiosamente sul primo, conducendo Maupassant a un’orrenda morte in una clinica, demente e paralizzato dalla neurosifilide, a soli quarantadue anni.
Il lettore distratto che si accosti a Bel Ami di Guy de Maupassant (1885) fatica senz’altro a realizzare che l’autore di questo gioiello del più spregiudicato realismo sia anche il padre di una serie di racconti fantastici tra i più conturbanti e sfuggenti della letteratura dell’ottocento: pensare che il rampante Georges Duroy condivida lo stesso universo dell’Horla sembra assurdo. Il fatto è che questo toro normanno che – si è detto – regge la penna come il remo, tanto netto nelle sue fotografie narrative, lavora idealmente a due livelli di sguardo: il primo, dell’occhio aperto e vitreo sulla realtà a forti tinte, spesso tossica, di una borghesia del secondo ottocento che ha occupato sgomitando tutti gli spazi possibili, ma ormai incapace d’imprese e di sorprese, ripiegata sulle caricature dei suoi grandi miti letterari (il viaggio, diventato la modesta gita con pranzetto fuori porta; l’amore, scipito in sesso e tedio; l’avventura, intravista nei saccheggi coloniali); il secondo, un occhio interiore allucinato, dischiuso da ferite d’infanzia mai composte, disagi d’ambiente e malattie strazianti in ultimo veneree. Penoso pensare che il secondo tipo di sguardo finisca con l’imporsi rabbiosamente sul primo, conducendo Maupassant a un’orrenda morte in una clinica, demente e paralizzato dalla neurosifilide, a soli quarantadue anni.
Legittimo cercare dunque un punto di raccordo o uno snodo ideale tra i due tipi di vista, a partire dal nesso più naturalistico, quello del corpo dell’autore – in origine di fibra robusta, solido, sportivo, vitalisticamente teso alla natura e in continua, vivace relazione con tanti amici e donne d’occasione. Guy ha senso degli affari, sa guadagnar bene, e per quanto si atteggi a maledetto, guadagna grazie a questo mondo borghese in cui pure la sua sincerità si trova a disagio, fuori posto. No, non è tanto nel corpo – fino a quello freddo coricato nella morgue – che può trovarsi un nesso.
La risposta, paradossalmente, ci giunge invece proprio da Bel Ami. Il vitalismo di Georges Duroy è diverso da quello di Guy e per certi versi ne rappresenta un doppio speculare, dunque opposto: eppure pochi romanzi appaiono dominati in modo tanto sconcertante dalla presenza della morte. Reduce da avventure in Nordafrica dove la morte di qualche arabo è per lui semplice motivo di sarcasmo, il normanno (come Guy) Georges vivrà la sua avventura sullo sfondo di un colonialismo predatorio che gioca la morte ai mercati di borsa. Introdotto dall’ex-commilitone Forestier – etimologicamente “guardia forestale”, custode ideale di quella selva dell’homo homini lupus che è il giornale La Vie Française dove lo fa assumere – gli subentra nel lavoro e nel talamo, sposandone l’affascinante moglie/egeria Madeleine, quando il collega (che incontriamo già malato) viene ucciso da una patologia polmonare. Da un collaboratore del giornale, il vecchio poeta Norbert de Varenne – una delle proiezioni di Maupassant nel romanzo, di straordinaria intensità – Georges riceve la lezione sulla prevalenza della morte, il suo insidioso dilagare ovunque: ma (ammette il poeta) è ancora troppo giovane per capire. Alla morte Georges è d’altronde costretto a pensare all’approssimarsi di un duello – che pure si risolverà in bagatella – e alla prospettiva di senescenza improvvisa e fine vita condanna la più infelice delle sue amanti, la matura Virginie Walter moglie del suo capo, dopo averla sedotta per vanità e senso dell’utile. La sensazione è dunque che lo spregiudicato commercio sessuale condotto da Georges con una pluralità, anche contemporanea, di amanti, finisca col riguardare sempre meno la vita e le sue pulsioni, e sempre più quell’isterilire nevrotico e necrotico che il vecchio poeta gli descriveva. Una inconscia, immatura fuga da ciò che lo incalza.
Il romanzo si chiude al matrimonio del Nostro con la figlia sedotta del capo, scena conclusa dal pensiero di Duroy all’amante continuamente ripresa e abbandonata Clotilde de Marelle (coi capelli “sempre disfatti all’uscir dal letto”: un caso che, da vocabolario, marelle sia la campana del gioco da cortile in cui si salta da una casella all’altra?): la sensazione è che l’arrampicatore sia giunto al vertice dei successi sociali, e che dopo inizierà il declino sotto l’egida della morte. Ma quel declino non occorre narrarlo, è già tutto tra le righe, predisposto a irrompere (forse tramite il giovane giornalista ora appoggiato da Madeleine, malamente ripudiata da Georges): Maupassant trova dunque inutile soffermarvisi. La morte è il vero punto di snodo tra i due tipi di vista. E del resto quel fiato di morte corre su tutta la società di cui il rampante Duroy è il furbesco – né tragico, né romanticamente diabolico – campione. All’inizio, buffo e maldestro, risulta persino simpatico: per divenire poi un invelenito furbetto del quartierino, col vento in poppa di un mondo a lui grossolanamente omologo.
Difficile non vedere, leggendo oggi Bel Ami dopo un’estate dominata da pasticci finanziari, sguaiate e rumorose separazioni nel bel mondo, affermazioni scandalose di rappresentanti dello Stato (i poveri mangiano meglio dei ricchi…), grottesche esternazioni sulla diversità, le donne & il mondo mondiale di autopromossi intellettuali o congiunti di politici, guerre condotte per interessi quasi coloniali, pessime performance di figli di potenti, uso delle donne come merce da letto, titoli di giornali a cortina fumogena, che l’Europa non è troppo cambiata. E in verità tra la borghesia irrancidita e metastatizzata del secondo ottocento francese (e non solo francese) e l’odierna ci sono almeno robusti punti di contatto. La letteratura ha fallito, non fornendo sufficienti spunti per riflettere? O non è piuttosto un’umanità persino peggiore di Duroy a rifiutare di mettere a frutto le lezioni di un altro tempo, pur di potere occupare impunemente – e senza neppure senso dell’ironia – spazi di potere politico, economico, mediatico, sessuale?
Ma, torniamo a sottolinearlo, Bel Ami non parla solo di questo, ma anche della morte che attende. Che attende poveracci come chi sta scrivendo questo pezzo, ma anche, con assai più fragore e scoli retorici, i Duroy della terra, gli arrampicatori, e poi tutti i potenti e i loro malassortiti collaboratori, cortigiani, scherani, complici… Oh, non è un augurio – io per primo mi auguro di restare ancora un po’ sulla terra – ma una riflessione concreta, davanti ai compiacimenti ministeriali sui chili presi in vacanza, alle risate degli epuloni sugli schermi tv mentre i Lazzari affondano coi barconi, a un imputridire beato e beante che precede quello fisico. Di quanto? Forse di poco, in fondo la morte – che “aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres” – ci raggiunge fin troppo rapidamente uno per uno (sì, anche Vostra Eccellenza che mi sta in cagnesco): e di fronte all’Indesiderata, i discorsi a effetto sotto i riflettori e le idiozie – griffate o meno da stellette – sulla pelle bianca e la razza italiana, i sorrisetti ammiccanti, gli orgogli fallici tamponati presto da pannoloni, o invece i musi duri cari all’elettorato non serviranno. Non servirà neppure un sacro usato per semplice parata, come nel matrimonio di Duroy, a far scorporare dall’ultimo film dei ricordi (che si dice scorra ai titoli di coda della vita) talune brutte sequenze, e magari la sensazione desolante d’essere soli e non aver capito niente. Perché lì, cerchiamo di ricordarlo, i titolatori da testata di regime e la fiera della porchetta non ci saranno più.




