di Gioacchino Toni
 Nell’occuparsi dei nuovi media, cioè di quegli agenti di cambiamento epocale – di cui fanno parte anche i dispositivi di comunicazione – che «sfruttano o potenziano la riproducibilità digitale dell’immagine», Tommaso Ariemma, Dark Media. Cultura visuale e nuovi media (Meltemi 2022), intende metterne in luce il lato oscuro e inquietante. L’autore propone una disamina della cultura visuale di massa promossa da tali media indagandone le trasformazioni nel corso degli anni Ottanta, Novanta e del primo decennio del nuovo millennio individuandone gli specifici registri stilistici di cui mette in luce le tonalità affettive e mediali. Nell’analisi proposta alla catastrofe degli anni Ottanta sarebbe seguita l’adolescenza infinita degli anni Novanta e una particolare costruzione identitaria propria dei tempi dei social del nuovo millennio.
Nell’occuparsi dei nuovi media, cioè di quegli agenti di cambiamento epocale – di cui fanno parte anche i dispositivi di comunicazione – che «sfruttano o potenziano la riproducibilità digitale dell’immagine», Tommaso Ariemma, Dark Media. Cultura visuale e nuovi media (Meltemi 2022), intende metterne in luce il lato oscuro e inquietante. L’autore propone una disamina della cultura visuale di massa promossa da tali media indagandone le trasformazioni nel corso degli anni Ottanta, Novanta e del primo decennio del nuovo millennio individuandone gli specifici registri stilistici di cui mette in luce le tonalità affettive e mediali. Nell’analisi proposta alla catastrofe degli anni Ottanta sarebbe seguita l’adolescenza infinita degli anni Novanta e una particolare costruzione identitaria propria dei tempi dei social del nuovo millennio.
Gli anni Ottanta, definiti dallo studioso come gli anni dell’“esplosione”, sarebbero caratterizzati da una specifica identità mediale votata a una produzione senza precedenti di narrazioni distopiche.
Gli anni Ottanta rappresentano una congiuntura straordinaria: virale (AIDS), tecnologica (l’avvio della diffusione senza precedenti dei personal computer), politica (il crollo dell’URSS e l’affermarsi della politica-spettacolo), ecologica (Chernobyl). Queste dimensioni gridano a gran voce: voi umani non siete il mondo.
Intrecciandosi, queste dimensioni portano alla luce una catastrofe mediale senza precedenti e una verità sull’essere che abbiamo sempre fatto fatica ad ammettere: essere è essere trasmesso. Trasmesso attraverso radiazioni, schermi, virus e non solo attraverso le forme umane del comunicare. La catastrofe mediale è l’emergere della trasmissione stessa, come trasmissione totale (p. 22).
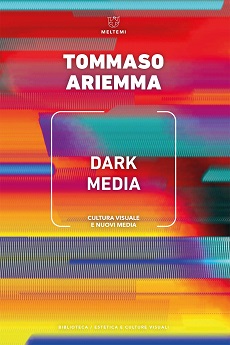 In un tale contesto, sostiene Ariemma, agli esseri umani si proponevano di venire in soccorso le interfacce grafiche “amichevoli” e “intuitive” del personal computer che con le loro simulazioni sugli schermi sembravano tranquillizzare promettendo la possibilità di gestire la complessità e con essa la catastrofe. «Le interfacce grafiche sono arrivate per darci l’illusione di un controllo quando tutto si stava sfaldando. Il mouse che avevamo in mano doveva scacciare l’idea che qualcosa ci stesse sfuggendo. Questo supporto, questo farmaco, si è rivelato a sua volta tossico» (p. 34)
In un tale contesto, sostiene Ariemma, agli esseri umani si proponevano di venire in soccorso le interfacce grafiche “amichevoli” e “intuitive” del personal computer che con le loro simulazioni sugli schermi sembravano tranquillizzare promettendo la possibilità di gestire la complessità e con essa la catastrofe. «Le interfacce grafiche sono arrivate per darci l’illusione di un controllo quando tutto si stava sfaldando. Il mouse che avevamo in mano doveva scacciare l’idea che qualcosa ci stesse sfuggendo. Questo supporto, questo farmaco, si è rivelato a sua volta tossico» (p. 34)
La distopia diffusa degli anni Ottanta sembrerebbe proporre un’anticipazione del futuro, quasi a voler far famigliarizzare con esso in anticipo rispetto al suo manifestarsi. Gli anni Ottanta sarebbero caratterizzerizzati non tanto dalla sensazione di “mancanza di futuro”, quanto piuttosto dal fatto che “il futuro è già presente”, basta soltanto avere il coraggio di individuarlo, magari ricorrendo ai media.
A produrre la premediazione distopica del futuro è, soprattutto, l’incremento esponenziale dell’innovazione tecnologica (da sempre un motore imprescindibile di ogni narrazione distopica), che, a partire dalla diffusione dei personal computer proprio negli anni Ottanta, presenterà la macchina, l’automa, l’algoritmo, come qualcosa che possiamo certamente utilizzare, senza avere tuttavia la possibilità di accedere al suo interno. Un tale interno diventerà sempre di più qualcosa di paradossale: una nuova interiorità, che non avrà più nulla a che fare con l’umano, se non per gli incubi che è capace di generare: soggetto, a ragione, sarà sempre più la macchina e sempre meno l’umano (p. 24).
Se negli anni Ottanta gli schermi più popolari restano quelli cinematografici e della televisione, nel corso del decennio, con il lancio del primo Macintosh prende il via un importante cambio di percezione sociale del computer: anziché macchina di calcolo inizia a essere pensato come mezzo di comunicazione. L’avvento dell’estetica della simulazione induce l’utilizzatore ad occuparsi della sola superficie visuale disinteressandosi delle strutture interne e del funzionamento.
La tensione distopica che attraversa gli anni Ottanta dà luogo, tuttavia, a una speculare tensione utopica all’interno di una vera e propria dialettica dell’immaginario. Il futuro è oscuro, la catastrofe è alle porte, le macchine sono sempre più minacciose e distanti: respinta, l’umanità tende allora a compattarsi, a riscoprire e a esaltare il valore dell’amicizia, soprattutto nell’immaginario della cultura di massa. All’interno di quest’ultimo è costante, infatti, l’elogio dell’amicizia come risorsa per affrontare il mostruoso e ogni sfida della vita. […] L’immaginario degli anni Ottanta ci prepara ad affrontare cadute, catastrofi, insieme a degli amici (pp. 29-30).
Secondo lo studioso si è probabilmente eccessivamente insistito nel tratteggiare gli anni Ottanta all’insegna del mero individualismo; a un’indubbia spinta in tale direzione si sono affiancati anche tentativi di arginare la deriva in direzione opposta.
Gli anni Ottanta sono stati anche gli anni dell’otaku, ossia del consumatore compulsivo di manga e anime giapponesi al chiuso della sua stanza. Si è facilmente indotti a mettere in luce la situazione di isolamento vissuta da tale soggetto ma, suggerisce Ariemma, si tratta in realtà di un ripiegamento in una “stanza profonda”, in un «luogo fatto di connessioni morbose tra reale e immaginario, per sfuggire al mondo attraverso un consumo immersivo di storie e immagini. Si tratta di ragazzi con uno strano rapporto con i loro fantasmi, tutti assorti nella loro personale arca, in fuga dal disastro. In attesa di tempi migliori, che non sarebbero mai arrivati» (p. 31).
Mossi da una brama di immergersi in storie in universi fittizi derivata dalla delusione che provavano nei confronti del mondo reale incapace di soddisfare le loro aspirazioni, questi ragazzi auspicavano
una socialità diversa, una socialità fatta di nicchie, bolle, priva di un centro, un nuovo stile di esistenza dominato sempre più dalle immagini digitali, caratterizzato dal “farsi immagine del mondo e dal farsi mondo dell’immagine”. Un modo di vivere estetico, che sarebbe diventato dominante attraverso un primato della sensazione, del sentire, su ogni livello, che si configurerà come una vera e propria strategia mediale condivisa. Dal punto di vista della sensazione anime, manga, videogiochi, film, serie televisive, hanno lo stesso grado, se non maggiore, di sensazione, rispetto alla “vita reale”. Il primato della sensazione, ovvero dell’immediato, ci avrebbe protetto da quanto stava avvenendo in termini di mediazione, di processi macchinici e biologici. Saremmo stati storditi (p. 32).
Per certi versi gli otaku degli anni Ottanta, sostiene lo studioso, nel loro accontentarsi dei “significati di superficie”, incapaci o impossibilitati a una visione profonda d’insieme, sembrano anticipare la cultura del Web.
Gli anni della sensazione sarebbero arrivati molto presto per tutti, come strategia mediale complessiva volta a stabilizzare e a diffondere la “cultura software”, ovvero la cultura delle interfacce e della simulazione, ponendo progressivamente fine al teatro dell’amicizia allestito dall’immaginario degli anni Ottanta. In questo modo, sarebbe venuto meno, dal punto di vista affettivo, quel calderone fatto di immaginario ed esperienze che aiutava, almeno i giovanissimi, a crescere, nonostante tutto. Al posto dell’amicizia sarebbe arrivata la brama di sentire e la trappola dell’adolescenza infinita, per separare in modo devastante, dal punto di vista sociale, gli individui tra loro, ognuno alla ricerca estatica di sensazioni, mandando in modo definitivo in crisi l’avvicendarsi delle generazioni. Tuttavia, proprio da questa separazione, così tipica degli anni Novanta, nascerà un desiderio di comunità senza precedenti: generico, universale. A sostenere questo desiderio sarà la Rete (p. 33).
Nel decennio successivo «pensiero e azione sarebbero stati come paralizzati. Al loro posto avrebbe preso il sopravvento un singolare bisogno di sensazione» (p. 37). Mario Perniola (Del sentire, Einaudi 1991) ebbe a dire a tal proposito che all’ideologia, socializzazione dei pensieri, si è andata a sostituire la “sensologia”, socializzazione dei sensi. Ne è testimonianza la trasformazione del panorama politico che in Italia, proprio nel corso degli anni Novanta, ha visto andare al potere la sensazione, anziché la fantasia auspicata a fine anni Sessanta. L’avvento di un mondo ridotto alla sensazione e alla simulazione è stato al centro di importanti riflessioni prodotte nel coso degli anni Ottanta e Novanta da studiosi come Jean Baudrillard.
Di fronte alla sensazione della “fine della Storia” sancita dalla caduta del muro berlinese (1989), dunque al dilagare di storie, gli anni Novanta hanno visto diffondersi l’ossessione del mantenimento di uno stato adolescenziale sospeso di fronte agli schermi televisivi via via sempre più sottili e diffusi ben oltre il salotto di casa.
 Ad annunciare un’epoca oscura ha provveduto la serie televisiva Twin Peaks (1990-1991) ideata da David Lynch e Mark Frost capace di rendere perturbante lo schermo domestico mettendo in scena una storia investigativa priva di approdo.
Ad annunciare un’epoca oscura ha provveduto la serie televisiva Twin Peaks (1990-1991) ideata da David Lynch e Mark Frost capace di rendere perturbante lo schermo domestico mettendo in scena una storia investigativa priva di approdo.
Stava già parlando di noi? Gli adulti rappresentati erano così immaturi, così vulnerabili e fragili. Non erano più un riferimento per adolescenti allo sbando ed erano esposti come mai prima d’ora alla morte. Twin Peaks era l’annuncio di un’epoca oscura. Le narrazioni che avevamo sottovalutato, quelle che se perdervi un episodio o due non succedeva nulla, ci avrebbero sfidato, sempre di più. Ci avrebbero chiamato sempre di più alla costruzione di un senso difficile da trovare. Loro, mature, ci avrebbero mantenuto giovani, perennemente alla ricerca di significati nascosti, storditi da un orrore arcano, cosmico. C’è una ragazza morta sulla spiaggia. Chi ha ucciso Laura Palmer? In edicola si poteva trovare il suo “diario”. Il primo esperimento narrativo che viaggiava su diversi media (p. 41).
Twin Peaks ha saputo anticipare quanto sarebbe accaduto dalla fine degli anni Novanta in poi mettendo al centro della scena lo stato adolescenziale con il suo desiderio incontenibile di sentire, che risulterà essere «il principio attivo delle nuove storie sugli schermi» (p. 41). Gli stessi manga e anime si faranno più complessi incentrandosi spesso sulla tragicità dell’adolescenza percepita come condizione insuperabile.
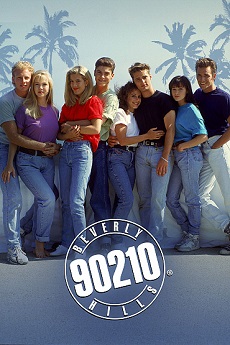 La serie televisiva Beverly Hills 90210 (1990-2000) creata da Aaron Spelling e Darren Star avrebbe messo i giovani di fronte a un universo di coetanei miliardari di cui non avrebbero mai potuto far parte. «L’adolescenza cessava di essere una condizione comune, perché, paradossalmente, ciò che avrebbe accomunato tutti gli adolescenti sarebbe stata l’idea che nessuno ha in comune nulla, e andava bene così. Rivendicazioni di uguaglianza, messa a fuoco dei privilegi di alcune classi sociali: tutto questo non avrebbe avuto alcun senso. Loro erano loro, tu eri tu. E dovevi combattere la tua battaglia con te stesso, paradossalmente, come tutti» (p. 42).
La serie televisiva Beverly Hills 90210 (1990-2000) creata da Aaron Spelling e Darren Star avrebbe messo i giovani di fronte a un universo di coetanei miliardari di cui non avrebbero mai potuto far parte. «L’adolescenza cessava di essere una condizione comune, perché, paradossalmente, ciò che avrebbe accomunato tutti gli adolescenti sarebbe stata l’idea che nessuno ha in comune nulla, e andava bene così. Rivendicazioni di uguaglianza, messa a fuoco dei privilegi di alcune classi sociali: tutto questo non avrebbe avuto alcun senso. Loro erano loro, tu eri tu. E dovevi combattere la tua battaglia con te stesso, paradossalmente, come tutti» (p. 42).
“Essere sé stessi” sarebbe divenuto il nuovo e faticoso imperativo adolescenziale. «Il culto della giovinezza sarebbe stato attraversato sempre da una contraddizione: proprio quelle istituzioni che avrebbero dovuto formare gli adolescenti, come la scuola, sarebbero state abbandonate e rese inutili, perché il loro funzionamento avrebbe prodotto la cosa che avremmo evitato per sempre: l’uscita dallo stato di minorità adolescenziale. La contraddizione, dunque, era solo apparente» (p. 43).
A metà del decennio il romanzo Infinite Jest (1996) di David Foster Wallace, attraverso la sua “trama imprendibile”, avrebbe dato voce torrenziale alla «mente adolescente, che consuma e dipende da quel consumo» (p. 43) e, ricorda ancora Ariemma, il brano Serving the Servant (1993) dei Nirvana, non a caso si apre con il verso “Teenage angst has paid off well” (“Il disagio giovanile ha pagato bene”), mentre in Smell Like Teen Spirit (1991) si fa riferimento a quello «spirito terribile e bifronte dell’adolescenza, che oscilla tra il bruciarsi la vita, perdendosi nell’immediato, nel culto della pura rivolta, e la costruzione di un avvenire […] Un ribellismo contraddittorio che si nutre e a sua volta nutre il sistema che odia e combatte » (pp. 44-45). Il teen spirit, suggerisce Ariemma è «brama del sentire» (p. 45), di un sentire e di un farsi sentire che, però, non ha saputo né potuto sedimentare alcunché, soprattutto se a dare le sensazioni più forti sono gli schermi.
 L’avvento nei primi anni Novanta di videogame “sparatutto in soggettiva” come Wolfenstein 3D (1992) e Doom (1993), prodotti da id Software, hanno consentito allo spirito adolescenziale di sfogare individualmente nichilismo, violenza e aggressività attraverso un’estetica e una cultura del flusso «che non incoraggia, soprattutto gli adolescenti, a pensare a sé stessi come attori in uno scenario sociale o politico più ampio. Ciò che conta è la propria soddisfazione individuale» (p. 47).
L’avvento nei primi anni Novanta di videogame “sparatutto in soggettiva” come Wolfenstein 3D (1992) e Doom (1993), prodotti da id Software, hanno consentito allo spirito adolescenziale di sfogare individualmente nichilismo, violenza e aggressività attraverso un’estetica e una cultura del flusso «che non incoraggia, soprattutto gli adolescenti, a pensare a sé stessi come attori in uno scenario sociale o politico più ampio. Ciò che conta è la propria soddisfazione individuale» (p. 47).
La comunità che veniva […] era caratterizzata dalla pura e semplice appartenenza, dal grado zero della condivisone: ogni nostro essere, ogni nostra maniera sarebbe stata, in qualche modo, comunicabile.
L’invenzione del web – proprio nei primi anni dell’ultima decade, ma alla portata delle masse solo verso la sua fine – non sarebbe stata possibile senza l’emergere di un desiderio di condivisione come forza sconosciuta e della possibilità di amplificare questa forza a dismisura. L’adolescenza avrebbe mostrato il suo lato luminoso, che avrebbe però presto bruciato e sciolto ogni cosa. Al punto che ci avrebbero chiesto di scansarci da quella luce. Gli individui separati avrebbero scoperto il paradosso della relazione, proprio grazie alla nuova tecnologia “social” che catturava l’energia generata dalla negazione della relazione stessa. La scissione degli individui, persino in sé stessi, generava un desiderio di condivisione generico e arcaico, l’anima stessa di ciò che sul web avrebbe preso il nome di community. Una bomba atomica sociale. Le tecnologie di informazione sarebbero diventate così sempre di più tecnologie di relazione e ogni sforzo informatico sarebbe stato fatto con l’unico scopo di farci incontrare e interagire il più possibile.
All’inizio […] ciò che viene messo in relazione e condivisione è figlio del tempo: individui isolati, aggressivi, cinici, spaventati dal mondo, insieme a coloro che erano in cerca di possibilità inedite. Ma le potenzialità a venire erano enormi e avrebbero stravolto i nostri rapporti per sempre (pp. 47-48).
Spetterà alla Rete dare forma al nuovo desiderio comunitario sconvolgendo però l’identità degli individui. E con la Rete l’amicizia si sarebbe trasformata in “contatto” a distanza, in una relazione mediata dalla tecnologia digitale. Con l’avvento dei social si è poi inaugurata una promessa di autenticità diversa da quella promossa da altri ambiti della Rete.
Se un tempo il Web era il luogo della crisi dell’identità, della sua sperimentazione, ove si navigava fingendosi altro e altri, a partire dall’arrivo di Facebook nel 2001, sostiene Ariemma, nasce una generazione di social network che richiede all’utente di esplicitare la propria rete sociale reale.
Gli “amici” su Facebook hanno, in primo luogo, una funzione identificante. Una funzione primitiva, che da sempre ci permette di capire chi siamo (dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei). Tuttavia questa rete, per la prima volta, diventa visibile, dichiarata, documentata. Nessun documento di identità è mai stato così preciso. Le impronte digitali, come pure la nostra carta d’identità ci dicono solo di un’identità astratta, generica. Potenzialmente pericolosa. Da un normale documento di identità non possiamo sapere le amicizie, gli interessi, le circostanze relative a un individuo. Con Facebook le relazioni e le circostanze diventano visibili e mappate (p. 57).
Ben presto dietro alla facciata di affidabilità, sicurezza e autenticità di questa nuova generazione di social network è emerso il cinismo della profilazione, della trasformazione dei dati in valore, evidenziando così come siano nei fatti «dispositivi di appropriazione radicali: invitano gli utenti a mettere del “proprio”, a rendere più appropriato possibile il proprio profilo, solo per estrarre e vendere meglio il tutto» (p. 58).
Nonostante risulti estremamente difficile individuare modalità di sottrazione dal contenimento imposto come normalità, secondo Ariemma, occorre trovare il modo per «fare della propria vita qualcosa di inappropriabile» (p. 58). Ed è con tale convincimento che, dopo aver esaminando la cultura visuale di massa nella sua evoluzione tra gli anni Ottanta e il primo decennio del nuovo millennio, nella seconda pare del volume Ariemma articola una sorta di “proposta farmacologica” per poter reagire al contenimento imperante.



