di Francesco Festa
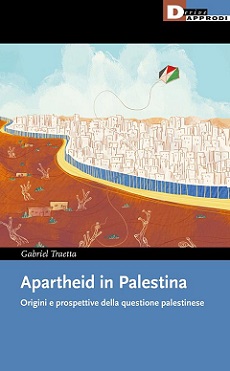 Gabriel Traetta, Apartheid in Palestina. Origini e prospettive della questione palestinese, DeriveApprodi, Roma, 2022, pp. 240, € 20,00
Gabriel Traetta, Apartheid in Palestina. Origini e prospettive della questione palestinese, DeriveApprodi, Roma, 2022, pp. 240, € 20,00
Pochi giorni fa è caduto l’ennesimo anniversario. Il 15 maggio 1948, il giorno drammaticamente noto ai palestinesi con l’appellativo di Al Nakba (“disastro”). Il giorno in cui lo Stato d’Israele si è impossessato delle terre, delle case e delle vite del popolo palestinese. Anche se questo processo prende il via ai principi del Novecento con l’acquisto e l’occupazione delle terre da parte degli ebrei d’ispirazione sionista, Al Nakba è il giorno in cui il popolo palestinese si è trasformato in una nazione di rifugiati: 750 mila palestinesi espulsi dalle loro case e costretti a vivere nei campi profughi; molti di quelli che non sono riusciti a scappare, poi, sono stati uccisi. Più del sessanta per cento della popolazione palestinese è stato espulso. Più di 530 villaggi palestinesi sono stati evacuati e distrutti completamente. Fino a oggi, Israele ha impedito il ritorno di circa sei milioni di rifugiati palestinesi e continua ancora oggi a cercare di espellere i palestinesi dalla loro terra, praticando forme e condotte proprie del colonialismo.
Quanto accade in quella porzione di Medioriente enuclea la quintessenza di tutte le contraddizioni, le ambiguità e le ipocrisie dell’ordine politico ed economico occidentale. Per dirla con una categoria di Mark Fisher racchiude il paradigma del “realismo capitalista” alla realtà palestinese. E per chi ha a cuore la giustizia, la libertà e la solidarietà internazionale, quali valori costituenti della vita sociale, non può ignorare quanto avviene ogni giorno in un piccolo territorio di circa ventiseimila chilometri quadrati, dove vivono un po’ più di cinque milioni di ebrei e circa quattro milioni di palestinesi. Qualora lo facesse, vi sarebbero i palestinesi a riaccenderne l’attenzione: con la loro resistenza dimostrano alle società occidentali cosa possa la dignità umana dinanzi ai soprusi e alla violenza dell’occupazione e dell’apartheid dello Stato di Israele, fra i più militarizzati al mondo. Quel “tozzo” di terra senza nessun confine internazionale a separare le due popolazioni vive in un continuo “stato di eccezione” o di “guerra civile permanente”. In effetti, dove persiste una situazione di colonizzazione – ci ricorda Giorgio Agamben – vi è uno “stato di eccezione”, ossia “un tale stato come un vuoto giuridico, una sospensione del diritto paradossalmente legalizzata”.
Dinanzi a tale ingiustizia dai tratti umani e storici drammaticamente abnormi, il libro di Gabriel Traetta, Apartheid in Palestina. Origini e prospettive della questione palestinese è un lavoro che cerca di mettere le cose a loro posto, di rendere per lo meno giustizia per ciò che concerne la verità storica, utilizzando termini e concetti ormai banditi dal senso comune, poiché sottoposti alla censura del potere israeliano. Questo libro risponde alla sollecitazione di Edward Said, l’intellettuale palestinese che ha dedicato una vita alla causa natia, vale a dire, “dire la verità al potere”. Traetta è un ricercatore indipendente, il che è garanzia – e nel suo caso è accezione davvero precipua – di passione e serietà nelle ricerche. Egli ha ripercorso la questione palestinese incrociando differenti metodi d’indagine, grazie anche al suo lavoro in campo diplomatico e internazionale che gli ha consentito di coltivare un punto di vista privilegiato.
Il libro, con un esaustivo apparato cartografico in appendice, porta a sintesi la letteratura sul tema. Per molti versi si presenta come un compendio degli studi sulla questione palestinese, difatti è all’oggi il lavoro più completo e articolato per chi voglia affrontarne problemi e prospettive. La sua cassetta degli attrezzi contiene l’indagine storica affiancata all’analisi del diritto internazionale, così come lo studio dei documenti diplomatici e delle organizzazioni internazionali trova sostegni nell’analisi del linguaggio ufficiale e di quello giornalistico, con le inevitabili ricadute nel senso comune. E Apartheid in Palestina ha ridonato la giusta interpretazione a termini corrispondenti alle pratiche odiose ed orribili messe in atto dallo stato di Israele e avallate dalla comunità internazionale.
Innanzitutto vi è da sgomberare il campo da alcuni equivoci a causa dei quali il dibattito pubblico viene inquinato alla fonte. Fra tutti quello dell’equiparazione fra antisionismo e antisemitismo, talché Traetta smonta la definizione di antisemitismo elaborata dallo stesso International Holocaust Remembrance Alliance – il più autorevole organismo di collegamento con la memoria ebraica dell’olocausto – e sostiene che
non rimane che cestinare il tutto come un lavoro reazionario, illiberale, antidemocratico, sprovvisto di qualsiasi fondamento giuridico e privo di dignità. La lotta all’odio, alla xenofobia, al razzismo e all’antisemitismo è un tema serio e non può essere strumentalizzato da un movimento politico – per di più storicamente razzista come il sionismo – per difendere le violenze e gli abusi commessi dallo Stato di Israele. Rifiutare il razzismo vuol dire rifiutarlo in toto, incluso il sionismo. Fare diversamente, nella migliore delle ipotesi, vuol dire prendere parte a una farsa. Questo, si badi bene, non significa che non vi possano essere o che non vi siano antisemiti tra le persone che si oppongono al sionismo, ma questi sono presenti anche tra coloro che sostengono il sionismo. Il punto è che è totalmente infondato assimilare in maniera generica l’antisemitismo e l’antisionismo. L’Ihra sembra non conoscere o finge di non conoscere persino quella che dovrebbe essere la sua storia. Le prime posizioni antisioniste, infatti, nacquero in seno alle correnti religiose ebraiche che vedevano nel sionismo un movimento politico colpevole di voler secolarizzare il giudaismo, trasformando così la religione in una nazionalità etnica. L’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto sarà infatti sorpresa nell’apprendere che l’antisionismo è innanzitutto un fenomeno ebraico sviluppatosi originariamente come risposta al sionismo. Sarà altrettanto sorpresa nello scoprire che nel 2020 in tutto il mondo, anche in Israele, vi sono comunità ebraiche, che sulla base delle più svariate argomentazioni – religiose, politiche e morali – si dichiarano antisioniste (pp. 197-198).
Altri concetti indagati da Traetta con quel desiderio di “dire la verità al potere” sono argomentazioni relative alla più ampia categoria del “regime di apartheid” messo in atto dallo Stato di Israele. Vale la pena di riportare direttamente le parole del libro, accludendo qui alcune parti del testo che rendono precipuamente l’organizzazione storica del regime di apartheid.
Tuttavia i governi di Tel Aviv sono andati ben oltre la costituzione di un regime fondato sull’ineguale redistribuzione della ricchezza. Come già è emerso, persino le organizzazioni più rappresentative del sistema di potere contemporaneo, si pensi ad esempio alle documentazioni prodotte dall’Unrwa, l’Unicef o l’Ocha, de- nunciano quotidianamente con forza gli abusi e i crimini commessi da Israele. Da un lato vi è un popolo oppresso, condannato inesorabilmente alla povertà e alla miseria in funzione del progresso altrui, e dall’altro un popolo oppressore che con la sua violenza ha instaurato un regime di occupazione fondato sulla discriminazione razziale. Non è certo un caso che delle sei Commissioni principali dell’Assemblea generale quella che si occupa di investigare le viola- zioni dei diritti umani di Israele ai danni dei palestinesi è la Special Political and Decolonization Committee – Fourth Committee. Sulla scia delle peggiori esperienze coloniali europee, Israele ha prima occupato la Palestina, poi espulso e sterminato una parte della popolazione, e infine immesso una fetta degli indigeni sotto occupazione nel nuovo ordine. Quest’ultimo, secondo il modello coloniale britannico e la formula ideata dalla Società delle nazioni, basa la sua legittimità su una presunta operazione di civilizzazione e progresso. Prima del 1948 l’oppressore – il Regno Unito – si fregiava del titolo di ‘potenza mandataria’ conferito dalla Società delle nazioni; dal 1948 l’oppressore – la comunità ebraico-sionista divenuta Israele – si fregia del nobile titolo di ‘Stato’. Come noto, l’ordine mondiale emerso nel corso del XX secolo, come il diritto internazionale da esso emanato, vede come attori principali dello scenario politico internazionale gli stati-nazione. Non è certo un caso che i popoli colonizzati – le popolazioni sudamericane, mediorientali e africane sono emblematiche a tale proposito – hanno dovuto lottare con tutte le loro forze per liberarsi dall’occupazione straniera e aggiudicarsi il tanto ambito titolo di “Stato”. Tuttavia, la questione non si risolve del tutto grazie a una formula giuridico-lessicale. Alcuni popoli ex-colonizzati, infatti, a distanza di decenni dal processo di indipendenza nazionale devono ancora passare dal grado di “Stato’ a quello di ‘Stato libero e sovrano’. Altri, invece, come quello palestinese, hanno perso – almeno finora – la lotta per la liberazione nazionale e da cento anni sono sotto il giogo delle potenze coloniali. Da oltre un secolo vi sono una presunta legalità nazionale (legalità codificata dalla potenza occupante di turno) e un presunto ordine internazionale (ordine imposto dai paesi egemoni dello scacchiere internazionale) che sanciscono la legittimità de facto delle politiche adottate dalla forza occupante. Dopo aver rubato la terra e le risorse, Israele ha poi generosamente istituito un ordine socio-economico in cui i condannati all’esilio e alla miseria potevano immettersi nel sistema di produzione e di mercato diventando manodopera a bassissimo costo, gli ultimi degli sfruttati. Tale sistema è andato avanti fino alla scelta radicale di sigillare la Striscia di Gaza, isolandola dal mondo, e di istituire regime di apartheid in Cisgiordania. Gli occupanti si arricchiscono e si sviluppano e gli occupati si impoveriscono rafforzando le basi del loro sottosviluppo. E così, proprio come affermato da Darcy Ribeiro in riferimento all’esperienza del colonialismo europeo in Sudamerica: ‘gli indigeni sono il combustibile energetico del sistema produttivo coloniale’. Dinanzi a tale violenza, gli attori principali che animano la cosiddetta comunità internazionale non solo non hanno preso e non prendono le parti degli oppressi ma si spingono – nel nome degli interessi economici delle classi dirigenti al governo – a rovesciare i ruoli e rendere vittima il carnefice e la vittima carnefice. La questione palestinese, se mai ce ne fosse stato bisogno, certifica definitivamente che per la stragrande parte degli stati l’ingiustizia sociale e il rispetto dei diritti umani non incidono minimamente sulle politiche relative alle relazioni internazionali (pp. 187-188).
Il regime di apartheid, giocoforza, deve trovare una ratio su cui far leva per giustificarsi, questa è nell’apparato teorico-politico del sionismo.
David Ben Gurion, uno dei padri del sionismo e fondatore di Israele, oltre ad aver ricoperto la carica di Primo ministro israeliano per primo, cristallizzò in un’affermazione diventata poi storica la volontà di dearabizzare la Palestina e creare uno Stato puramente ebraico: ‘Sono favorevole al trasferimento forzato: non ci vedo nulla di immorale’. Molti anni dopo, nel novembre 1998, sulla stessa scia, il Primo ministro Ariel Sharon fu ancora più esplicito: È dovere dei leader israeliani spiegare all’opinione pubblica, chiaramente e coraggiosamente, un certo numero di fatti che sono stati dimenticati nel tempo. Il primo di questi è che non c’è sionismo, colonizzazione, o Stato Ebraico senza l’espulsione degli arabi e l’espropriazione delle loro terre (p. 211).
Frantz Fanon è un autore citato più volte nel libro perché permette di disvelare le politiche israeliane in regime coloniale e di apartheid, le quali trovano sostegno nel silenzio dei governi occidentali e, al contempo, nel loro rimosso coloniale, ossia in quelle teorie razziste e anti-scientifiche per cui intere popolazioni sono state relegate al rango di “sotto-uomini” mascherando così i reali obiettivi della politica coloniale occidentale. Il colonialismo, in teoria, è stato abolito, ma persiste de facto all’interno delle politiche migratorie così come nella gestione di conflitti internazionali, come se agisse in filigrane sottili eppur spesse che motivano quel “realismo capitalista” occidentale. Mutatis mutandis, avviene nello Stato di Israele – indifferentemente sostenuto da governi europei e statunitensi di qualsiasi colore – malgrado questi violi senza soluzione di continuità tutte le risoluzioni dell’ONU. Fra i tanti citati con attenzione da Traetta, vi è la “risoluzione 242 del 1967” sul ritiro di Israele da tutte le posizioni occupate, che rinvia anche alla risoluzione 194 del 1948 sul ritorno dei profughi; oppure la risoluzione 252, la quale riaffermò il principio espresso nel preambolo della risoluzione 242, in cui si sancisce come tutte le misure legislative e amministrative adottate da Israele, compresa l’espropriazione di terre e proprietà, tese a modificare lo status legale di Gerusalemme siano da considerarsi non valide.
Ma la radice storica di questa diplomazia fallace vi è la guerra arabo-israeliana del 1949, seguita ad Al Nakba. Con gli armistizi separati fra Israele e Egitto, Libano, Giordania e Siria, lo Stato di Israele ha occupato e annesso il 77% del totale della Palestina mandataria, a dispetto del 56% assegnatogli dall’Onu, di cui fa parte anche Gerusalemme ovest. “In contrasto con le disposizioni della risoluzione 181 – osserva Traetta – riguardo alla condizione di corpus separatum della Città santa, nel 1949 la posizione di Israele espressa in seno all’Assemblea generale dal proprio rappresentante diplomatico presso la Commissione politica ad hoc fu la seguente: ‘Il governo di Israele ha sostenuto l’istituzione da parte delle Nazioni Unite di un regime internazionale per Gerusalemme che si occupa esclusivamente del controllo e della protezione dei Luoghi Santi e coopererà con tale regime. Concorderebbe inoltre di porre sotto il controllo internazionale i Luoghi Santi situati all’interno del suo territorio ma al di fuori di Gerusalemme, e ha appoggiato la proposta che bisognerebbe dare delle garanzie per la protezione dei Luoghi Sacri situati in Palestina e garantirne il libero accesso’” (p. 201).
Il sistema coloniale agisce anche su un secondo livello, vale a dire sulla percezione da parte dei colonizzati del sistema stesso. Fanon, che ne ha indagato gli effetti, ha mostrato come i colonizzati tendono a interiorizzare le immagini deridenti e caricaturali che vengono loro imposte: tali immagini, associate alle relazioni oggettive e strutturali, vengono riconosciute come “naturali”. Il colonialismo dei “settlers” agisce attraverso l’eliminazione dell’esistenza delle popolazioni indigene dal territorio. Solo a queste condizioni esso può funzionare. Al colonialismo non interessa lo sfruttamento degli indigeni, ma tende invece a produrre una totalità, sradicando ciò che costituisce la sua negazione, cioè l’esistenza di popoli indigeni, riducendoli a un’entità invisibile, una persona non grata. È per questo che l’impasse israelo-palestinese non dovrebbe essere vista come un evento particolare, ma piuttosto come una struttura che opera per l’eliminazione dei palestinesi autoctoni come entità. Il desiderio di riconoscimento nel colonizzato, che si sviluppa nei termini propri della struttura coloniale globale, può essere visto come una forma di misconoscimento, in quanto rafforza il predominio dell’oppressore. Tuttavia quanto accade nei territori occupati è qualcosa di straordinariamente resistente a qualsiasi forma di oscuramento o misconoscimento. Ed è questa la forza della resistenza palestinese, nonostante l’apartheid, il sionismo e le politiche di annientamento o assoggettamento nei loro confronti. La resistenza palestinese, anziché esaurirsi, rinasce sempre a nuova vita.
Ciò nondimeno la resistenza palestinese convive con la forza israeliana. La soluzione qual è? Riconoscerne l’esistenza. Quella di entrambi, però. La sola intervista rilasciata da Said a un giornale israeliano, l’“Ha’aretz Magazine”, è stata anche la sua ultima in vita e descrive il conflitto fra Israele e Palestina come una “maestosa sinfonia” e mostrandone le vie di fuga.
“Dicevo l’altra sera a Daniel Baremboim – rifletteva a voce alta – Pensa a questa catena di eventi: l’antisemitismo, il bisogno degli ebrei di trovare una patria, l’idea originaria di Herzl, decisamente colonialista, e poi la sua trasformazione nelle idee socialiste del moshav e del kibbutz, la situazione drammatica sotto Hitler e persone come Yizhak Shamir che erano realmente interessate a cooperare con lui, poi il genocidio degli ebrei in Europa e le azioni contro i palestinesi nella Palestina del 1948”. Quando pensi a tutto questo, quando pensi a ebrei e palestinesi non separatamente ma come parti di una stessa sinfonia, c’è qualcosa di incredibilmente maestoso. Una storia molto ricca, anche molto tragica e per molti versi disperata, una storia di estremi – di opposti in senso hegeliano – che ancora deve ottenere il giusto riconoscimento. Quello che hai davanti, quindi, è una sorta di grandezza sublime: una sequenza di tragedie, perdite, sacrifici, dolori che richiederebbero la mente di un Bach per riuscire a ricomporla.



