di Gioacchino Toni
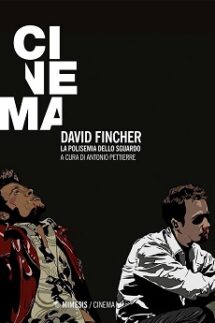 Il regista statunitense David Fincher ha ottenuto fama interazionale grazie ad opere cinematografiche e serie televisive di indubbio successo: Alien³ (1992); Seven (1995); The Game – Nessuna regola (The Game) (1997); Fight Club (1999); Panic Room (2002); Zodiac (2007); Il curioso caso di Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button) (2008); The Social Network (2010); Millennium – Uomini che odiano le donne (The Girl with the Dragon Tattoo) (2011); L’amore bugiardo – Gone Girl (Gone Girl) (2014); Mank (2020); House of Cards – Gli intrighi del potere (House of Cards) – serie TV (2013); Mindhunter – serie TV (2017-2019).
Il regista statunitense David Fincher ha ottenuto fama interazionale grazie ad opere cinematografiche e serie televisive di indubbio successo: Alien³ (1992); Seven (1995); The Game – Nessuna regola (The Game) (1997); Fight Club (1999); Panic Room (2002); Zodiac (2007); Il curioso caso di Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button) (2008); The Social Network (2010); Millennium – Uomini che odiano le donne (The Girl with the Dragon Tattoo) (2011); L’amore bugiardo – Gone Girl (Gone Girl) (2014); Mank (2020); House of Cards – Gli intrighi del potere (House of Cards) – serie TV (2013); Mindhunter – serie TV (2017-2019).
Essendo ravvisabili in queste opere – pur di “qualità variabile” – elementi di continuità sia linguistico-espressiva che di generale visione della realtà, viene spontaneo parlare di “produzione autoriale”. Occorre però domandarsi, suggerisce Antonio Pettierre, curatore del volume David Fincher. La polisemia dello sguardo (Mimesis, 2021), come si possa definire un “autore” nel cinema contemporaneo. «Ha ancora senso in quest’epoca storica dove l’elemento industriale ha un impatto determinante per la riuscita, distribuzione e conseguente visibilità di un film?». Di certo le opere di Fincher «mostrano una pluralità di segni, significati e strategie di significazione, sia nei contenuti espressi sia negli elementi simbolici ricorrenti, determinando un mondo autoriale identificabile e riconoscibile».
La frequentazione adolescenziale delle sale cinematografiche di Fincher coincide con l’esplosione del fenomeno New Hollywood e la fascinazione per tale produzione lo porta, non appena conseguito il diploma, a gettarsi a capofitto nel mondo del cinema senza passare dai corsi accademici. Dopo quattro anni trascorsi presso la Industrial Light & Magic, la “fabbrica degli effetti speciali” di George Lucas, decide di passare alla macchina da presa, inizialmente in ambito pubblicitario.
Se a prima vista l’opera di Fincher può sembrare focalizzata esclusivamente su un punto di vista maschile, in realtà, sostiene Pettierre, le cose sono più complesse. Innanzitutto si tratta di figure maschili dotate di caratteristiche psicologiche particolari: «l’irrequietezza, l’ossessione, la sconfitta personale nella ricerca di un effimero successo, la solitudine. Uomini che più che odiare le donne si confrontano con loro in una posizione spesso di debolezza data dal loro malessere interiore».
A proposito delle figure femminili dei suoi film, occorre dire che anche quando rivestono ruoli apparentemente secondari, risultano determinanti nello sviluppo narrativo. Esse, sostiene Pettierre, si rivelano «non solo come controparti maschili, ma soprattutto come soggetti totalmente supplenti, o controcorrente e attive, oppure come elementi iconici che riportano alla realtà, da un lato, o la disgregano, dall’altro».
 Il tenente Ripley e Meg Altman, ad esempio, si trovano a doversi arrangiare nel confrontarsi rispettivamente con il mondo maschile di Alien³ e con i dei malviventi in Panic Room. «Se nel primo caso la protagonista si sacrifica per fermare l’orrore interiore, nel secondo deve tornare a uno stato selvaggio per proteggersi e salvare la prole da un terrore esteriore».
Il tenente Ripley e Meg Altman, ad esempio, si trovano a doversi arrangiare nel confrontarsi rispettivamente con il mondo maschile di Alien³ e con i dei malviventi in Panic Room. «Se nel primo caso la protagonista si sacrifica per fermare l’orrore interiore, nel secondo deve tornare a uno stato selvaggio per proteggersi e salvare la prole da un terrore esteriore».
Per certi versi tanto le figure femminili quanto quelle maschili proposte da Fincher possono essere disturbanti e disturbati a riprova di come i suoi personaggi tendano ad incarnare l’individuo al di là del genere: «i personaggi femminili e maschili sono alla fine intercambiabili e intercomunicanti, agiscono sia come soggetti attivi sia come oggetti passivi in una realtà deformata e deformante. E il tema che riveste il cinema fincheriano, esplicito o sottotraccia, resta sempre guidato dai peccati capitali alla base del male di essere, di esistere, di vivere».
In Fight Club Marla Singer ha il duplice ruolo destabilizzante e riconciliante nei confronti del Narratore, Lisbeth Salander subisce continue violenze in Millennium e ciò ha finito per tramutarla «in un individuo solitario, silenzioso, che vive e padroneggia il dark web [, in] una guerriera, un’indiana metropolitana che segue le tracce per catturare le prede (o liberarle)». La stessa Amy, in Gone Girl, è alle prese con un confronto-scontro di genere con il marito. Si tratta di donne forti e determinate nel combattere per loro affermazione. Anche le figure femminili secondarie esprimono in realtà un ruolo determinante. «Nel mondo in disgregazione, dove il falso, il caos e l’instabilità psicofisica sono una costante, la donna diventa una guida, un punto di riferimento, la vera bussola da seguire».
Per quanto riguarda il male, per Fincher questo può nascere ove non ci se lo aspetta, rilevarsi capace di infiltrarsi ovunque e di esprimersi nelle forme più inattese.
La visione di Fincher è quella di un pessimismo senza possibilità di redenzione, in cui il male si esprime attraverso le azioni dei protagonisti. Non è un caso se la figura del serial killer è presente in tre pellicole: John Doe, demiurgo che appare solo nel finale di Seven; la presenza in absentia di Zodiac nell’omonimo film, convitato di pietra che si rende visibile negli omicidi messi in scena, nelle lettere spedite al giornale e nei pensieri ossessivi di Graysmith; e Martin Vanger di Millennium – Uomini che odiano le donne, presente dall’inizio, visibile e allo stesso tempo sconosciuto fino al climax finale.
Se in Alien³ il male ha le fattezze dell’alieno che Ripley porta in grembo, in Seven invece si trova all’interno della società ed il serial killer di turno, con la sua messa in scena dei sette peccati capitali, non fa che palesare ciò che l’umanità persegue nella quotidianità. Il male si manifesta anche come branco, come nel caso del gruppo di assassini e stupratori della colonia penale di Alien³ o in quello del trio di criminali in Panic Room. Lo ritroviamo, inoltre, sotto forma di «società consumistica dove tutto è merce in Fight Club oppure nel capitalismo cinico dell’industria del cinema in Mank», così come nei rapporti di coppia di Gone Girl.
Altro elemento ricorrente nelle opere è l’assenza del padre che può palesarsi nel non essere contemplato, come in Alien³, Fight Club, The Social Network, Millennium, o nella sua «presenza negativa o liminare», come in Seven. Oppure, ancora,
in Panic Room Stephen Altman è padre presente solo finanziariamente […] per poi apparire nel finale per essere oggetto di una punizione fisica brutale, una traslazione dell’odio della moglie attraverso le azioni dei rapinatori; o Thomas Button che abbandona il figlio Benjamin sulla soglia di una casa di riposo; o lo stesso Graysmith, che ossessionato dalla ricerca di Zodiac, diventa sempre più distante dai propri figli fino ad abbandonare la famiglia per la sua follia; o i genitori di Amy, moglie di Nick Dunne, in L’amore bugiardo – Gone Girl, figure di fondo per una figlia che non comprendono appieno e a cui interessa solo l’apparenza sociale.
È però in The Game e Mank che, sottolinea Pettierre, tutto diviene più esplicito: il primo è incentrato sul dolore per la mancanza di amore paterno di un ricco, solitario e malinconico personaggio in preda al tormentato ricordo del padre austero e assente suicidatosi davanti a lui quando era bambino, mentre il secondo film rappresenta una sorta di omaggio metacinematografico al padre del regista, «autore della sceneggiatura, assente nella narrazione ma presente nella sua struttura come un fantasma».
Anche le scelte spaziali del regista meritano di essere indagate. L’opera di Fincher è formata da spazi essenzialmente chiusi e oppressivi; si tratta di un cinema di luoghi metropolitani ricostruiti e labirintici in cui i personaggi si muovono difendendosi dal caos esterno che però non manca di infiltrarsi ed invadere l’interno.
La metropoli diviene una sorta di astrazione che propone allo spettatore la visione di un mondo ostile, uno spazio che rivela come tutto sia per certi versi mera finzione. «Ciò che è visibile è solo una minima porzione della realtà, di una società metropolitana che è una prigione non solo dei corpi ma anche di anime […] Lo spazio urbano diventa così la metafora principale delle tenebre che avvolgono i protagonisti del cinema del regista americano».
 La produzione fincheriana risente, oltre che della biografia personale, delle evoluzioni tecnologiche che, soprattutto alla luce delle possibilità offerte dal digitale, permettono al regista di operare «ripetute osmosi tra pubblicità, videoclip, televisione e sala cinematografica». Fincher «utilizza il digitale come un filtro, uno strumento di perfezionamento della realtà registrata con la macchina da presa tradizionale».
La produzione fincheriana risente, oltre che della biografia personale, delle evoluzioni tecnologiche che, soprattutto alla luce delle possibilità offerte dal digitale, permettono al regista di operare «ripetute osmosi tra pubblicità, videoclip, televisione e sala cinematografica». Fincher «utilizza il digitale come un filtro, uno strumento di perfezionamento della realtà registrata con la macchina da presa tradizionale».
Sempre restando sullo spazio scenico possiamo citare l’impiego del digitale per riprodurre nei minimi dettagli la San Francisco degli anni ’60 in Zodiac, compiendo un lavoro filologico da una parte, ma dall’altra riportando in vita i ricordi di Fincher bambino per rendere visibile allo spettatore quel periodo da lui vissuto in prima persona. In questo senso, Fincher effettua un intervento di rifrazione dello sguardo in un modo tale per cui la messa in crisi della sua egemonia rispetto agli altri sensi, ci porta a una cartografia aggiornata in cui aspetti culturali e sociali si incontrano per dare forma a un’immagine composita, un’immagine che sa restituire la complessità della nostra attuale composizione. […] Fincher compie, dunque, un’ibridazione della realtà attraverso l’imposizione del suo sguardo dove “tutto è reversibile e manipolabile, modellando un rapporto allo stesso tempo fondato sulla semplicità degli eventi e la loro disseminazione reticolare” all’interno del corpo filmico di cui lui ha un completo controllo. […] In Fincher l’immagine cinematografica riproduce una realtà adattata e mutata dal suo sguardo.
Se il digitale permette al regista di modificare la realtà in base ai suoi desideri, la fotografia
diventa non solo un elemento profilmico all’interno dello spazio scenico, ma un elemento estetico-simbolico che, da un lato, produce indizi e senso interno – per i personaggi – ed esterno – per il pubblico, in una mise en abyme visuale; dall’altro, riproduce un mondo passato e personale, quasi referenziale per il regista stesso, il cui significato più profondo è “stabilire con il mondo una relazione particolare che dà una sensazione di conoscenza, e quindi di potere”. […] Fincher, in questo modo, si (ri)appropria della realtà da dietro la macchina da presa, la falsifica, la plasma, la modifica. […] L’immagine, dunque, diventa il campo su cui testare le potenzialità espressive di rappresentazione del mondo, delle sue angosce, dell’orrore quotidiano.
Il volume curato da Antonio Pettierre contiene numerosi saggi che approfondiscono qualche aspetto di un un’opera di Fincher. Su alcuni di questi scritti occorrerà tornare prossimamente, nel frattempo vale la pena almeno elencarli: “Nouvelle vogue”: la origin story di David Fincher di Matteo Zucchi; “Into the basement”: l’abietto del/nel cinema di David Fincher, o dell’inevitabilità di Alien³ di Matteo Zucchi; Seven. Rappresentazione di una società corrosa dal male di Marcello Perucca; La posta in gioco. The Game – Nessuna regola di Filippo Zoratti; Fight Club ovvero psicopatologia del consumatore (im)permanente di Antonio Pettierre; Panic Room: la crisi dell’abitare nell’America di inizio millennio di Eugenio Radin; Sotto il segno di Zodiac. Semiotica di un serial thriller di Rudi Capra; Tradimenti e promesse mancate ne Il curioso caso di Benjamin Button: confronti tra letteratura e cinema di Rita Ricucci; Gli spazi virtuali della società di massa: messa in scena di una nuova rivoluzione antropologica in The Social Network di Antonio Pettierre; Millennium – Uomini che odiano le donne. Falso remake che indaga il lato oscuro della società scandinava di Marcello Perucca; L’amore bugiardo – Gone Girl. Vittime e carnefici nel rapporto di coppia di Marcello Perucca; Il curioso caso di David Fincher e Netflix di Giuseppe Gangi; The touch of Welles: Mank, tra metatestualità e falsificazione di Giuseppe Gangi.



