di Franco Pezzini
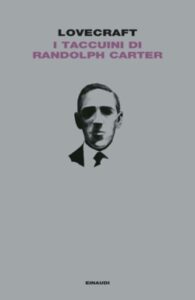 Howard Phillips Lovecraft, I taccuini di Randolph Carter, a cura di Marco Peano, trad. di Mario Capello, euro 19, pp. XVIII-254, Einaudi, Torino 2021.
Howard Phillips Lovecraft, I taccuini di Randolph Carter, a cura di Marco Peano, trad. di Mario Capello, euro 19, pp. XVIII-254, Einaudi, Torino 2021.
D’accordo, la prima domanda può essere: serviva davvero, una nuova traduzione di questi testi? La raccolta presenta l’intera saga dell’onironauta di Lovecraft, cioè i suoi racconti La testimonianza di Randolph Carter, L’indicibile, La chiave d’argento, il romanzo La cerca onirica di Kadath l’ignota, e un racconto a quattro mani, Al di là del portale della chiave d’argento scritta assieme a Edgar Hoffmann Price – tutti testi nel complesso famosi. Al netto però di qualunque considerazione sull’utilità sociale della traduzione di un classico (come tale in sé noto, ma merita sempre d’essere riproposto) e sulla politica editoriale di voler avere in catalogo una propria versione, mi pare che la risposta debba essere positiva. Intanto il volume è molto bello, elegante come appunto ci si attende per un classico; la traduzione, buona e godibile, è condotta sull’edizione a cura dell’espertissimo Joshi, The complete fiction di Barnes & Noble 2011 (e non sulle precedenti, criticate per refusi e imprecisioni); a volgere i racconti in italiano è un bravo traduttore estraneo al sottomondo fandom, che giustamente li ha trattati come classici della letteratura anglosassone; e a curare il tutto è un competente curatore come Marco Peano, già studioso attento dell’epistolario, e che qui corona l’insieme con una bella Prefazione. Alcune soluzioni del traduttore faranno storcere un po’ il naso a quanti si erano abituati a rese consolidate – i “tuttossa della notte” al posto dei magri notturni –, ma da un lato quelle non costituivano verità rivelata, e dall’altro si tratta in fondo del voler tornare alla sorpresa di un testo con gli occhi di una nuova generazione. In sostanza, lasciamo le lamentazioni a consumarsi, e godiamoci questa bella edizione.
Su Lovecraft, e anche su questi racconti, le piste di ricerca fertili sarebbero ancora davvero tante: a partire dal suo rapporto con le fonti. Dove, per favore, evitiamo di considerare tutta una serie di autori eccellenti come meri ispiratori e altri come puri epigoni: Lovecraft è stato grandissimo, ma sarebbe il primo a trovare insensato tale riduzionismo grottesco e provinciale di maestri come Machen, Bierce o lo stesso immenso Poe (per citare solo qualche patriarca). Dividere tout court la storia del fantastico in prima e dopo Lovecraft, come se lui dovesse essere il centro focale di tutto, atteso quasi messianicamente, significa brandire un’impostazione critica un po’ imbarazzante, da tifo tra squadre di paese: non lo si fa (giustamente) per il resto della letteratura, ha davvero senso proporre una partizione “a podio” nella letteratura fantastica?
Tanto più che, ad analizzare con attenzione i testi, scopriamo i fili che corrono da un’opera all’altra, da un autore all’altro, e rendono HPL parte vitale di un lungo cammino che certo non si esaurisce in lui. Kadath l’ignota è per esempio solo una tappa avanzata, ciclopica di quella serie di arcicastelli – d’Otranto, di Udolpho, Metzengerstein, Casa Usher eccetera, fino al Castello Dracula, a quello di Kafka e ad altri – il cui statuto incerto di luoghi fisici e insieme del sogno si relaziona agli orizzonti e paradigmi delle rispettive epoche. Il tema dell’identità plurima come cifra paradossale di orrore si colloca in un’epopea del fantastico come letteratura di crisi dell’identità esplorata fin dal Settecento, emblematica dell’Ottocento ed esondante nello stesso mainstream del Secolo breve. Il rapporto tra gruppi di dèi, qui continuamente richiamato non tanto a fornire coordinate fantateologiche quanto spunti poetici, sembra richiamarsi alle dinamiche di testi come la lirica Il Verme Conquistatore di Poe, con la messinscena di “Mimi fatti a sembianza di Dio in alto / [che] borbottano e brontolan piano” e volteggiano, “vani fantocci […] al comando di vasti esseri informi [“vast formless things”, nella prima versione “vast shadowy things”], / che spostano lo scenario qua e là” eccetera. Come non è Lovecraft a inventare gli pseudobiblia o le città simbolo d’inconcepibile alterità, pur giocando sull’uno e sull’altro topos con straordinaria bravura.
Ancora: Lovecraft, che non è certo un maestro sul piano ideologico come qualcuno pretenderebbe a fini strumentali, è invece un buon maestro di scrittura – alla faccia di quanti ne hanno demolito lo stile (penso a certe frecciate del pur bravo Colin Wilson, che lì però cade malamente), spesso sulla base di edizioni inaffidabili o magari di confusioni con il vorrei-ma-non-posso epigono Derleth. Il primo dei testi qui antologizzati, La testimonianza di Randolph Carter, trasformazione in novella – com’è noto – del resoconto di un autentico sogno dell’autore, mostra come il materiale onirico possa felicemente fornire il tessuto completo (e non solo uno spunto ispiratore di singole scene, come per Walpole, Mary Shelley, forse Stoker) a un testo narrativo suscettibile a quel punto di criteri di giudizio diversi, non asfitticamente psicologistici ma letterari. L’indicibile, forse meno forte sul piano della narrazione, si configura però come una vera e propria lezione teorica di scrittura e riflessione critica sull’uso del non-detto in chiave enfatica e perturbante, contro le critiche e i sofismi di alcuni lettori. La chiave d’argento, con le sue dimensioni liricamente nostalgiche, colloca la filosofia di vita di Lovecraft/Carter all’interno di una crisi consumata verso una serie di valori del mondo americano del tempo, nel cui contesto intellettuale il racconto va anzitutto valutato. Come per Poe, anche se in modo diverso per il mutare dell’America e il differente profilo soggettivo, il pensiero di Lovecraft va rapportato a un orizzonte di giornali, pubblicazioni amatoriali e non, scoperte e nuove ipotesi scientifiche, conferenze, dibattiti e polemiche – da lui seguiti magari a distanza, o anche al filtro dei sui contatti. Avvicinarlo a figure della piazza europea (magari sull’onda di pretese vicinanze alla “Tradizione”, e di sporadiche sue letture) risulta una forzatura: togliere Lovecraft dal suo mondo significa fraintenderlo completamente. La chiave d’argento, scritto nel 1926 – nel corso di quegli anni ruggenti che a lui interessano in fondo poco – verrà pubblicato all’inizio del 1929: di lì a qualche mese si scateneranno forze mostruose, gli Altri Dèi di una finanza che inabissa gli Stati Uniti come una fantastica R’lyeh, aprendo le porte alla follia (povertà, suicidi, disoccupazione, deflagrazione sociale) e ai mostri (però quelli gotici, il cui cinema eromperà proprio su quell’onda, irrorato dalle fantasie dei transfughi dell’espressionismo tedesco). Il cosmo/caos di Lovecraft incombe dall’alto sulle teste dei lettori ma in robusta parte anche nel profondo delle loro interiorità: quando Fruttero e Lucentini inseriranno vari racconti del Nostro nel bellissimo Storie di fantasmi (Einaudi, 1960) suggeriranno in fondo questo.
La cerca onirica di Kadath l’ignota, con il godibilissimo affresco di un’odissea negli Spazi Ulteriori, delinea a sua volta un tipo di fantasy che purtroppo non trova sufficienti estimatori da poter costituire un modello diffuso (mentre pensiamo al brulicare, anche in Italia, di autori fermi a elfi, orchi e talismani – come se dopo Tolkien avesse ancora senso). Certo, il romanzo brulica di ispirazioni a classici precedenti (il Nyarlathotep in scena viene direttamente dall’Eblis del Vathek, i riferimenti ai fuochi di figure faunesche da Pomponio Mela tramite Poe, eccetera), ma giocati in modo così festosamente originale e brioso da non esaurirsi mai nel puro citazionismo. Lì HPL capitalizza la narrativa d’avventure esotiche antiche e vittoriane, le letture delle Mille e una notte e i relativi controcanti europei settecenteschi, e le stesse suggestioni fantarcheologiche rimbalzanti in una certa pubblicistica d’epoca (i continenti perduti di Ignatius L. Donnelly, i Maya di Augustus Le Plongeon, eccetera). Non stupisce per esempio che in Al di là del portale della chiave d’argento emerga il richiamo al colonnello Churchward, “scopritore” del continente perduto di Mu… In effetti quest’ultimo testo è il più problematico della raccolta, perché abbina al timone il materialista Lovecraft e un interessato all’esoterismo come Price: ciò che potrebbe permettere di ravvisare nel nesso tra l’eroe Carter e l’occultista creolo Etienne-Laurent de Marigny, il “più grande mistico, matematico e orientalista del continente”, qualche confusa memoria del mago mulatto Paschal Beverly Randolph, figura emblematica di occultista tra l’America e l’Oriente.
Possiamo restare perplessi scoprendo come venga qui considerato il massimo di orrore e straniamento lo scoprirsi del protagonista come identitariamente presente in realtà diverse del cosmo: forse oggi siamo più abituati all’ipotesi degli universi paralleli, o all’idea che “percentuali” di noi si trovino in giro variamente sparigliate nella realtà (anzi Carter, come scrittore, dovrebbe non considerarla una prospettiva così nuova). Ma non stupiamoci, è cambiato il mondo e il titano Lovecraft è solo una tappa nel lungo cammino della storia del fantastico: inventa o spesso recupera e valorizza topoi, ci gioca con bravura (pienamente) letteraria e con il suo corpus di racconti edifica i pilastri di un’intera mitologia, che d’altra parte poggiano la base nel piccolo orbe della sua Nuova Inghilterra.
Tutto ciò non a ridurre o banalizzare l’importanza di Lovecraft, tutt’altro: ma a contestualizzare un po’ la naïveté di un certo tipo di devozione fiorente su internet e in millanta eventi sul fantastico, un (Carducci permetterà) lovecraftismo degli stentatelli votato al culto compulsivo di lui a botte di interventi sussiegosi, analisi letterarie migliorabili – non mancano studiosi seri, ma certo in percentuale ridotta rispetto a fiumane di autoproclamati esperti –, riferimenti a opere critiche datate e discutibili, mentori da non inimicarsi, affermazioni storiche banalizzanti (“normale che fosse razzista, tutti allora lo erano”). E imitazioni non esaltanti, in chiave di fanfiction: mentre, osservava giustamente il critico Davide Mana, i discepoli migliori di HPL non sono quelli che lo scimmiottano o pretendono di continuarlo, ma quelli che lo tradiscono, si ispirano a lui per reimmaginare completamente il quadro, mostrano di averne appreso la lezione e la valorizzano per analogia.
Che HPL sia anche un effervescente fenomeno pop non stupisce e non c’è nulla di male, c’è spazio per tutti – anche se non è detto che ogni entusiasta abbia tout court qualcosa di sensato da proclamare. Ottimi i carotaggi monotematici, ma vanno raccordati a un orizzonte culturale ampio e insieme puntuale, senza scorciatoie esoteriche dove non congrue (anche se permettono di fare sfoggio d’erudizione in taluni ambienti) e con un’attenzione comunque al mondo concreto su cui Lovecraft teneva i piedi, pur vagheggiando cosmi lontani. Quella è la Nuova Inghilterra delle Città del tramonto, in fondo: e una meta può essere il tipo d’approccio, esemplare per rigore e quantità di dati offerti, con cui brilla per esempio la Edgar Allan Poe Society di Baltimora votata al suo grande predecessore. Qualcosa che su Lovecraft in parte c’è, ma soprattutto nella critica anglosassone, mentre da noi – basta farsi un giro sul web – a grandi numeri prevale l’ossessione antimodernista, in loop come un uroboro. Davvero meritevole invece l’uscita, in tre volumi in Italia per un piccolo editore, dell’opera dell’espertissimo S.T. Joshi, Io sono Providence. La vita e i tempi di H.P. Lovecraft (Providence Press, 2020-21), col pregio di aprire finalmente le finestre e far entrare un po’ di aria fresca nel mondo delle letture lovecraftiane nostrane, grazie al rigore asciutto degli studi anglosassoni.
Dissodare i testi, analizzarne il linguaggio, individuare i precedenti filologici, linguistici o tematici, che non costituiscono mai dati aridi ma rimandano a letture concrete e sogni… Se vogliamo davvero onorare Lovecraft, anche nell’Italietta intignata nei livori verso i grandi editori e la critica “alta”, cominciamo insomma a trattarlo da classico qual è, apriamo alla realtà storica del suo mondo e delle sue letture (non quelle che avrebbe potuto condurre, sulla base della bibliotechina personale dell’autoeletto esegeta), e allo specifico letterario dove ha dato il suo meglio. Se poi con Schopenhauer possiamo giustamente elogiare i dilettanti, che hanno mostrato di apprezzare Lovecraft anche quando una critica accademica ancora non lo capiva, non possiamo dimenticare che anche nello studio della letteratura, anche non essendo accademici, occorre dedicare ai soggetti un rigore – anzitutto nell’approccio, se non proprio nelle forme – che a quello dell’accademia si avvicini. Bene la buona divulgazione, specie se poi permetta qualche guizzo minimamente originale nell’impostazione, ma anche quella richiede rigore. Bene lo sforzarsi di cogliere la novità di Lovecraft, non in grazia di un ipse dixit reazionario, ma per la gioia continua di una possibile riscoperta, che è uno degli aspetti caratterizzanti i classici. Necessario dunque saper anche uscire dal portale serrato del fandom, con relative grandezze (che pur ci sono) e limiti.
L’edizione in questione, pur non avendo pretese di edizione critica, fa in fondo proprio questo, trattare seriamente Lovecraft come un classico angloamericano in quanto tale (non solo “del fantastico”). E su un autore grandissimo tanto maltrattato da critica ostile e devozioni asfittiche, pare un riconoscimento importante.



