di Marcella Farioli
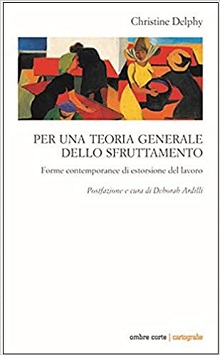 Christine Delphy, Per una teoria generale dello sfruttamento. Forme contemporanee di estorsione del lavoro (traduzione e postfazione a cura di Deborah Ardilli), Ombre Corte, Verona 2020, pp. 155, € 13 (tr. di Pour une théorie générale de l’exploitation, Syllepse, Paris 2015).
Christine Delphy, Per una teoria generale dello sfruttamento. Forme contemporanee di estorsione del lavoro (traduzione e postfazione a cura di Deborah Ardilli), Ombre Corte, Verona 2020, pp. 155, € 13 (tr. di Pour une théorie générale de l’exploitation, Syllepse, Paris 2015).
Va considerata un evento la prima traduzione integrale in italiano di un’opera della sociologa Christine Delphy, una delle più originali pensatrici del femminismo francese, protagonista del Mouvement de libération des femmes e nel 1977 fondatrice, insieme a Nicole-Claude Mathieu, della rivista “Questions féministes”; un evento poiché Delphy, ampiamente tradotta nei paesi anglosassoni, è stata finora oggetto, in Italia, di una vera e propria rimozione.
Questa cancellazione non stupisce. Da un lato, il femminismo francese fin dagli anni ’80 è stato identificato tout court col pensiero della differenza sessuale, con il gruppo Psychanalyse et politique e con feudi accademici ben difesi da intellettuali come Cixous e Kristeva; questa cristallizzazione – validata anche dalle femministe anglo-americane – di un «French Feminism» privo della sua costola materialista, si è poi perpetuata sia nell’accademia sia nei settori militanti per un meccanismo spontaneo di riproduzione dell’identico. D’altro canto, come osserva Deborah Ardilli, autrice della postfazione del volume, questa cancellazione del femminismo materialista, che ne ha decretato l’assenza dall’editoria italiana, ha anche altre e più profonde ragioni: «più che di marginalizzazione, termine che potrebbe erroneamente indurre a pensare all’esito di un processo di selezione naturale sul mercato delle idee, meglio sarebbe parlare di resistenza attiva al paradigma materialista e, a cascata, alla possibilità di riconoscergli un’elasticità sufficiente a farlo migrare verso ambiti diversi da quello per cui era stato originariamente concepito da Marx » (p. 107).
Come vedremo, infatti, quella che Ardilli ha felicemente definito «l’eresia materialista di Christine Delphy» prevede l’applicazione all’asse del sesso di alcuni strumenti analitici marxiani nati per analizzare il conflitto capitale/lavoro. La sua opera, come e ancor più di quella di Colette Guillaumin e di Nicole-Claude Mathieu, ha così incontrato una duplice ostilità: quella del femminismo marxista, che osteggia il riuso critico delle categorie marxiane e quella del pensiero della differenza sessuale, che rifiuta la visione materialistica della storia e preferisce ancorare nel simbolico la spiegazione dei fatti sociali. La tendenza postmodernista a rifiutare le spiegazioni generali della realtà e a frantumare i rapporti sociali in una miriade di individualità eterogenee, lo slittamento del discorso relativo al genere dal piano delle strutture materiali a quello dell’immaginario e delle rivendicazioni identitarie, e infine, ad un diverso livello, l’avanzata inarrestabile del pensiero neo-liberale, accompagnato dalla sua ideologica astrazione degli antagonismi dalle cause materiali che li producono, sono tutti ostacoli che hanno frenato la ricezione italiana di Delphy.
L’irresistibile anelito a obliterare tutto ciò che nel femminismo odora di marxismo si è del resto manifestato in Italia anche sul piano storiografico nei confronti di Lotta Femminista, l’unica delle formazioni politiche femministe della seconda ondata attive nel nostro paese a mutuare i propri strumenti di analisi politica dal pensiero marxiano, applicati allo sfruttamento del cosiddetto lavoro di riproduzione. Analogamente, anche il femminismo materialista francese è stato fino ad ora espunto dal mainstream femminista italiano.
Eppure gli apporti teorici di Delphy già dagli anni Settanta si caratterizzano come una vera rivoluzione epistemologica in seno alla teoria femminista. I due contributi principali della sociologa risiedono nella decostruzione e denaturalizzazione del binarismo sessuale e nella teorizzazione del modo di produzione domestico. Le due questioni sono intimamente connesse, poiché l’eterosessualità obbligatoria, che sta alla base della divisione sessuale del lavoro, è uno strumento essenziale per il disciplinamento delle donne; ma è nello specifico la seconda questione che Delphy affronta nel volume Per una teoria generale dello sfruttamento, che rappresenta una sistematizzazione, una base per una teoria generale delle forme contemporanee di estorsione del lavoro e più in particolare dello sfruttamento del lavoro gratuito delle donne.
Nella prima parte del saggio (Da che parte attaccare la “divisione ineguale” del “lavoro familiare”), Delphy smantella con rigore argomentativo la tesi di una tendenza del femminismo marxista, secondo cui il lavoro domestico gratuito delle donne avvantaggia il capitalismo perché permette al padronato di pagare meno i lavoratori, risparmiando sui costi del mantenimento e della riproduzione della forza-lavoro. Questo modello, basato astrattamente sull’idea che i lavoratori siano tutti maschi e sposati, non regge alla prova dei fatti: poiché le donne lavoratrici non hanno una moglie, chi riproduce la loro forza-lavoro? Perché né queste ultime né i lavoratori celibi sono sovra-retribuiti per “compensare” l’assenza di una moglie che svolga lavoro gratuito per loro?
Delphy teorizza invece l’esistenza, accanto al modo di produzione capitalista, di un secondo modo di produzione, analiticamente distinto: quello domestico (o patriarcale), che opera al di fuori del meccanismo del plusvalore e che si basa sull’estorsione diretta del lavoro domestico delle donne da parte degli uomini, eufemisticamente dipinta (e, in definitiva, fraintesa) dal linguaggio corrente come “divisione ineguale dei compiti”. Con la nozione di «travail domestique» Delphy non designa solo il lavoro familiare destinato al consumo domestico («travail ménager»), ma anche il lavoro svolto gratuitamente dalle donne nelle attività economiche del marito che entrano nel sistema dello scambio. Mentre il modo di produzione capitalista avvantaggia i capitalisti, il modo di produzione domestico va a beneficio degli uomini; i due sistemi sono tuttavia imbricati, tra loro e con altri rapporti sociali, ad esempio quello di “razza”.
Per definire lo sfruttamento originato dal modo di produzione domestico, che si realizza in assenza di salario e fuori dal mercato, Delphy utilizza la categoria di “appropriazione” (coniata da Colette Guillaumin), che viene esercitata individualmente e collettivamente da parte della classe degli uomini sulla classe delle donne, in particolare nella famiglia come luogo specifico di sfruttamento. Il concetto di classe viene così applicato da Delphy ai gruppi sociali delle donne e degli uomini per designare la classificazione dicotomica dei sessi e la loro simultanea gerarchizzazione: nell’ambito del modo di produzione domestico «gli uomini, in quanto gruppo, estorcono tempo, denaro e lavoro alle donne attraverso una serie di meccanismi, ed è in questa misura che costituiscono una classe» (p. 51).
Lo sforzo teorico della sociologa – è bene ricordarlo – è lontano da un mero virtuosismo analitico, ma si salda incessantemente alla cogenza di iscrivere la teoria nel concreto e di tradurla in prassi politica nell’ottica di una trasformazione dell’esistente. È in questa prospettiva che Delphy analizza il ruolo di alcuni apparati e istituzioni che cooperano al mantenimento dell’assetto gerarchico del genere: lo Stato, il mercato del lavoro, il matrimonio, l’eterosessualità obbligatoria e si interroga sulle possibilità fattuali di combattere la ripartizione ineguale dei compiti.
Nella seconda parte del saggio (Per una teoria generale dello sfruttamento) Delphy evidenzia i limiti della teoria del plusvalore che, nata per descrivere lo sfruttamento capitalista, finisce per escludere dalla nozione di sfruttamento tutti quei rapporti sociali che non passano attraverso il salario, l’estrazione di plusvalore e il mercato – a torto ritenuto l’unico luogo dell’economico: tramite questa esclusione si cancellano «intere categorie di persone che non possiedono nemmeno la propria forza-lavoro, perché il loro status impone che questa sia già da sempre appropriata, che appartenga ad altri (…). Si tratta in primo luogo delle mogli, dei servi, degli schiavi e di altri intoccabili» (p. 87). Di queste categorie la tradizione marxista preferisce pensare che non siano soggette a una modalità di sfruttamento distinta, ma che di esse il capitalismo si avvalga per dividere la classe e imporre un sovrappiù di sfruttamento, collocando questi soggetti in fondo alla scala della classe operaia.
Come opportunamente osserva Ardilli nella postfazione, «la fede in un unico modo di produzione induce uno sdoppiamento dello sguardo che si concretizza, con risultati da capogiro, in un dualismo metodologico blindato: una spiegazione sociologicamente informata per tutto ciò che transita attraverso il mercato, da una parte, e, dall’altra parte, la ritirata discreta nell’alveo del determinismo naturale per ogni fenomeno sociale situato ai suoi margini». Si profila dunque la necessità di una teoria generale dello sfruttamento che dia conto non di una sola, ma di tutte le forme di estorsione del lavoro, astraendone i principi.
La traduzione del saggio di Delphy, rappresenta un’occasione per reimmettere nel dibattito sul genere una concezione materialistica dei rapporti sociali di sesso, per concentrare l’attenzione sul lavoro domestico come terreno di una forma di sfruttamento e di un conflitto di classe da rilanciare, per respingere l’idea dominante che, invertendo il rapporto logico e cronologico tra ideologia sessista e appropriazione materiale delle donne, identifica nella «lotta agli stereotipi di genere» e nell’«educazione alle differenze» un’illusoria via di salvezza. Per estrarre infine dal cono d’ombra in cui è celato il nesso strutturale tra lo sfruttamento delle donne all’interno del modo di produzione domestico e la violenza maschile su di esse, una violenza troppo spesso attribuita a una paradossale “crisi della mascolinità” e troppo spesso trattata come una patologia di singoli individui sulle pagine dei quotidiani e nelle aule dei tribunali. Un nesso strutturale che appare ovvio nell’ambito di altri rapporti di sfruttamento o di appropriazione, come quello capitalistico o quello schiavile, ma non nei rapporti sociali di sesso.
Il testo, caratterizzato dal rigore e dal piglio critico e pungente propri della scrittura di Christine Delphy, è offerto nell’eccellente traduzione di Deborah Ardilli, che restituisce la vis polemica dell’autrice, opera scelte linguistiche rigorose per i concetti chiave del pensiero della sociologa e nel contempo chiarifica, grazie anche all’ampio apparato di note, i riferimenti nel testo a contesti, personaggi e tendenze della politica francese. Nella sua densa postfazione Ardilli condensa i tratti pertinenti e l’originalità del pensiero delphiano in costante confronto col pensiero femminista contemporaneo, segnalandosi, come in altri suoi lavori, per l’ampiezza nella visione dei problemi e della storia delle idee.



