di Fabio Ciabatti
Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli e Loris Caruso (a cura di), Popolo chi?, Ediesse, Roma 2019, pp. 214, € 13,39
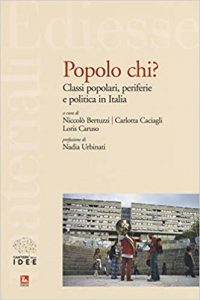 Dagli anni ’80 del secolo scorso le classi popolari sono scomparse dal discorso pubblico mainstream come soggetto autonomo, capace di parlare con una propria voce. Eppure, come ogni rimosso, il popolo riemerge come fantasma cui attribuire tutti i mali del presente: l’elezione di Trump, la vittoria della Brexit, l’affermazione elettorale di Lega, la crescita del razzismo e chi più ne ha più ne metta. “Popolo sei ‘na monnezza!” verrebbe da dire insieme all’ingenuo fraticello interpretato da Alberto Sordi nel film Nell’anno del Signore.
Dagli anni ’80 del secolo scorso le classi popolari sono scomparse dal discorso pubblico mainstream come soggetto autonomo, capace di parlare con una propria voce. Eppure, come ogni rimosso, il popolo riemerge come fantasma cui attribuire tutti i mali del presente: l’elezione di Trump, la vittoria della Brexit, l’affermazione elettorale di Lega, la crescita del razzismo e chi più ne ha più ne metta. “Popolo sei ‘na monnezza!” verrebbe da dire insieme all’ingenuo fraticello interpretato da Alberto Sordi nel film Nell’anno del Signore.
Ma è proprio così? Gli autori del libro Popolo chi? sostengono che si tratta di una rappresentazione decisamente unilaterale. E lo fanno dopo aver ascoltato la voce di quelle classi popolari in nome delle quali molti si sentono autorizzati a sproloquiare. Il testo, curato da Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli e Loris Caruso, rappresenta il risultato di una ricerca basata su 60 interviste in profondità realizzate in quartieri e aree popolari di Milano, Firenze, Roma e Cosenza. Secondo gli autori non esiste un popolo pronto a consegnarsi nelle mani del populismo di destra. Piuttosto, il quadro che emerge viene riassunto con una parola: “contraddizione”. Vediamo brevemente perché.
L’inchiesta rimarca l’importanza della sfera lavorativa nella vita delle persone. “Sfruttato, precarizzato o intermittente, il lavoro (e la sua mancanza) costituisce una parte centrale nella realtà quotidiana di tutti gli intervistati, rappresentando … la fonte principale della loro sofferenza”.1 Di fronte a questa situazione, però, prevale la rassegnazione e la paura. Non si pensa che un’azione collettiva possa cambiarla. La maggioranza delle persone, infatti, non vive questi problemi come immediatamente sociali o, in senso lato, politici. Le sofferenze esperite nel luogo di lavoro sono considerate come mali privati sconnessi dal vissuto e dalle sofferenze delle altre persone che condividono le stesse condizioni. In breve il lavoro è centrale, ma non produce identità sociale e mobilitazione.
Ma dovendo pensare ad un conflitto chi dovrebbe essere la vera controparte? Chi comanda davvero, secondo gli intervistati, non sono i politici, ma i grandi imprenditori, i banchieri e i finanzieri. Eppure nei loro confronti non vengono pronunciate parole di disapprovazione. La condanna, se non un vero e proprio disgusto, viene riservato alla classe politica anche se essa viene considerata alla dipendenze del vero potere, l’élite economico-finanziaria.
L’ostilità nei confronti dei politici si accompagna però a un atteggiamento di delega nei confronti dei partiti. In altri termini non si pensa a un impegno diretto nella politica, ma si vorrebbe che le organizzazioni politiche (e anche quelle sindacali) tornassero ad avere un profilo alto, adeguato alla propria funzione pubblica. Come interpretare questo nuovo profilo? Anche qui abbiamo risposte contraddittorie, alle volte anche dalla stessa persona. Da una parte, si vorrebbero proposte forti che identifichino e differenzino tra loro le forze politiche attraverso una polarizzazione netta e chiara, dall’altra si chiede ai partiti di superare litigi e contrasti inutili, di lavorare insieme in nome del bene comune.
In materia economica, la ricerca riscontra spesso un atteggiamento favorevole alla competizione (contro le cricche, i favoritismi, le raccomandazioni, le posizioni di privilegio acquisito, ecc.), al mercato, alla possibilità di scelta del consumatore, al fare impresa e soprattutto alla meritocrazia, vissuta come un principio che può dare le giuste opportunità a chi non parte da posizioni di privilegio. Nello stesso tempo, però, c’è una voglia sotterranea di liberarsi dalla centralità del denaro che costringe a una vita piena di stress e priva di tempo per gli affetti. In considerazione di questa contraddizione non compare un discorso con elementi di anticapitalismo, ma emerge con molta forza una richiesta di maggiore presenza dello Stato. Praticamente nessuno crede al fatto che la privatizzazione dei servizi pubblici abbia un effetto benefico. Su questi temi gli autori parlano di un “senso comune progressista”.
E veniamo al tema forse più caldo, il razzismo. Inutile nascondersi che l’immigrazione viene considerata come uno dei maggiori problemi. Ma la cosa che balza agli occhi dei ricercatori è che l’esperienza diretta degli intervistati, i rapporti effettivi che intercorrono con gli immigrati sono generalmente descritti con toni positivi. I giudizi negativi, che nondimeno emergono, non sembrano sgorgare da fatti vissuti in prima persona, ma sembrano riecheggiare discorsi altrui, assorbiti attraverso i media tradizionali e i social media.
Ma attenzione, questi discorsi non possono essere considerati come mero frutto di un preconcetto ideologico. L’ostilità nei confronti dei migranti nasce da preoccupazioni strettamente utilitaristiche, materiali: la paura della loro concorrenza nel mercato del lavoro e nell’accesso ai servizi pubblici. Non c’è un pregiudizio etnico-culturale. L’identità nazionale degli intervistati, non a caso, è alquanto debole. Le caratteristiche negative attribuite ai migranti sono praticamente le stesse che sono imputate agli italiani. La diffidenza prevale anche nei confronti dei propri connazionali. Ciò non toglie che proprio la mancanza di un senso comune d’identità, di un sentimento condiviso di appartenenza possa rappresentare il brodo di cultura per l’emersione di pulsioni compensatorie di stampo autoritario e xenofobo.
Se questo è il quadro generale che emerge dalla ricerca, sottolineano gli autori, l’analisi sociale non si può fermare a rilevare la contraddizione. Deve saper dire quale dei due poli che la costituiscono risulti dominante, quale sia maggiormente in grado di orientare l’agire sociale. Oggi senz’altro prevale il lato regressivo. Se prendiamo la questione dell’immigrazione, la destra nelle sue diverse sfaccettature, ha costruito un discorso semplice e apparentemente razionale che fa appello a timori di natura strettamente materiale. Il suo presupposto, rafforzato dalla lunga crisi, è l’inevitabile scarsità delle risorse a disposizione, l’intangibilità dell’attuale distribuzione della ricchezza che penalizza le classi popolari. Il discorso della destra, si potrebbe dire, ha un carattere performativo, non nel senso di inventare una realtà prima inesistente con il solo atto di nominarla, ma nel senso di offuscare, nella percezione comune, un lato della contraddizione a tutto favore dell’altro che in questo modo viene rafforzato.
La sinistra moderata, non volendo intaccare il presupposto di questo discorso perché legata a doppio filo con gli interessi del capitale, è destinata a rimanere incapace di incidere sul senso comune. Non a caso, rileva la ricerca, “tutta la sinistra è sostanzialmente assente dalla vita e dalla coscienza degli intervistati. … I termini usati in riferimento a quest’area politica sono: scomparsa, sbiadita, introvabile, compromessa, subalterna”.2 E, attenzione, tutta la sinistra è sostanzialmente identificata con il Partito Democratico, perché ciò che esiste alla sua sinistra non risulta pervenuto alla percezione comune o è considerato corresponsabile di tutte le recenti scelte di governo del principale partito di centro-sinistra.
Rilevare delle contraddizioni significa tratteggiare un quadro che non è statico ed è, almeno potenzialmente, suscettibile di cambiamenti positivi, di rotture fruttuose. Ma in quale senso occorre lavorare politicamente? In alcuni passaggi del libro emergono indicazioni che vanno nella direzione della ricostruzione, da sinistra, di organizzazioni di massa e di una rappresentanza politico-istituzionale, certamente da adeguare ai tempi correnti. I lati positivi delle contraddizioni rilevate nella ricerca sembrano indicare che uno spazio in questo senso esiste. Viene però da chiedersi perché mai chi ha provato a lavorare in questa direzione in Italia abbia miseramente fallito. Possibile che si tratti solo di pochezza del personale politico? Se poi allarghiamo lo sguardo all’Europa vediamo che quei soggetti che sembravano aver intrapreso questa strada con successo o hanno subito un fragoroso tracollo (Syriza in Grecia) o si sono impantanati (Podemos in Spagna).
Per venire a capo di queste questioni occorrerebbe partire da quella che un tempo si chiamava analisi di fase. Se pensiamo che la crisi attuale non abbia caratteri meramente congiunturali, ma che le si possa attribuire un connotato in qualche modo “epocale” (anche senza pensare a un crollo del capitalismo più o meno prossimo), gli scenari politici che si aprono necessitano di maggiore radicalità. Più che fare leva su uno dei due poli delle contraddizioni più volte richiamate occorrerebbe allora puntare a rimuovere l’elemento che, a mio parere, rende possibile l’oscillazione tra gli opposti: la passività delle classi popolari, il loro atteggiamento delegante. Per innescare questa attivazione, hanno ragione gli autori, “è necessario che specifici attori e organizzazioni la promuovano in modo finalizzato, contribuendo a definire un problema o una condizione come rilevanti e a costituire un’«area di uguaglianza» in cui possano svilupparsi rapporti di solidarietà tra pari”.3 In assenza di ciò forte è il rischio che la rabbia per la propria condizione orienti verso la “competizione orizzontale ciò che potrebbe essere conflitto verticale, [verso la] lamentazione rancorosa ciò che potrebbe essere polarizzazione di classe”.4
I prerequisiti di un’azione politica efficace nella fase attuale non finiscono qua. Gli autori sostengono che le classi popolari, disorientate e impaurite di fronte alla “sensazione che «tutto stia cambiando» o stia per cambiare”, non sono “ostili a discorsi politici che provino nuovamente a interpretare il mondo”.5 Per questo bisogna avere un disegno di società, a patto che si sappia mettere insieme “pragmatismo e capacità di agire sul simbolico”.6 E, in particolare, bisogna “reinventare una lingua (politica) per parlare di ciò che le persone vivono e sono nei luoghi di lavoro e nel processo lavorativo. Su questo, nessuna riscoperta di lingue morte sarà efficace”.7
Certo, tutto ciò non esclude a priori forme di rappresentanza politica, anche istituzionale, ammesso che si riesca a limitare la sua inerziale tendenza a costituirsi come corpo separato, dotato di suoi autonomi interessi. Ma il punto vero rimane la scelta delle priorità della fase. Rilevata una frattura fra popolo e élite economico politica bisogna puntare a colmare questo gap riproponendo una qualche forma di compromesso sociale o occorre piuttosto favorire il rafforzamento di un senso di autonomia e di alterità delle classi popolari nei confronti dello stato e delle istituzioni, recuperando una delle caratteristiche fondamentali del movimento operaio delle origini?
Quale che sia la risposta, ricominciare a fare inchiesta è fondamentale soprattutto quando essa ci aiuta, come nel caso del libro qui presentato, a ribaltare luoghi comuni ideologicamente fuorvianti e politicamente paralizzanti. Senza però dimenticare che, in questo caso, stiamo pur sempre parlando di un’inchiesta, per così dire, a freddo. Molti anni fa Raniero Panzieri ci ricordava l’importanza di quella che chiamava l’inchiesta “a caldo”, fatta cioè in situazione di forte conflitto. In questi momenti, sosteneva il padre dell’operaismo, è possibile studiare “in che maniera cambia il sistema di valori che l’operaio esprime in periodi normali, quali valori si sostituiscono con consapevolezza di alternativa, quali scompaiono in quei momenti, perché ci sono dei valori che l’operaio possiede in periodi normali e che non possiede più in periodi di conflitto di classe e viceversa”.8 In questi momenti caldi ciò che sembrava poco prima impossibile e fantasioso può apparire come qualcosa di semplice e naturale.
Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli e Loris Caruso (a cura di), Popolo chi?, Ediesse, Roma 2019, p. 79. ↩
Ibidem, p. 48. ↩
Ibidem, p. 28. ↩
Ibidem, p. 216. ↩
Ibidem, p. 209. ↩
Ibidem, p. 210. ↩
Ibidem, p. 211. ↩
Raniero Panzieri, “Uso socialista dell’inchiesta operaia”, in La ripresa del marxismo leninismo in Italia, Nuove Edizioni Operaie, Roma 1997, p. 322. ↩



