di Sandro Moiso
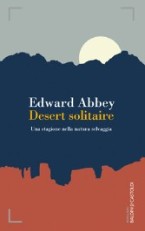 Edward Abbey, Desert solitaire. Una stagione nella natura selvaggia, Baldini & Castoldi 2015, pp. 363, € 19,50
Edward Abbey, Desert solitaire. Una stagione nella natura selvaggia, Baldini & Castoldi 2015, pp. 363, € 19,50
“Questa non è una guida turistica, è un’elegia. Un memoriale. State stringendo una lapida tra le mani. Una roccia insanguinata. Non lasciatela cadere ai vostri piedi, scagliatela contro un grosso vetro. Che cosa avete da perdere?” Siamo soltanto alle pagine introduttive del testo di Edward Abbey, ma già l’autore ha reso esplicito il programma; non soltanto del suo diario del periodo trascorso come ranger dell’Arches National Monument nello Utah, ma dell’intera sua opera letteraria.
Edward Abbey, nato in Pennsylvania nel 1927 e morto in Arizona nel 1989, appartiene sicuramente alla schiera di scrittori statunitensi che hanno posto al centro della loro letteratura la natura e il rapporto che l’uomo mantiene con essa. Insieme al tema della morte è infatti questo ad aver caratterizzato buona parte della migliore letteratura americana e a differenziarla decisamente dalla cultura europea che ha visto nella natura, dai classici a Baudelaire e a Nietzsche, soltanto qualcosa da superare.
Invece, da Henry David Thoreau a Herman Melville e da Walt Whitman a A.B.Guthrie solo per citarne alcuni, il tema del rapporto, spesso distruttivo, instauratosi tra la nostra specie e l’ambiente circostante costituisce il vero centro narrativo dell’opera letteraria. Valga per tutti il capolavoro che fonda la letteratura nord americana: Moby Dick, in cui distruzione e morte della natura vanno di pari passo con quella dell’uomo.
Abbey, però, scrive il suo Desert Solitaire. A Season in the Wilderness nel 1968 e molte cose sono cambiate rispetto al mondo in cui scrivevano gli autori dell’Ottocento e del primo novecento. Non in meglio, poiché la devastazione dell’ambiente legata allo sfruttamento delle risorse oppure alla crescita delle città e delle metropoli o anche soltanto al turismo si è fatta ormai evidentissima. Ogni promessa del millantato progresso si è dimostrata vana e l’American Way of Life soltanto una menzogne o una trappola per allocchi. Ecco perché la sua scrittura si rivela fin dalle prime opere così radicale.
Autore di romanzi come Fire on the Mountain (1962)1 e The Monkey Wrench Gang (1975),2 ha finito col diventare l’inconsapevole (?) ispiratore di movimenti radicali di difesa dell’ambiente e del territorio come Earth First ed altri, sia in America che in Europa. A differenza, però, di un altro grande cantore della wilderness o natura selvaggia, Jack London, l’ambiente, con la sua geologia, la sua flora, la sua fauna, le su acque e i suoi pericoli, per Abbey non è soltanto qualcosa in cui e con cui l’uomo deve imparare a convivere e sopravvivere.
Per lo scrittore statunitense l’uomo deve riconoscersi parte del tutto e difendere, anche con il sabotaggio più radicale, la natura incontaminata, là dove ancora esiste, dallo sfruttamento capitalistico dei suoli e delle sue ricchezze. Preferendo, piuttosto, alla devastazione incontrollata della wilderness, la distruzione della società dell’ingordigia, dell’abbrutimento e dello sfruttamento di qualsiasi specie, non soltanto della nostra. Non essendo, in fin dei conti, quest’ultima né migliore né più importante delle altre all’interno del grande quadro del cosmo che ci circonda e permea.
Non a caso il punto di partenza, l’osservatorio privilegiato sulla realtà è costituito dalle grandi regioni desertiche che si estendono tra l’Ovest e il Sud Ovest degli Stati Uniti. E non solo perché in quei territori di canyon profondissimi, labirinti geologici e caldo insopportabile il nostro si trovò a svolgere l’attività di ranger per il National Park Service per periodi piuttosto lunghi e in quasi totale solitudine.
“Il deserto non dice nulla. Completamente passivo, agìto ma non agente, se ne sta lì come lo scheletro nudo dell’Essere, spoglio, sparso, austero e completamente inutile, invitando non all’amore ma alla contemplazione. Così semplice e ordinato da suggerire classicità; senonché il deserto è un regno oltre l’umano e nella visione classicista solo l’umano è significativo, se non addirittura reale” (pag. 326) Inutile, impensabile per il modo di produzione capitalistico qualcosa che non sia immediatamente utile, e oltre l’umano, totalmente distante da quella cultura umanistica e di stampo prettamente europeo in cui tutto deve essere ridotto all’uomo e alla sua esperienza.
“Ho scoperto che non mi opponevo all’umanità in generale, ma alla centralità dell’uomo, all’antropocentrismo, all’idea che il mondo esiste solamente per l’uomo; che non mi opponevo alla scienza – che significa semplicemente conoscenza – ma alla scienza male applicata, alla venerazione della tecnica e della tecnologia, a quella perversione della scienza giustamente chiamata scientismo; che non mi opponevo alla civiltà ma alla cultura” (pag. 331) Sono qui già accennati argomenti che saranno poi sviluppati da filosofi anarchici come John Zerzan.
Ma è proprio la distinzione tra civiltà e cultura che diventa chiarissima in Abbey: “ Civiltà è la forza vitale nella storia dell’uomo; cultura è la massa inerte delle istituzioni e organizzazioni che vi si accumula intorno e tende a rallentare l’avanzata della vita; Civiltà è Giordano Bruno che affronta la morte sul rogo; cultura è il cardinale Bellarmino, che condanna Giordano Bruno a essere bruciato in Campo de’ Fiori; […] Civiltà è rivolta, insurrezione, rivoluzione; cultura è la guerra di uno Stato contro l’altro o delle macchine contro il popolo, come in Ungheria o in Vietnam; Civiltà è tolleranza, distacco e humor, oppure passione, rabbia e vendetta; cultura è l’esame di ingresso, la camera a gas, la tesi di laurea e la sedia elettrica;
Civiltà è Nestor Machno, il contadino ucraino che combatté i tedeschi, poi i Rossi, quindi i Bianchi, poi ancora i Rossi; cultura è Stalin e la Patria; Civiltà è Gesù che trasforma l’acqua in vino; cultura è Cristo che cammina sulle acque; Civiltà è un ragazzo con una molotov in mano; cultura è il carro armato sovietico o il poliziotto di Los Angeles che gli spara; Civiltà è il fiume che scorre libero; cultura, 592.000 tonnellate di cemento;3 la Civiltà scorre; la cultura si ispessisce e si coagula, come sangue esausto e malato” ( pp. 333 – 334)
Tutto il pensiero radicale dal 1968 in avanti è qui concentrato in poche righe. La lotta per difendere la Natura e l’ambiente è l’unica lotta che può salvare la specie nella sua breve transumanza nell’universo. L’uomo è tale se inserito nella Natura, ma diventa disumano quando se ne separa. Come in Marx, mai citato da Abbey, storia dell’uomo e storia naturale dovranno tornare a coincidere. Pena la fine dell’umanità stessa.
Fine che potrebbe rivelarsi, oltre che tragica, ridicola. Con milioni di individui di ogni sesso ed età inscatolati in sedie a rotelle meccaniche, inquinanti e mortali, che li separano, attraverso pochi millimetri di metallo, dalle bellezze del mondo circostante, rendendoli anche solo incapaci di comprenderle. La poesia della natura non è più per tutti in un mondo dominato dal profitto, dai media e dalle automobili.
“Sono entrato nelle caverne ai piedi delle Mooney Falls, cascate alte settanta metri. Che cosa ho fatto? Non c’era nulla da fare. Ho ascoltato le voci, le molte voci vaghe e distanti ma sorprendentemente umane dell’Havasu Creek. […] Mi sono immerso nel luogo e ho fantasticato per giorni sulla riva della pozza sotto la cascata, ho vagato nudo sotto i pioppi come Adamo, ispezionando i miei giardini di cactus. I giorni si sono fatti strani e ambigui, il fluire del tempo era pervaso da un elemento sinistro. Ho vissuto ore narcotiche durante le quali, come il taoista Zhuangzi, mi preoccupavo delle farfalle e di chi sognava cosa […] e ho smarrito la capacità di distinguere tra me e il mondo circostante” (pag. 275)
L’istituzione dei parchi nazionali sembra poi costituire null’altro che il tentativo di vendere un prodotto a milioni di turisti/acquirenti con l’istituzione di giganteschi Expo che racchiudono la natura in autentiche riserve indiane. Destino che negli Usa sembra accomunare i nativi americani e la wilderness negli stessi ambiti locali. “Quest’area bizzarra che sono sicuro un giorno o l’altro verrà trasformata nell’ennesimo parco nazionale provvisto di polizia, amministratori, strade asfaltate, percorsi naturalistici per automobili, punti panoramici ufficiali, aree per il campeggio prefissate, lavanderie a gettone, punti ristoro, distributori di Coca Cola, toilette e biglietti d’ingresso” (pag. 235)
“I Supai sono una tribù eccellente: sono generosi, festosi e intelligenti. Non solo intelligenti, scaltri. Non solo scaltri, saggi. Esempio: l’Ente degli Affari Indiani e il Bureau of Public Rooads, come la maggior parte degli enti governativi, si intromettono sempre, si agitano sempre, sono sempre in cerca di qualcosa da fare, e l’anno scorso hanno fatto un’offerta congiunta per costruire una strada da un milione di dollari nell’Havasu Canyon senza alcun costo per la tribù, spalancando così la loro terra alle ricchezza de turismo motorizzato. La maggioranza dei Supai ha votato contro la proposta” (pag. 274)
I popoli nativi sembrano ancora riconoscere la differenza tra capitale e vera ricchezza, tra grandi opere e ambiente vitale. Tra interesse della specie e, ancora una volta, cultura. “E’ questo il locus dei? Qui ci sono abbastanza cattedrali, templi e altari per un pantheon di divinità indù […] Se l’uomo non avesse un’immaginazione così debole e facile a stancarsi, se la sua capacità di meravigliarsi non fosse così limitata, abbandonerebbe per sempre le fantasticherie celesti. Imparerebbe a percepire l’assoluto e il meraviglioso nell’acqua, nelle foglie e nel silenzio, e sarebbe una consolazione più che sufficiente per la perdita degli antichi sogni” (pp. 244 – 245)
“L’amore per la natura selvaggia è ben più di un semplice appetito per ciò che è inaccessibile., è anche un’espressione di fedeltà alla terra, la terra che ci ha creato e che ci sostiene, l’unica casa che mai conosceremo, l’unico paradiso di cui abbiamo davvero bisogno. Se solo avessimo gli occhi per vedere. Il peccato originale , il vero peccato originale, è la distruzione cieca per semplice cupidigia del paradiso naturale che ci circonda. Se solo ne fossimo degni” (pag.231)
Sospeso tra memoria romanzata, poesia, saggio, libello politico e panteismo radicale il libro di Abbey si rivela ancora, a distanza di cinquant’anni dalla sua prima stesura e a distanza di venti dalla sua prima edizione italiana,4 un testo fondamentale, non solo per la letteratura americana moderna ma anche per saper distinguere tra civiltà e cultura (elevata o di massa che sia), tra passione e falsa coscienza, tra azione e sottomissione.
“Nel deserto non c’è carenza d’acqua, ce n’è la giusta quantità, un rapporto perfetto tra acqua e roccia e tra acqua e sabbia che assicura la presenza di quello spazio ampio, libero, aperto e generoso tra le piante egli animali, le case, i paesi che rende l’arido West così diverso da ogni altra parte della nazione. Qui non manca l’acqua, a meno che non si voglia costruire una città dove una città non dovrebbe esserci.
Gli Sviluppatori – politici, imprenditori, banchieri, amministratori ed ingegneri – ovviamente la pensano altrimenti e si lamentano in continuazione con amarezza della terribile siccità, soprattutto del Sud Ovest. Propongono progetti faraonici per deviare l’acqua […] Non riescono a capire che la crescita per la crescita è una follia cancerosa […] Non capiranno mai che un sistema economico che può solo espandersi o morire è disonesto nei confronti di tutto ciò che è umano” (pag. 179)



