La Sinistra Negata e gli anni ’90 a cura di Nico Maccentelli
Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale. Le puntate precedenti le trovate nei link a piè di pagina. (Questa seconda parte del redazionale dedicata agli Anni ‘90 è divisa in due puntate e questa è la seconda puntata)
Parte seconda/2: quale comunismo?
3. SUICIDIO, VOCAZIONE ULTIMA.
Detto ciò, siamo ancora ben lontani da una definizione di “comunismo” valida, pur avendone forse individuato qualche elemento. Per “comunismo” si intende infatti anche un tipo di ordinamento economico che contempli il lavoro quale valore d’uso, non di scambio, il comunismo, cioè, a differenza del socialismo, non prevede una permanenza del proletariato, sia pure in posizione di classe dominante, bensì la sua scomparsa in quanto classe legata alla vendita della forza-lavoro e con ciò la scomparsa di tutte le altre classi sociali.
È individuabile qualcosa del genere nei comportamenti storici del proletariato? Nelle fasi di lotta non molto, visto che in quei momenti il problema è combattere le altre classi, mantenendo la propria identità e anzi valorizzandola. Inoltre la questione non può porsi in questi termini in contesti nei quali la scarsità dei beni non consenta una radicale trasformazione delle forme di distribuzione, e imponga la conservazione di una qualche gerarchia sociale, anche se magari capovolta.
Esistono tuttavia comportamenti pre-politici e metapolitici che fanno comprendere come l’abolizione delle classi sia un’altra delle istanze spontanee del proletariato, a pari titolo dell’aspirazione alla democrazia diretta. Per fare un esempio, le lotte alla FIAT dei primissimi anni Ottanta sorpresero gli osservatori per il fatto che protagonista ne era una classe operaia composta da giovani e giovanissimi che, a differenza dei loro “padri”, col luogo di lavoro intrattenevano un rapporto superficiale e non determinante. Le ore di lavoro venivano da questi soggetti, in prevalenza dotati di un buon grado di istruzione, “date per perse”: si trattava ai loro occhi di un sacrificio cui sottoporsi per ottenere il denaro necessario ad una gestione del tempo libero analoga a quella dei coetanei. Era del resto difficile anche solo definire “operai” quei giovani; nel senso che “operai” lo erano nelle ore trascorse in fabbrica, ma per il resto del tempo erano membri di gruppi rock, ragazzi di quartiere, frequentatori di discoteche, anima- tori di varie attività culturali, ecc., ed ai loro occhi questo secondo tipo di definizione era molto più importante della prima.
Di ciò la FIAT, e in altre situazioni il resto del padronato, hanno poi largamente approfittato, sfruttando l’indifferenza alla fabbrica per inasprire disciplina e intensità del lavoro, mentre il capitale in senso ampio coglieva l’importanza del tempo libero e procedeva alla sua sistematica colonizzazione. Sta di fatto che era nata, forse per la prima volta nel nostro paese, una classe operaia che esistenzialmente non si qualificava come tale, e fondava la maggior parte delle proprie rivendicazioni non sui bisogni connessi al luogo di lavoro, ma su quelli maturati fuori.
 Il “movimento del ’77”, nelle sue espressioni migliori, colse con largo anticipo l’avvio di questi processi ad un tempo sociali e culturali, tentando una ricomposizione del proletariato giovanile sul territorio. Non altrettanto sensibile fu la sinistra istituzionale, che guidò le lotte alla FIAT, e in generale quelle aventi a protagonisti gli operai dotati di una soggettività di nuovo tipo, ad una rovinosa sconfitta, salvo poi ripensarne le ragioni e diagnosticare frettolosamente (e stupidamente) un’estinzione del proletariato e delle sue istanze.
Il “movimento del ’77”, nelle sue espressioni migliori, colse con largo anticipo l’avvio di questi processi ad un tempo sociali e culturali, tentando una ricomposizione del proletariato giovanile sul territorio. Non altrettanto sensibile fu la sinistra istituzionale, che guidò le lotte alla FIAT, e in generale quelle aventi a protagonisti gli operai dotati di una soggettività di nuovo tipo, ad una rovinosa sconfitta, salvo poi ripensarne le ragioni e diagnosticare frettolosamente (e stupidamente) un’estinzione del proletariato e delle sue istanze.
Va però osservato, non certo a suo discarico, che era – ed è – obiettivamente difficile organizzare categorialmente una classe operaia che non solo non si sente tale, ma che avverte anche l’impellente necessità di abbandonare quell’abito troppo stretto. E in effetti il più radicato bisogno di quel tipo di giovane operaio era e rimane quello di abbandonare al più presto la fabbrica, rendendo omogenei tempo libero e tempo di lavoro a detrimento del secondo, anche a rischio di cadere in una dilatazione inavvertita della giornata lavorativa, come sta accadendo con il proliferare di attività autonome implicanti un elevato grado di autosfruttamento.
Tutto ciò, a ben vedere, non è che il coronamento logico di un processo storico lunghissimo, che ha visto la classe operaia impegnata a far sì che i propri figli non perpetuassero la condizione dei padri. Si può anzi dire, senza eccessive forzature, che l’intera vicenda del proletariato (non solo italiano) si sia svolta all’insegna dell’autonegazione e dell’eliminazione delle condizioni per una propria riproduzione in quanto classe, attraverso battaglie e conquiste – prima fra tutte quella dell’accesso alla cultura – che impedissero una perpetuazione della condizione subalterna, quanto meno per le generazioni a venire.
Già da questo si dovrebbe comprendere su quali bisogni profondi riposi l’idea comunista, e quanto essa si differenzi da quella socialista, da cui sono scaturiti – non a caso – “stati operai” votati alla cristallizzazione della classe, sia pure in posizione presuntivamente dominante. Ma ciò che più preme osservare è che oggi, in alcune aree del mondo, quel desiderio di abbandono definitivo di una condizione subordinata che le classi subalterne hanno sempre coltivato ha perso ogni connotato velleitario, spostandosi dalla sfera del- l’auspicabile alla sfera del possibile. Difatti l’assetto produtti- vo odierno, con l’automazione, con l’informatizzazione, con la dilatazione dei servizi, si incarica quotidianamente di espellere forza-lavoro dai rami produttivi tradizionali, anche se ciò, in un contesto di squilibri sociali, è fonte non di liberazione, ma di sofferenza e di squilibri ulteriori.
Ciò non autorizza ancora a sognare una società di abbondanza generalizzata, in cui ognuno attinga alla ricchezza sociale fornendo prestazioni lavorative ridotte al minimo (una visione del genere, contemplata da Marx solo in termini di proiezione, sorvolerebbe con troppa leggerezza sul fatto che nel mondo non esiste solo l’Occidente). Autorizza però ad agire per una appropriazione contraria alla logica statal-padronale, e dunque allusiva al comunismo, dei benefici che il nuovo assetto comporta, esigendo quote maggiori di ricchezza sociale e bloccando i meccanismi selettivi laddove un’organizzazione in classi tende malgrado tutto a riproporsi (“malgrado tutto” nel senso di pura imposizione autoritaria, disciplinare, senza vincoli diretti con la nuova configurazione produttiva, che di per sé libererebbe una pluralità di soggetti dai ruoli tradizionali), contendendo al capitale la gestione del tempo libero ed ampliandone l’estensione.
Quest’ultimo punto merita di essere particolarmente sottolineato. Alla luce di quanto si è detto fino ad ora, la vicenda delle classi subalterne ha avuto storicamente un secondo filo conduttore sotterraneo, accanto a quello propriamente politico-rivendicativo; un filo conduttore che potremmo definire “esistenziale”.
Dapprima tentando di garantire almeno ai propri figli un futuro diverso, poi cercando in prima persona di utilizzare in forme svincolate da condizionamenti produttivi il tempo sottratto al padrone, il proletariato ha sempre aspirato ad introdurre nella propria esistenza quei momenti di creatività, di invenzione, di impiego libero da costrizioni della propria intelligenza, riservati dal capitalismo ad altre classi e dal socialismo a ben delimitate corporazioni. Nei momenti più alti di lotta è persino riuscito, sia pure sporadicamente, a portare quella tensione sul luogo di lavoro o sul territorio di riproduzione, sconvolgendone disciplina e norme con l’irruzione di innovazioni umane prima ancora che politiche (dalla “pentola proletaria” dei braccianti parmensi in sciopero ai primi del ‘900, alle rappresentazioni teatrali degli wobblies statunitensi, ai concerti nelle fabbriche occupate durante l’autunno caldo”, fino alle mille trovate del proletariato giovanile intorno al ’77).
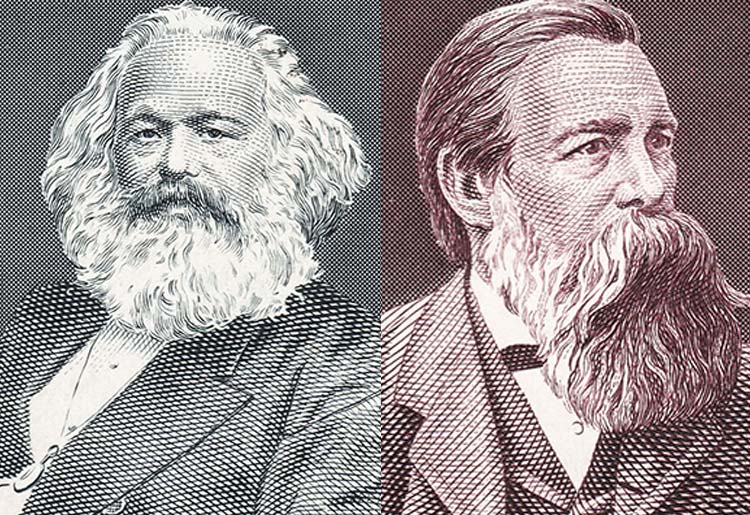 Espressioni squisitamente, puramente comuniste, contenendo in sé non solo una critica alla divisione del lavoro, ma anche una negazione radicale della visione “numerica” cara al capitale, e dunque un’affermazione altrettanto radicale di se stessi come persone (ciò che in passato abbiamo definito, con le parole di un operaio inglese, «sparare sull’orologio»). Senza questa dimensione il comunismo non si dà, a meno di non definire tale qualche squallido inferno alla Pol Pot; e proprio questa dimensione è quella che più chiaramente emerge dalle forme antagonistiche, passate e presenti, del proletariato giovanile, sovente e del tutto a torto scambiate per manifestazioni di svago (da Parco Lambro al movimento punk, dai circoli milanesi della fine degli anni ’70 ai centri sociali autogestiti degli anni a seguire, ecc.).
Espressioni squisitamente, puramente comuniste, contenendo in sé non solo una critica alla divisione del lavoro, ma anche una negazione radicale della visione “numerica” cara al capitale, e dunque un’affermazione altrettanto radicale di se stessi come persone (ciò che in passato abbiamo definito, con le parole di un operaio inglese, «sparare sull’orologio»). Senza questa dimensione il comunismo non si dà, a meno di non definire tale qualche squallido inferno alla Pol Pot; e proprio questa dimensione è quella che più chiaramente emerge dalle forme antagonistiche, passate e presenti, del proletariato giovanile, sovente e del tutto a torto scambiate per manifestazioni di svago (da Parco Lambro al movimento punk, dai circoli milanesi della fine degli anni ’70 ai centri sociali autogestiti degli anni a seguire, ecc.).
Saper leggere il comunismo anche dove non si autoqualifica come tale, al di là di fredde equazioni ispirate alla stessa logica numerica del capitalismo. Questa dev’essere la grande capacità dei comunisti, impegnati ad aiutare la classe operaia a realizzare il proprio destino storico: scomparire.
4. NON PIÙ NEMICI, NON PIÙ FRONTIERE.
Il discorso fin qui svolto ha il grave limite (che poi è il più vistoso della tradizione “operaista”) di riferirsi, salvo qualche fuggevole osservazione, solo ad un contesto occidentale, ed anzi ad una sua porzione. Di fatto il dominio capitalistico, seguendo la propria naturale vocazione, ha raggiunto un’estensione mondiale, pressoché totale, travolgendo anche le superstiti cortine di ferro e di bambù che ne frenavano – seppur malamente – la dilatazione. Ciò pone problemi che a Marx erano certamente ignoti, sebbene gli intellettuali di sinistra più avvertiti – pensiamo in particolare a P.M.Sweezy, Il marxismo e il futuro, Torino, 1980- li abbiano presi in considerazione con largo anticipo sugli attuali sviluppi.
Ai giorni nostri non è più utilizzabile un disegno comunista che tenga presente solo la configurazione economica, politica e sociale delle aree più industrializzate, affidando alla classe operaia di queste ultime l’onere della liberazione dell’intero proletariato; e ciò non solo per il fatto che tale classe perde colpi in tutto l’Occidente, ma per il motivo che alla sua contrazione numerica corrisponde, nello stesso Occidente, una moltiplicazione di soggetti subalterni dalle caratteristiche poco omogenee e non definibili alla luce del ruolo produttivo diretto, mentre alla periferia del sistema, nel paesi del Terzo e Quarto mondo, le classi subordinate proliferano all’interno di processi produttivi che traggono dal centro gli impulsi decisionali. Tutto ciò in conseguenza del decentramento produttivo, dello spostamento dal centro alla periferia delle lavorazioni a tecnologia matura, del passaggio dalle multinazionali alle transnazionali e degli altri fenomeni di cui ci siamo già occupati in altri numeri della rivista.
 Se questo è il quadro, corollari ne sono: 1) una più stretta integrazione tra un’area e l’altra del mondo, come divisione internazionale del lavoro e come conseguente complementarietà produttiva (a tutte spese della forza-lavoro) tra Sud e Nord, tra Est ed Ovest, ecc.; 2) una fluidificazione della forza-lavoro, i cui flussi si spostano da un quadrante all’altro a seconda della domanda e sotto la pressione di scompensi determinati da un contesto unitario ma non omogeneo, fornendo con la loro mobilità un elemento riequilibratore; 3) una limitazione delle funzioni degli Stati nazionali, che sempre più tendono a delegare alle compagnie transnazionali parte delle loro prerogative, tra cui l’azione diplomatica e l’impostazione del commercio estero, mentre nel contempo si inseriscono in sistemi più vasti di decisione politica e di deterrenza repressiva.
Se questo è il quadro, corollari ne sono: 1) una più stretta integrazione tra un’area e l’altra del mondo, come divisione internazionale del lavoro e come conseguente complementarietà produttiva (a tutte spese della forza-lavoro) tra Sud e Nord, tra Est ed Ovest, ecc.; 2) una fluidificazione della forza-lavoro, i cui flussi si spostano da un quadrante all’altro a seconda della domanda e sotto la pressione di scompensi determinati da un contesto unitario ma non omogeneo, fornendo con la loro mobilità un elemento riequilibratore; 3) una limitazione delle funzioni degli Stati nazionali, che sempre più tendono a delegare alle compagnie transnazionali parte delle loro prerogative, tra cui l’azione diplomatica e l’impostazione del commercio estero, mentre nel contempo si inseriscono in sistemi più vasti di decisione politica e di deterrenza repressiva.
La guerra scompare così dall’orizzonte dello scontro tra blocchi; ma essa ricompare all’interno del rapporto Nord-Sud (dove il Nord, paradossalmente, scaturisce dalla somma di Est ed Ovest). La coesione e la funzionalità del quadro può essere mantenuta solo cristallizzando la divisione dei compiti tra le aree geografiche, e cioè la distinzione tra quelle in cui hanno sede comando e tecnologie evolute e quelle fornitrici di materie prime e di manodopera a basso costo. La subordinazione del Sud del mondo assurge quindi a puntello del sistema capitalistico globale, essendo il fattore decisivo che consente di contenere l’aumento della composizione organica del capitale, spinta alle stelle dal rinnovamento tecnologico, nonché di scongiurare la saturazione dei mercati occidentali (evento che il crollo dei paesi dell’Est ha solo procrastinato).
La guerra, come uso della coercizione, del ricatto, del banditismo finanziario si riconferma, anche in un contesto mutato, come quintessenza spirituale del capitalismo, come sua perfetta stilizzazione. Ex-Yugoslavia, Balcani, Africa, Medio Oriente sono lì a riconfermare come il lupo perda il pelo ma non il vizio. Ma storicamente il movimento comunista ha rotto col filone socialista proprio sul tema della guerra, affrontato dal secondo come questione interna ai singoli Stati, e visto invece dal primo come banco di prova della solidarietà tra proletari, come male assoluto da sradicare assieme al sistema disumano che ne è all’origine.
È questa impostazione originaria del problema della guerra, antisocialista, autenticamente comunista, che si legge nella trama delle iniziative di solidarietà tra i popoli che spontaneamente, silenziosamente, in dimensioni inaspettate e mai accertate ha riempito il vuoto degli anni Ottanta (duemila comitati per il Salvador nei soli Stati Uniti!); che ha governato con discrezione i movimenti antimilitaristi, pacifisti e terzomondisti; che si manifesta tuttora nei tentativi di fraternizzazione con il proletariato immigrato, qualora riescano a sottrarsi all’impostazione lacrimosa e insopportabile conferita al tema dalla sinistra istituzionale e dal quotidiano Il Manifesto.
Ma se dobbiamo individuare in questo campo le indicazioni spontanee che giungono dal proletariato, dobbiamo riferirci non a minoranze attivistiche, per quanto generose, bensì alle classi subalterne nel loro assieme, considerate sulla stessa scala mondiale in cui opera il capitalismo.
In molte situazioni a livello internazionale i popoli rivendicano la propria dignità umana, il proprio diritto a vivere ed essere liberi, contro Stati, alleanze di Stati, organismi interstatali e sovranazionali che detengono il monopolio della forza, il monopolio della finanza, il monopolio della politica, il monopolio delle vite. Tale rivendicazione non è in sé “comunista”. È però certo che non vi può essere oggi comunismo che non contempli un ordinamento internazionale fondato su scambi equitativi, tale da impedire che alla divisione in classi interna ai singoli paesi si sovrapponga una divisione in popoli, spostando le dinamiche del privilegio dai contesti nazionali ad interi quadranti geografici.
I due obiettivi fondamentali del comunismo, libertà totale e totale eguaglianza (un terzo si vedrà fra breve) assumono, in un ambito mondiale, le denominazioni di autodeterminezione dei popoli e di equità degli scambi, tra soggetti di pari dignità e di pari potere contrattuale. Mentre la tensione verso l’estinzione dello Stato diviene, in quel quadro allargato, lotta per l’estinzione dei sistemi politici, economici e militari di controllo sovranazionale.
 Battersi per il comunismo significa agire su tutti e due i fronti: quello della propria situazione contingente e quello internazionalista, su cui il comunismo è nato e si è qualificato quale espressione più compiuta dei bisogni proletari.
Battersi per il comunismo significa agire su tutti e due i fronti: quello della propria situazione contingente e quello internazionalista, su cui il comunismo è nato e si è qualificato quale espressione più compiuta dei bisogni proletari.
Simile coerenza, non sempre avvertibile nei movimenti pacifisti e antirazzisti che ancora abbiamo sotto gli occhi, si è scorta durante gli anni ’80 nelle azioni di boicottaggio dei prodotti israeliani e sudafricani, nel sostegno militante al Nicaragua sandinista, al Salvador e agli altri popoli in lotta contro l’imperialismo, ma anche oggi anche se in maniera minore e più ambigua, by default– attraverso la solidarietà nei confronti della causa zapatista del Chiapas messicano.
Marx diceva (ne La sacra famiglia, precisiamo ad uso dei filologi o di chi ci dovesse scambiare per ignoranti) che la Rivoluzione francese, iniziata nel 1789, non si era poi più arrestata. Ebbene, i tre capitoletti in cui è suddivisa la nostra esposizione avrebbero tranquillamente potuto essere chiamati liberté, égalité, fraternité. Perché questo è il comunismo: libertà, attraverso il massimo sviluppo della democrazia reale; uguaglianza, attraverso la soppressione delle classi sociali; fraternità, attraverso la negazione delle frontiere e l’affratellamento dei popoli.
Se ci si riflette un attimo, si tratta delle massime aspirazioni di ogni essere umano dotato di coscienza e di ragione.
(Fine delle puntate de La Sinistra Negata)
Le puntate precedenti le trovate: 01 qui, 02 qui, 03 qui, 04 qui, 05 qui, 06 qui, 07 qui, 08 qui e 9 qui.



