di Franco Pezzini
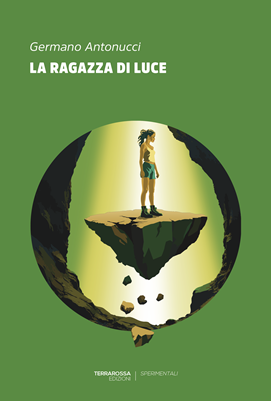 Germano Antonucci, La ragazza di luce, pp. 200, € 16, Terrarossa, Alberobello (Bari) 2025.
Germano Antonucci, La ragazza di luce, pp. 200, € 16, Terrarossa, Alberobello (Bari) 2025.
L’Italia, dalle Alpi al Meridione, è fitta di storie di frane. Un fenomeno geologico che presenta impressionanti contraccolpi simbolici: ora sulla storia comunitaria – pensiamo per esempio ai casi in cui gli archivi locali siano stati spazzati via da valanghe di terra e pietre, a ingoiare i documenti di generazioni – ora su quella individuale: travolgendo una comunità si spezzano vite e storie personali, fino a rendere l’evento una vera e propria linea di demarcazione memoriale. E proprio una frana è l’evento mitologico – evocato di continuo, interiorizzato dai personaggi, richiamato indirettamente persino sulla suggestiva copertina – alle spalle degli eventi di La ragazza di luce.
Si può discutere sull’uso del termine fantastico, per questa storia per molti versi amaramente realista: ma certo una visionarietà a base d’impliciti, di convinzioni, di affabulazioni la percorre tutta, fin dal titolo. Scritto con grande eleganza, finezza e trasparenza stilistica, il romanzo conduce del resto attraverso un set che ha visto la normalità sovvertita nella sua forma più materiale e terrigna, appunto un’apocalittica frana abbattutasi sull’abitato di Lume (e qui attenzione, la copertura del lume con tonnellate di materiali pare suggerire valenze simboliche) recando al contempo frane diverse e interiori. In particolare nella vita dei ragazzini protagonisti, Nina e Ruben, che hanno perso reciprocamente la madre e il padre nel cono d’ombra attorno alla catastrofe, ma in fondo di tutta la comunità, che cerca di riscriversi identitariamente in chiave mitico-magica.
Che succede dunque se presso la croce in capo al promontorio si manifesta una presenza luminosa, appunto la figura eponima, e qualcuno prende a gridare al miracolo? Che succede se una ragazzina di grande fantasia e intraprendenza, che il magico l’ha assorbito fin da piccola nei discorsi in casa, si vota alla quest d’una madre ingombrante e amatissima, misteriosamente perduta – nell’inaccettabilità d’una categoria-morte cui non riesce a dare un senso? E se un ragazzino vissuto nell’ammirazione del padre deve incassare con l’enigmatica fine di lui una nuova definizione affettiva della vita di sua madre? E se una bimba malata diventa motore di ambigui movimenti economici coinvolgenti tutta la comunità? Germano Antonucci, un autore giovane e brillante già emerso tra i finalisti del call Calvino qualche anno fa offre in questa bella storia di formazione – ma anche di solidarietà, di amicizia, senz’altro d’amore – con venature noir una prova di alto livello, densa e profonda.
Fuori dal mito di paese, Nina stessa diventa in qualche modo la ragazza di luce illuminando con la sua azione ribelle le ombre della comunità. Beninteso, non attraverso la stregoneria fai-da-te di sassi bianchi e neri smossi come in una frana simbolica (“Il male arriva e passa, / il male ti punisce, / se metti il nero al centro / il male ti obbedisce”) per colpire chi la ferisca: ma piuttosto nel far uscire allo scoperto i villain e nell’imparare a metabolizzare quell’amore-“cosa rotta” per una madre squilibrata e aggressiva, a tratti alla deriva delle proprie frane patologiche, fino a trovarle un posto più stabile nel proprio sistema affettivo e in un equilibrio emotivo. Nel proprio e, si può dire, nel nostro: abbiamo bisogno che la narrativa – tanto più quella letteraria, come nella scrittura alta di Antonucci – ci aiuti a dire il rapporto con la malattia mentale, suscitatrice di una straziante altalena di emozioni (conflitto, rifiuto, ostilità, pietà, dolore, amore) in chi è legato da rapporti affettivi e poi, a cerchio d’onda, negli altri attorno. Tanto più nell’empatia con persone che non possono vantare la statura pubblica di un’Alda Merini, ma restano isolate e stigmatizzate in giudizi frettolosi dietro i paraventi comunitari. Le ferite interiori della combattiva Nina richiederanno una vita per essere ricucite, ma una nuova luce di comprensione apre a un futuro e a una realistica felicità.
E anche Ruben, in parallelo, dovrà sistemare la “cosa rotta” accettando nuovi equilibri affettivi. Che i genitori siano oggetto di mito (il padre, per Ruben) o invece di conflitto (la madre), è difficile trovare una lingua giusta per parlarne, soprattutto in presenza di vicende drammatiche ma in fondo sempre, per ciascuno di noi. L’adolescenza è sempre terra di frane, grandi e piccole: e questo trovare parole è anche la voce di una crescita, di un salvarsi dalla catastrofe.



