di Franco Pezzini
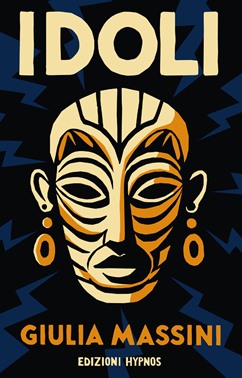 Giulia Massini, Idoli, prefaz. di Giacomo Ortolani, pp. 288, € 16,90, Hypnos, Milano 2025.
Giulia Massini, Idoli, prefaz. di Giacomo Ortolani, pp. 288, € 16,90, Hypnos, Milano 2025.
“[…] Vi dico a un esterno cosa sembra: il racconto di una mitomane e il quadro di un’isterica”.
“Ah sì?” Don Thierry sollevò un sopracciglio. “Le sembra così, monsieur? Noi invece la chiamiamo possessione”.
Una delle scoperte più appassionanti dell’anno in corso, per quanto riguarda la narrativa che ormai, congruamente o meno a seconda dei casi, si definisce weird, è questo bellissimo romanzo. Appassionanti non solo per la trama, indubbiamente forte e molto originale, ma anche per il passo narrativo davvero letterario. Giulia Massini trasfonde nell’opera una ricchezza di livelli, un’eleganza di scrittura, una potenza di suggestione che di rado si trovano attestati nel fantastico italiano contemporaneo.
Non solo ricorre dunque a un topos, la possessione, che da Blatty in poi ha ridefinito l’horror ed è letteralmente fradicio di possibilità e implicazioni, ma viene spesso gestito in chiave banale e stereotipata. La più affascinante eredità de L’esorcista di Friedkin, 1973 non sta nella pletora di invasamenti demoniaci inscenati in quello che ormai, a dispetto delle gloriose origini, è un filone tristanzuolo e ritrito: molto più intrigante di mille L’esorcista del papa, a quel punto, è la scena del film La grande bellezza in cui Jep Gambardella si congeda dall’anziano e papabilissimo cardinal Bellucci (Roberto Herlitzka) cultore di buona cucina, profitta del momento appartato per chiedergli conto delle voci sulla sua attività come esorcista, e quello non risponde, impartendo una benedizione e facendo ripartire la macchina. No, qui il discorso si amplia, punta verso l’ambiguità stessa del concetto di spirito possessore, verso il rapporto con frantumi di un’identità a interpellare l’etnopsichiatria…
Anzi, Massini non solo propone con autentico rispetto antropologico alcune categorie legate alle culture africane (bacino ormai tradizionale di analisi della possessione come fenomeno sociale) senza banalizzarle in caricature e conservandone la cifra di mistero e disinvoltura, ma problematizza il raccordo tra simili esperienze & impliciti e le società occidentali con le loro più pudiche psicoterapie.
Ancora: Massini pone in scena in modo convincente una catena di crisi originate da genitori ingombranti, divoranti. “Forse siamo tutti figli di un padre da annientare”, anche se persino questo si rivelerà falsante.
Diciamo che, leggendo, si coglie una profondità che è anzitutto quella umana dell’autrice (e questo è un bonus che nessuna scuola di scrittura può offrire), attraverso dimensioni sofferte evocate nei Ringraziamenti, alle quali Massini ha saputo rispondere creativamente con una maturità e una tostaggine che la fanno amare. Se davanti a un romanzo – qualunque, anche questo – non è tanto l’autore a essere importante ma piuttosto l’esito finale, qui il lettore vorrebbe essere in amicizia con una persona di tanta ricchezza interiore.
Brevemente e tentando di non spoilerare: la storia corre tra il 1999 e il 2000, scandita da storie, sogni, ricordi. Valerio Sergio Iacono, psicoterapeuta, figlio di un luminare cauteloso e ingombrante con la cui memoria è ancora in conflitto, si è specializzato in ipnosi regressiva con la convinzione della sua utilità per far riaffiorare dimensioni di psiche più duttili e sanabili. Un successo con il caso di una famosa attrice affetta da porfiria l’ha lasciato svuotato: il suo problema è di lasciarsi coinvolgere troppo – in modo, si direbbe, troppo affettivo – dal rapporto coi pazienti, lasciandosi colonizzare dagli inconsci altrui. Qualcosa che assume conturbanti eco storiche quando gli arriva un caso di estremo interesse e urgenza, quello dell’anziano Ernesto Kéréku, elegante antichista e antropologo figlio di un guaritore africano del Benin e di una veneziana: il suo problema è il rapporto ossessivo, feticistico con gli oggetti da cui è impossibilitato a separarsi. Ernesto, Nesto per la sua famiglia, ha cercato Iacono perché vuole scendere in trance ipnotica, liberarsi “e trovare… qualcosa”. Vive in una casa liberty centralissima e nascosta a Bologna, parossisticamente piena di libri e oggetti e colori africani, e che – lui ne è convinto – “vivrà in eterno”: una casa dove le cose sono “costrette a restare” in modo quasi osceno, e che brulica di oggetti particolari – come un certo calamaio (“Con l’inchiostro che conteneva si potevano scrivere solo lettere di vendetta”), un fermacarte con un glifo vevè per entrare in comunicazione con gli spiriti, un feticcio summon di Makeba la potente guaritrice…
Di fronte a una storia di magia e feticci animati dove compare un Kéréku e c’entra l’Africa occidentale, inevitabile pensare al bellissimo lungometraggio animato franco-belga-lussemburghese del 1998 Kirikù e la strega Karabà di Michel Ocelot, ispirato a un racconto folkloristico di quel cantone del continente: ma la storia non c’entra e può avere al massimo influito sul nome dell’anziano signore (“Anche se lei non è il Kéréku cui loro pensano, fa parte di questa storia”, si dice in effetti a un certo punto).
Il fatto è che – apprende stupito Iacono – gli oggetti sarebbero impregnati di spiriti legati agli orizzonti della nostra vita interiore, con sentimenti fin troppo connessi. E fin da subito Nesto confida l’importanza per lui del culto beninese dei Marassa, i gemelli divini che sgomitano nei suoi sogni: quanto rilevino lo capiremo con un certo raccapriccio solo molto più avanti. D’altra parte Nesto si crede un mostro: e scopriremo via via perché.
Il quadro familiare che si spalanca è un terreno minato (“certe famiglie sono come un patto […] È qualcosa che non può essere sciolto”). Nesto è ancora schiacciato dall’ombra del padre Ben, guaritore e mago tirannico all’inizio presentato come un abile ciarlatano, ventriloquo, ma che poi emerge come un uomo d’impressionante potere in grado di curare come di colpire, un domatore di spiriti socialmente intoccabile persino negli anni del fascismo. La madre Maria aveva una figlia di primo letto e solo con grande fatica è riuscita ad avere Nesto: italianissima, per compiacere il marito ha assunto abitudini e posture africane. La figlia, la procace Ines sorellastra di Nesto, vorrebbe pure essere africana: anche lei non riesce a generare figli vivi e a un tratto prende a manifestare un rapporto morboso con la propria bambola. Al contrario Nesto vorrebbe avere pelle e tratti somatici da bianco: marginalizzato a scuola, viene affidato dal padre a don Ilario, un candido sacerdote locale che prende a frequentare lo stregone molto perplesso del suo sistema sincretico. Dei due angeli associati a ciascun essere umano, Ben è in grado di rubare quello piccolo, insomma la parte volatile, con risvolti via via più orridi.
Affascinato dal caso (“era tutto ciò che esaltava il mio spirito”), genuinamente affezionato a Nesto (cogliamo un’affettività terremotata che trova sfogo solo nel lavoro: più volte vorrebbe abbracciare il paziente, ma in terapia non si può), Iacono teme di finire assorbito come nel precedente caso dell’attrice. Un timore persino riduttivo, considerando in cosa precipiterà la sua deriva…
Quali sono i rischi veri della terapia ipnotica? Cos’è il piccolo pezzo di materia biologica ormai essiccata che Maria conserva, e perché gli ornati della villa ripropongono ossessivamente il tema della biforcazione? A cosa serve un cadavere vivente? Che forma può assumere un’anima, e cosa desidera? Iacono, che si crede un nuovo Charcot, vuole davvero risolvere il caso e guarire il paziente? Perché la giovane Laura Blanchard, sosia di Ines, dà segni d’essere ossessa? E don Thierry, giovane e corrucciato parroco haitiano, successore ideale del tenero Ilario buonanima, ha davvero capito la situazione? Ma soprattutto, cosa inabita rabbiosamente la bambola di Ines e poi una spilla con un cammeo d’onice effigiante una testa africana, in grazia di “qualche spiritismo insito nelle cose” e forme forse di magia nera?
Giulia Massini ci regala un testo capace di far riflettere e orripilare con squisita intelligenza e originalità.



