di Giovanni Iozzoli
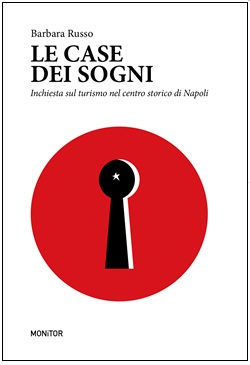 Barbara Russo, Le case dei sogni. Inchiesta sul turismo nel centro storico di Napoli, Monitor, Napoli 2025, pp. 109, € 12,00
Barbara Russo, Le case dei sogni. Inchiesta sul turismo nel centro storico di Napoli, Monitor, Napoli 2025, pp. 109, € 12,00
Il tema dell’abitare ha assunto una centralità paragonabile al tema lavoro, nella definizione delle gerarchie sociali e dei destini individuali, dentro le metropoli tardocapitaliste.
Questa è una novità della fase storica che stiamo vivendo. Fino a vent’anni fa il reddito/lavoro costituiva la premessa per l’accesso al bene casa. Sulla base del reddito si articolavano le diverse modalità di fruizione del diritto all’abitare – affitto, acquisto diretto, mutuo. Il lavoro era la precondizione dell’accesso alla merce casa. Oggi, le due categorie – casa e lavoro – si sono in qualche modo sganciate dal reciproco rapporto di dipendenza. Si può avere un lavoro e non avere diritto all’abitare, anche dentro condizioni contrattuali dignitose. Si può lavorare 50 ore a settimana e finire col dormire in una macchina.
La specialissima merce casa si è come autonomizzata dall’ordinario meccanismo di formazione del prezzo delle merci. E’ diventato un terreno nuovo di gerarchizzazione dei rapporti sociali, la linea di confine tra il “dentro” e il “fuori”, tra l’appartenenza alla polis e la collocazione nei suoi bordi sfrangiati. La casa è un prisma attraverso cui si possono leggere in controluce diverse tendenze generali in atto: la crisi dei ceti medi, la ripolarizzazione feroce della distribuzione del reddito, lo spazio urbano come luogo privilegiato di incontro tra capitale finanziario e produttivo, l’espansione della bolla immobiliare come indicatore ultimo della decadenza economica di un “capitalismo nazionale”.
Infatti l’impazzimento del valore e dei prezzi del mercato immobiliare è in stretta connessione con la crisi generale del sistema capitalistico, con le sue difficoltà di autovalorizzazione che costringono ad individuare le superfici edificabili, come unica controtendenza alla caduta dei profitti nei settori di impiego tradizionale. Quando una metropoli si deindustrializza, sposta tutte le sue energie e risorse su quel terreno – dietro le ambigue formule del ridisegno urbanistico, della riqualificazione, del contrasto al degrado, del restyling etc – e la città, le sue mura, le sue strade, le sue piazze, le sue abitazioni, diventano snodo centrale del ciclo di valorizzazione.
Il possesso/eredità di un immobile (familiare) è oggi la modalità prevalente e quasi esclusiva per accedere al mutuo/acquisto, mentre l’affitto è sopposto ad un vertiginoso processo di rendita speculativa pressoché inarrestabile – tendenza che rende la società italiana sempre più simile a quella degli Stati Uniti. Lavoro/reddito/casa rappresentano un intreccio tematico in radicale ridislocazione; e per raccontare la moderna condizione proletaria nella metropoli, sarà necessaria una nuova qualità dell’indagine sociologica e dell’inchiesta sul campo.
E’ lo sforzo che affronta Barbara Russo nel suo libro Le case dei sogni, un testo che si inserisce nel filone di indagine che il ricercatore collettivo Monitor continua a produrre, partendo dalla metropoli napoletana ma relazionandosi agli analoghi fenomeni più generali della società italiana.
A Napoli, il nodo del diritto all’abitare si intreccia strettamente con i processi di turistificazione e gentrificazione (alla napoletana) di quello che è il centro storico più vasto e popolato d’Europa. E tali processi a loro volta ridisegnano il mercato del lavoro e riconfigurano la cartografia dei poteri sul territorio – tra governi locali, imprenditoria privata tradizionale e nuova imprenditoria del terzo settore. Un approccio analitico che inquadra Napoli, quindi, non come eterna capitale dell’arretratezza, bensì laboratorio avanzato di tendenze della ristrutturazione capitalistica – nonché di forme originali di resistenza sociale.
Barbara Russo sceglie l’approccio etnografico, ormai indispensabile per indagare le fenomenologie sociali complesse, intervistando diverse tipologie di figure che si ritrovano nel vortice dei cambiamenti. Si va dai privati cittadini lanciati nella speculazione del b&b fai da te, agli operatori più strutturati che hanno scelto la via del property manager – l’intermediazione professionale che si va regolarizzando sul piano normativo e fiscale, creando anche nuovi elementi di stratificazione sociale. Fino ad arrivare ai “danni collaterali” prodotti da ogni espansione di mercato: le persone vittime dell’espulsione dal centro di Napoli, cacciate da case destinate ad essere fagocitate dentro al ciclo della speculazione turistica.
Molti degli intervistati raccontano di essere rimasti nelle loro case quando i proprietari hanno alzato i canoni di locazione all’improvviso, di aver accettato di pagare fitti più alti pur di continuare a vivere in quelle case, di aver assecondato le sempre nuove richieste dei proprietari nonostante l’assenza di manutenzione e contratti registrati per metà o del tutto in nero. Quando sono arrivati gli sfratti, alcuni di loro hanno provato a resistere, non solo perché non avevano altri posti dove andare, ma anche per salvaguardare il legame affettivo con le loro case e non perdere i rapporti con il vicinato, che in molti casi fornivano loro anche una possibilità di accedere al lavoro e al welfare. Chi alla fine ha dovuto lasciare la casa, ha preferito accettare canoni di locazione più alti a fronte di condizioni abitative peggiori, oppure si è fatto ospitare da amici e parenti, rinunciando ad avere una casa propria pur di rimanere in questi quartieri, vicino alle proprie comunità, ai luoghi di lavoro, alle scuole dei figli e agli spazi dove si svolge la propria vita quotidiana. (pag. 11)
La maggior parte dei soggetti più deboli, non possono che cedere alla speculazione e alla forza di impatto dell’industria turistica. Racconta una famiglia intervistata:
Da otto anni viviamo in questa casa, qui abbiamo le nostre abitudini, la scuola, il parco, la chiesa; si tratta di perdere tutto (…). Il proprietario ci ha detto che ce ne dobbiamo andare perché vendono tutto, anche gli altri due appartamenti che hanno nel palazzo. Gli avevo chiesto di mantenere l’affitto ma mi ha risposto che tutti gli appartamenti diventeranno b&b e che quindi non è possibile restare. Saranno venute a vedere la casa più di cinquanta persone: parlano di come aggiustarla, di cosa cambiare per farne un b&b… (pag. 60)
Quindi il passaggio storico, epocale, che ha investito Napoli, nel racconto di Barbara Russo, è facilmente leggibile.
Attori sociali vecchi e nuovi individuano nel centro storico della città un terreno di valorizzazione che può essere venduto all’industria dell'”esperienza turistica”, che dall’inizio del secolo in corso ha cominciato a inserire Napoli nella sua mappa di itinerari pregiati. La composizione sociale popolare e sottoproletaria di quei quartieri rappresenta un ostacolo a tale valorizzazione, ma anche una risorsa in quanto serbatoio di mano d’opera inutilizzata. Comincia il processo di espulsione delle classi povere che liberano metri quadri per l’uso turistico e allo stesso tempo la messa in valore della forza lavoro che in quei territori vive. Nasce la retorica del turismo come Grande Occasione di emancipazione. Si uso lo stigma che ricade da sempre sui quartieri popolari – parassitismo e malavita – per legittimare il ridisegno urbanistico e sociale dei territori. Nel racconto che ne fanno i residenti, alcuni rioni, come la Sanità, aderiscono perfettamente a questo schema – senza dimenticare che le vite delle persone non sono né schemi né statistiche.
Una delle maggiori contraddizioni che saltano all’occhio quando si osserva ciò che sta accadendo alla Sanità riguarda lo squilibrio tra il potere d’acquisto dei turisti e quello dei residenti. Dai beni di prima necessità, fino alle attività commerciali e di ristorazione, i prezzi sono aumentati ma la povertà del quartiere è rimasta invariata. Applicato al campo degli affitti, questo scarto rivela un nuovo cortocircuito prodotto dall’economia turistica, capace di tagliare in due la città: un mercato immobiliare dai valori sempre più alti che non coincide con i redditi e le possibilità economiche degli abitanti, apre la strada a nuovi attori (pag. 67)
E quindi, sovente, lo sfrattato, diventa anche carne da macello dell’industria turistica.
Nel caso di Cinzia, come in quelli di Dinesh, Pramila e altri intervistati che hanno perso la casa, proprio chi è impiegato come mano d’opera precaria, flessibile e sottopagata nel comparto alberghiero o extra-alberghiero, è poi coinvolto nelle sue “esternalità negative”, in primis gli sfratti e la perdita della casa. (pag. 81)
La retorica delle Grande Occasione, l’eterno mito del Risanamento napoletano, il turismo come moderna panacea alla crisi delle metropoli e il nodo casa come nuovo ordinatore sociale, sono fenomeni ricorrenti che investono tante città ma che a Napoli si presentano nelle forme più trasparenti e leggibili. Le analisi elaborate in questo libro, prodotte “dall’interno” dello tsunami sociale che sta ridisegnando le metropoli, rappresentano il racconto vivo, in presa diretta, di un grande cambiamento che arricchirà pochi e peggiorerà le condizioni di tanti. Senza il protagonismo dei soggetti che vivono la città, senza il rispetto dei loro bisogni e della loro storia, nessuna emancipazione è possibile: soprattutto se fondata sulla speculazione immobiliare.



