Sinistra rivoluzionarla e composizione di classe in Italia (1960-1980) a cura di Nico Maccentelli
 Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale. Le puntate precedenti le trovate nei link a piè di pagina.
Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale. Le puntate precedenti le trovate nei link a piè di pagina.
Parte terza. Ancora sugli Anni Ottanta.
La sinistra rivoluzionaria italiana di fronte alla crisi. (Seconda parte)
2. I FATTORI SOGGETTIVI.
Malgrado quanto si è detto, non ci si deve illudere che il crollo subito dalla sinistra di classe nel corso degli anni Ottanta sia stato dovuto in via esclusiva all’iniziativa dell’avversario.
La storia delle classi subalterne italiane e delle loro espressioni organizzate ha conosciuto momenti di repressione più dura (anche se non sotto il profilo della mistificazione ideologica, oggi acuta quanto mai in passato) senza che ciò comportasse un vero e proprio salto generazionale, né il formarsi di un drammatico vuoto di memoria.
È nostro avviso che, se ciò è avvenuto, la causa vada ricercata anche in debolezze interne, che hanno dettato reazioni sbagliate e confuse a quanto stava accadendo. Cercheremo di esaminare brevemente alcuni dei comportamenti dannosi e autolesivi che hanno consentito alla repressione di colpire tanto in profondità.
Durante l’emergenza.
Alla fine degli anni Settanta la sinistra rivoluzionaria coltiva un senso di potenza rasentante l’illusione dell’invincibilità. Non vi è scuola, non vi è quartiere, non vi è grande fabbrica, nelle maggiori città italiane, in cui non si respiri aria di insubordinazione. Inoltre il ’77 ha instaurato forme di socialità e
di aggregazione in gran parte sconosciute al ’68. È possibile vivere assieme, come una grande tribù, riducendo al minimo i contatti con la società “esterna”. Per molti resta indimenticabile l’enorme corteo che alla fine del 1977 si è mosso attraverso Bologna, a conclusione del convegno sulla repressione, e la sensazione respirata nei giorni precedenti di potersi quasi impadronire di una intera città.
In realtà, il potere non è stato nemmeno scalfito in nessuna delle sue strutture, per quanto terreno abbia perso nel controllo delle culture e del comportamenti. Di ciò ci si rende conto solo dopo il “caso Moro”, allorché ha inizio la repressione sistematica ed indiscriminata. La reazione di molti è la sorpresa, cui segue lo sbandamento, e anche le iniziative di autodifesa frettolosamente approntate sono del tutto inadeguate all’ampiezza dell’attacco avversario. Eppure la sopravvalutazione delle proprie forze, e la sottovalutazione delle forze altrui – primo degli errori che ci preme segnalare – continuano ad operare per alcuni anni ancora. Lo si vede allorché, nel 1980-81, inizia il grande “dibattito” (se cosi si può chiamare) sull’amnistia.
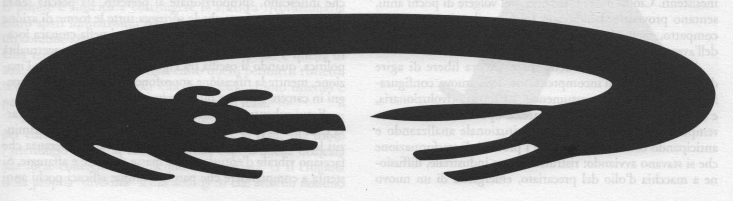 Alcuni compagni (in particolare quelli che fanno capo alla rivista romana Assemblea, e molti di coloro che hanno trovato rifugio all’estero) vedono l’amnistia generalizzata, frutto di una campagna indirizzata in tal senso, quale soluzione del problema di quell’enorme fetta di movimento che da un paio d’anni popola le carceri italiane. Altri la giudicano invece uno sbocco di tipo riformistico, equivalente a un cedimento, e propongono una via d’uscita intermedia: una mobilitazione collettiva perché ai detenuti politici vengano concessi gli arresti domiciliari, quale premessa per una liberazione non patteggiata. Vi è infine chi ritiene riformistiche e perciò negative entrambe le soluzioni precedenti e, pur non appoggiando l’area delle formazioni armate, sostiene che la liberazione dei detenuti politici potrà risultare solo da un’azione di forza. Giudicate oggi, simili discussioni appaiono francamente demenziali, perché ispirate a una premessa demenziale: quella che il potere fosse tanto debole da concedere amnistie, arresti domiciliari o da tollerare soluzioni di forza, e la sinistra rivoluzionaria ancora tanto possente da poter imporre l’una o l’altra delle alternative.
Alcuni compagni (in particolare quelli che fanno capo alla rivista romana Assemblea, e molti di coloro che hanno trovato rifugio all’estero) vedono l’amnistia generalizzata, frutto di una campagna indirizzata in tal senso, quale soluzione del problema di quell’enorme fetta di movimento che da un paio d’anni popola le carceri italiane. Altri la giudicano invece uno sbocco di tipo riformistico, equivalente a un cedimento, e propongono una via d’uscita intermedia: una mobilitazione collettiva perché ai detenuti politici vengano concessi gli arresti domiciliari, quale premessa per una liberazione non patteggiata. Vi è infine chi ritiene riformistiche e perciò negative entrambe le soluzioni precedenti e, pur non appoggiando l’area delle formazioni armate, sostiene che la liberazione dei detenuti politici potrà risultare solo da un’azione di forza. Giudicate oggi, simili discussioni appaiono francamente demenziali, perché ispirate a una premessa demenziale: quella che il potere fosse tanto debole da concedere amnistie, arresti domiciliari o da tollerare soluzioni di forza, e la sinistra rivoluzionaria ancora tanto possente da poter imporre l’una o l’altra delle alternative.
L’esperienza degli anni successivi ha poi dimostrato che il potere é disposto ad attenuare l’emergenza e a concedere qualche brandello delle libertà sospese solo quando è ben certo di avere ridotto all’impotenza i propri antagonisti; ma l’eccessiva fiducia in se stessa che la sinistra di classe manteneva nei primi anni Ottanta la induceva a ignorare questa verità lapalissiana, dividendosi sull’opportunità di concessioni date per già acquisite, ma che nessuno era in realtà disposto ad accordare a titolo di pura elargizione.
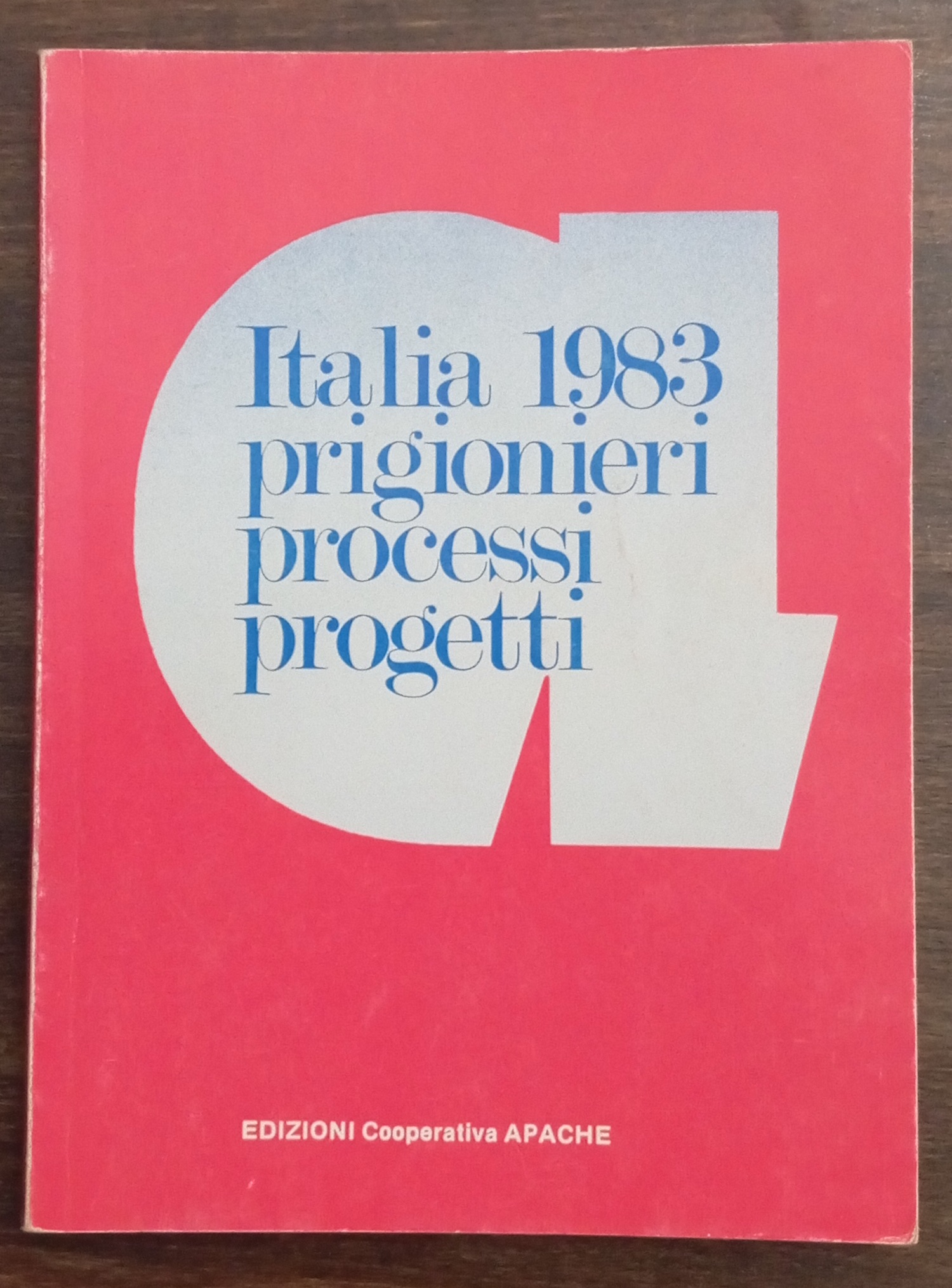 Simile distorsione percettiva è in parte riconducibile ad un secondo errore in cui la sinistra di classe incorre negli anni bui, anche se non del tutto volontariamente. Gli arresti in massa e la presenza di tanti militanti in carcere fanno si che la tematica carceraria assorba quasi totalmente l’attenzione del compagni, rimasti in libertà, a scapito di ogni altro terreno d’intervento. Ciò è largamente comprensibile e dettato da uno stato di obiettiva necessità; questo non toglie che, sfogliando oggi le riviste di allora, si rimanga perplessi notando che il problema carcerario sovrasta praticamente tutti gli altri, che appaiono semplici appendici di quello.
Simile distorsione percettiva è in parte riconducibile ad un secondo errore in cui la sinistra di classe incorre negli anni bui, anche se non del tutto volontariamente. Gli arresti in massa e la presenza di tanti militanti in carcere fanno si che la tematica carceraria assorba quasi totalmente l’attenzione del compagni, rimasti in libertà, a scapito di ogni altro terreno d’intervento. Ciò è largamente comprensibile e dettato da uno stato di obiettiva necessità; questo non toglie che, sfogliando oggi le riviste di allora, si rimanga perplessi notando che il problema carcerario sovrasta praticamente tutti gli altri, che appaiono semplici appendici di quello.
L’errore di prospettiva consiste nel fatto che la situazione dei militanti incarcerati sarebbe stata di gran lunga migliore (e lo sarebbe ancor oggi) se il movimento si fosse mosso con decisione nella società, continuando la propria crescita e comunque mantenendo le posizioni già acquisite; invece la sinistra rivoluzionaria rimane immobile e con lo sguardo fisso sulle pareti delle prigioni, dove sono sì rinchiusi i compagni migliori, ma dove le possibilità di espansione sono pressoché inesistenti. Ciò fa sì che i detenuti, nel volgere di pochi anni, sentano provenire dall’esterno solo un silenzio via via più compatto, mentre chi è rimasto fuori paga le conseguenze dell’aver assunto una posizione meramente difensiva.
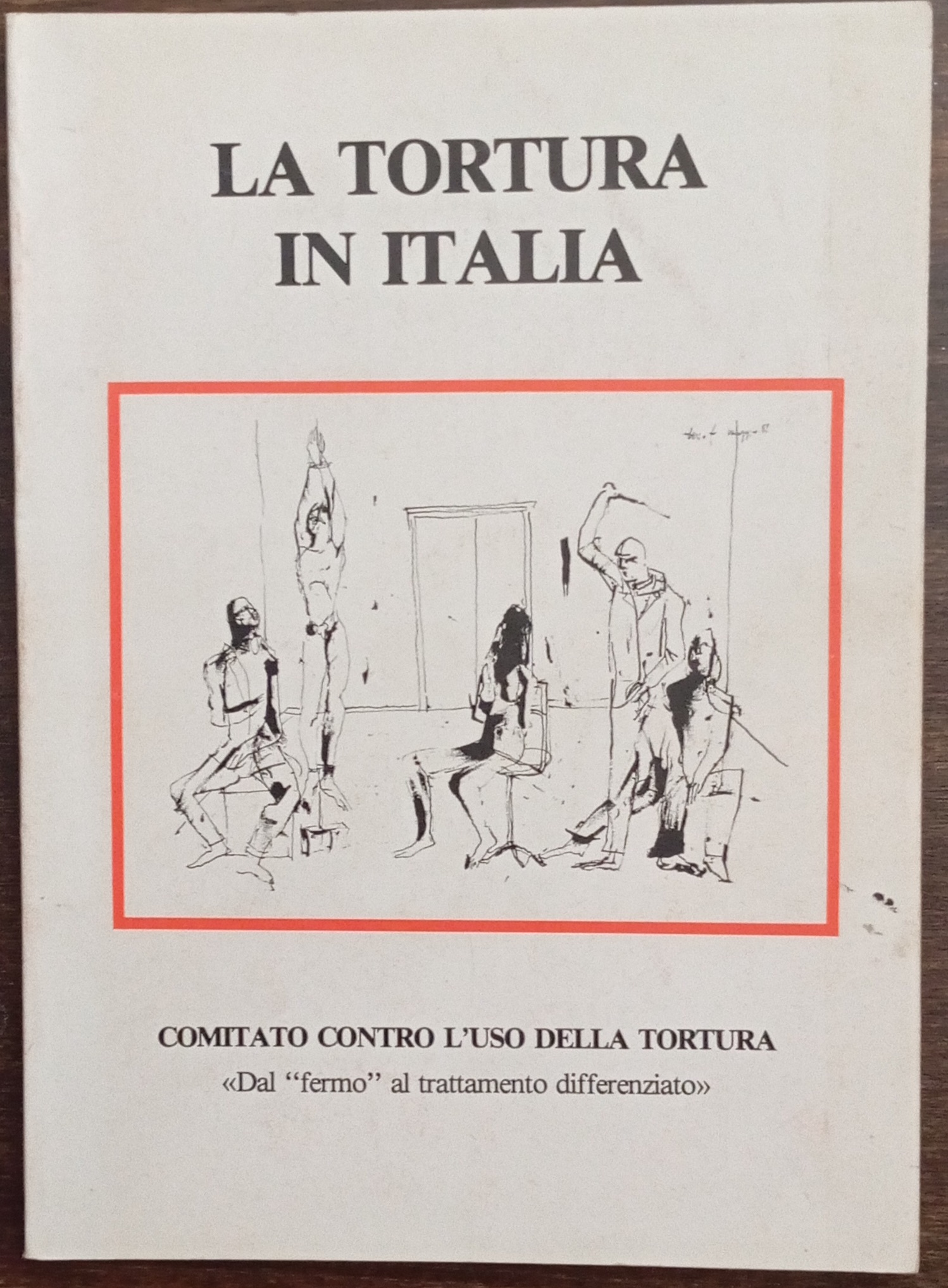 Ma l’indebolimento delle forze ancora libere di agire discende anche dall’incomprensione della nuova configurazione che la società sta assumendo. La sinistra rivoluzionaria, e in primo luogo quella di matrice operaista aveva a suo tempo dato scacco alla sinistra istituzionale analizzando e anticipando con enorme lucidità i processi di trasformazione che si stavano avviando: ristrutturazione industriale, diffusione a macchia d’olio del precariato, emergenza di un nuovo proletariato territoriale, e così via. Un’occhiata a riviste come Classe quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia, Primo Maggio, Metropoli, Quaderni del Territorio, Magazzino, ecc. può confermarlo. Quando però quei processi assumono ritmi vertiginosi e si impongono all’attenzione di tutti, se l’analisi resta abbastanza lucida, la capacità di muoversi con disinvoltura nel nuovo contesto viene progressivamente meno.
Ma l’indebolimento delle forze ancora libere di agire discende anche dall’incomprensione della nuova configurazione che la società sta assumendo. La sinistra rivoluzionaria, e in primo luogo quella di matrice operaista aveva a suo tempo dato scacco alla sinistra istituzionale analizzando e anticipando con enorme lucidità i processi di trasformazione che si stavano avviando: ristrutturazione industriale, diffusione a macchia d’olio del precariato, emergenza di un nuovo proletariato territoriale, e così via. Un’occhiata a riviste come Classe quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia, Primo Maggio, Metropoli, Quaderni del Territorio, Magazzino, ecc. può confermarlo. Quando però quei processi assumono ritmi vertiginosi e si impongono all’attenzione di tutti, se l’analisi resta abbastanza lucida, la capacità di muoversi con disinvoltura nel nuovo contesto viene progressivamente meno.
Vi è chi dà per liquidata la classe operaia e si rivolge in via esclusiva ai “nuovi soggetti sociali”, senza tener conto che questi ultimi hanno per forza di cose un grado più attenuato di autoconsapevolezza e non sono facilmente mobilitabili come un corpo unico; vi è, di converso, chi si aggrappa ad una centralità operaia che le cronache si incaricano quotidianamente di smentire, parlando linguaggi che già negli anni Sessanta cominciavano ad essere obsoleti; vi è chi continua a ripetere che “precario è bello”, quando il precariato che ha sotto gli occhi è frutto non di una scelta, ma di un’imposizione padronale; vi è chi parla ancora di “rifiuto del lavoro” senza preoccuparsi di precisare il significato dell’espressione, urtando nell’incomprensione di chi vede che è il padrone che gli rifiuta il lavoro.
Errori generosi e ampiamente giustificabili, che tuttavia denunciano un progressivo scollamento dal reale e un venir meno della capacità di rappresentarlo. Il terzo errore capitale della sinistra rivoluzionaria, negli anni in cui la repressione è ancora al culmine, è dunque quello di smarrire una visione lucida della propria matrice sociale, liquidando vecchi soggetti senza trovarne di nuovi, o abbarbicandosi a referenti che da tempo hanno smarrito ogni ruolo protagonistico. Il tutto nel contesto di azioni di lotta di breve respiro (micro-agitazioni studentesche, occupazioni di case, ecc.) che nella loro frammentarietà e sporadicità rivelano l’assenza di una benché minima proiezione progettuale, e che non hanno risonanza alcuna al di fuori dello spazio limitatissimo (scuola, quartiere) in cui hanno luogo.
La microconflittualità costituisce, infatti il quarto errore fondamentale della sinistra rivoluzionaria. Si inseguono momenti di scontro prescindendo totalmente dal loro valore strategico, dal loro potenziale di continuità, dalla loro capacità di contagio. L’occupazione di un vecchio immobile, indifferente a tutti salvo che al proprietario, viene spacciata come trionfo della lotta di classe; l’incendio di un cassonetto della spazzatura assurge al rango di guerriglia urbana; un modesta autoriduzione in una mensa universitaria diviene momento esaltante di illegalità di massa.
 Col tempo, anche queste pallide caricature degli espropri e delle ronde proletarie degli anni Settanta finiscono col rarefarsi e con lo scomparire quasi del tutto; sia per le repressioni che innescano, sproporzionate al pretesto, sia perché senza disegno politico forte che le sorregga tutte le forme di azione diretta non sono che materia per trafiletti nella cronaca locale. Ma chi si preoccupa più di manifestare una progettualità politica, quando si oscilla tra l’iperattivismo insensato e l’inazione, mentre la riflessione approfondita è delegata ai compagni in carcere o investe quasi esclusivamente il carcere?
Col tempo, anche queste pallide caricature degli espropri e delle ronde proletarie degli anni Settanta finiscono col rarefarsi e con lo scomparire quasi del tutto; sia per le repressioni che innescano, sproporzionate al pretesto, sia perché senza disegno politico forte che le sorregga tutte le forme di azione diretta non sono che materia per trafiletti nella cronaca locale. Ma chi si preoccupa più di manifestare una progettualità politica, quando si oscilla tra l’iperattivismo insensato e l’inazione, mentre la riflessione approfondita è delegata ai compagni in carcere o investe quasi esclusivamente il carcere?
E qui subentra il quinto errore capitale, vale a dire la scarsa cura per la propria immagine. Cortei sempre più striminziti lanciano slogan sempre più truculenti, nella speranza che facciano vibrare d’entusiasmo le masse derelitte e affamate. Si stenta a comprendere che parole d’ordine efficaci pochi anni prima risultano incomprensibili nel nuovo contesto socio- culturale, e servono solo ad isolare e ad annebbiare l’identità reale di chi continua a ritenerle veicolo per dimostrare di essere più a sinistra di chiunque altro.
Assai giustamente, negli anni di più dura repressione il movimento ha rifiutato di prendere le distanze dai partiti armati, ritenendoli comunque più vicini a se stesso dell’avversario di classe. Ma rifiutare di denigrare l’identità altrui, per quanto pericoloso e letale sia questo rifiuto dettato da coerenza politica ed umana, non può voler dire rinunciare ad affermare l’identità propria. Invece è questo che si finisce col fare, nell’illusione che una chiarezza predominante al proprio interno sia condivisa dall’intero corpo sociale. Il che significa trascurare il fatto che quest’ultimo è condizionato da forze che hanno tutto l’interesse ad alimentare la confusione e a fare il vuoto attorno agli antagonisti spacciandoli per “fiancheggiatori”.
Nella post-emergenza.
Alcuni degli errori citati vengono corretti man mano che ci si inoltra negli anni Ottanta. Ma il terreno perduto é molto ed è difficilmente riconquistabile, anche perché il potere è nel frattempo passato dalla pura repressione alla colonizzazione delle coscienze.
La sinistra di classe è stata drammaticamente ridimensionata, tanto che è sempre più difficile riferirsi a essa come a un “movimento”; le sue idee circolano poco e male, raggiungendo solo ambiti limitatissimi e per lo più privi di una spiccata fisionomia sociale; il reclutamento di nuovi militanti si è pressoché interrotto, e comunque non è tale da garantire un ricambio.
Dato che è il momento delle realtà frammentarie, isolate le une dalle altre o con contatti solo sporadici (salvo specifici spezzoni coordinati tra loro) non è più possibile individuare errori comuni a tutti. Esistono però comportamenti erronei abbastanza diffusi da poter essere indicati come caratteristici della fase, sebbene non manchi chi si sottrae ad essi e muove verso diverse prospettive.

Bologna, proteste in Piazza Verdi contro la privatizzazione all’interno della mensa universitaria. Foto di Luciano Nadalini
Il primo di questi comportamenti è l’auto-ghettizzazione. Il potere è riuscito a costringere la sinistra rivoluzionaria entro spazi limitatissimi e ben individuati, separandola con un cordone sanitario da buona parte della società circostante. Una tendenza negativa che si manifesta spesso è quella di adattarsi a vivere e a muoversi entro questi perimetri ristretti, non avendo occhi che per ciò che accade al loro interno e perdendo quindi la corretta percezione del reale.
Nascono modi di fare, di esprimersi, di agire indecifrabili per chiunque non sia interno al gruppo, al clan, alla tribù; l’attenzione rivolta al collettivo rivale supera quella dedicata alle forze concrete che agiscono nella società; ci si crogiola nella propria “diversità” senza accorgersi che attorno nessuno la nota.
L’esito peggiore che simile distorsione prospettica può avere è quello di illudersi di mantenere una dimensione politica, mentre si è solo un gruppo di amici o poco più. E come dei topi chiusi in una piccola gabbia finiscono col divorarsi a vicenda, così buona parte della propria aggressività viene rivolta verso chi sta più vicino, e distolta dall’avversario reale. I tentativi di incontro e di confronto della seconda metà degli anni Ottanta finiscono in risse e lacerazioni molto più spesso di quanto avvenisse nel passato decennio, quando la posta in gioco era ben maggiore e i motivi di divisione ben più concreti. Non ci si rende conto che uno sguardo proveniente dall’esterno del ghetto evidenzierebbe le similitudini ed attenuerebbe le differenziazioni. Se accade il contrario è solo perché si è incapaci di guardare oltre le pareti che il potere ha costruito perché il movimento antagonista vi restasse intrappolato.
In genere, anche chi ha ben chiare le dimensioni dell’emorragia subita tende a comportarsi come se nulla fosse stato; e vedendo che un simile atteggiamento non produce risultati, riduce pian piano le dimensioni e le ambizioni della propria militanza, fino a fare di nuclei un tempo combattivi altrettanti CRAL perfettamente adattati all’esistente e a cui manca solo il biliardo per consacrarli regni della noia.
Le puntate precedenti le trovate: 01 qui, 02 qui, 03 qui, 04 qui e 05 qui



