di Luca Baiada
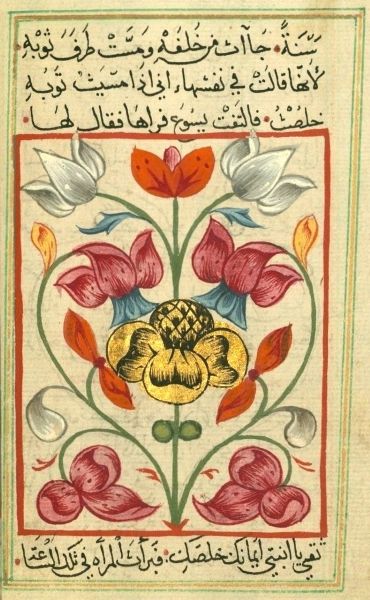 Da un’ampia fessura si staglia una lama di luce opaca, polverosa. Una luce che sembra palpabile. Arrivano rumori frammentati, taglienti come pietre spezzate, suoni grevi e umidi. Si mischiano a grida di gioia, a scrosci di pianti lontani.
Da un’ampia fessura si staglia una lama di luce opaca, polverosa. Una luce che sembra palpabile. Arrivano rumori frammentati, taglienti come pietre spezzate, suoni grevi e umidi. Si mischiano a grida di gioia, a scrosci di pianti lontani.
Lui è seduto su un basso sgabello, con la schiena appoggiata a un muro scrostato. Da un lato ha un cunicolo stretto che scende e si torce, davanti a sé un fagotto di qualcosa, accanto c’è un secchio col manico spezzato. Il pavimento è scuro, malmesso, impregnato di sporco e di grasso. Lei è appoggiata al muro opposto, i capelli raccolti sotto il velo, il viso giovanissimo. Ha le mani sotto un grembiule, composte. Lo guarda tesa:
– «Il momento è venuto. Non trovi le parole neanche tu? Sai, in fondo, non sono sicura che tu mi abbia mai detto cosa pensi. Voglio dire, cosa pensi di tutto questo. E di noi».
Lui si assesta appena, il corpo contratto. È avvolto in panni rimediati. I pantaloni, si vede che un tempo furono buoni. La camicia è fuori misura, sopra indossa brandelli di maglie da donna, cuciti insieme alla meglio.
– «La guardia vuole davvero fare conversazione col prigioniero?»
– «Smetti di fare lo stupido. Verranno a prenderti, dovrò darti in consegna. Non potrò accompagnarti. Se usciremo non dovremo salutarci; altrimenti ci saluteremo qui, senza vederci alla luce».
Da fuori viene il suono di un fischio secco. Lei:
– «Sono loro, stanno cominciando il giro, sanno che sei qui».
Si sente una voce, da fuori:
– «Controllo di sicurezza!»
Lei grida un numero, senza uscire. L’uomo seduto appoggiato al muro alza gli occhi e fa un vago sorriso:
– «Numeri, certo. Anche mio nonno era un numero. Lo sai, dove, vero?»
Lei lo guarda fisso:
– «Anche mio cugino, quello preso di notte a Jenin, ha avuto un numero, scritto sulla schiena. E un altro a Jabalya con gli arresti di massa, e altri ancora. Arrestati, processati quando c’è stato un processo; altrimenti galera senza giudizio. E botte e fame e sete. E molti non tornano. Numeri sulla schiena, sul polso, sui cartellini legati addosso, come al mercato del bestiame. E se vuoi continuare a fare i confronti, possono durare un altro anno».
– «E tutto il resto?»
Il viso di lei si schiarisce. Esita, poi la voce si fa accogliente:
– «Il resto è piaciuto a tutti e due. E il numero qui non è il tuo, è mio. Un sistema di controllo su ogni posto di custodia. Ma solo per i punti di transito, sono più vicini alle uscite; per questo prima non li sentivi: stavi giù. Un numero che varia, per precauzione. Ma non chiedermi con che sistema cambia. Non te lo direi neanche sotto tortura. E noi lo sappiamo, che sapete costringere a parlare. Come le chiamano, alla vostra corte suprema? Moderate pressioni, o cose del genere. Tutto legale. Ma la legalità, è la vostra».
– «Sì, le moderate pressioni. Ma quando ti piace farti premere, allora tu…»
– «Basta! Oggi, proprio oggi, vuoi essere volgare oppure sincero? Oggi per la prima volta?»
– «Sincero. Mi mancherai. So molto, non tutto. Voglio dire, di te. Mi ero abituato a vederti nel buio. Ma con una luce nella mente, nelle parole. Adesso basta quella di una fessura sul mondo, e di colpo sei più bella di prima».
– «Non c’è il mondo, là fuori, ci sono macerie coi cadaveri sotto. Li chiameremo eroi. Alcuni sono eroi davvero, altri…».
– «Altri? altri cosa?»
– «Altri non lo so. Ci sono persone della mia famiglia, sotto, e gli altri sono affamati e in fuga, chissà dove. E forse, viva o morta, là fuori c’è anche tua moglie».
L’uomo abbassa gli occhi, sembra che si guardi i piedi, avvolti in stracci e cuoio. Si alza stirandosi, si mostra in tutta la statura, più alto di lei. Le va incontro. Lei si irrigidisce:
– «Fermo!»
– «Hai paura, proprio ora che me ne vado?»
– «No. Puzzi più del solito. Sei peggio di un caprone».
Scoppiano a ridere. Fragorosi, come bambini. Si abbracciano forte, si tempestano di baci, a lei cade il velo, si infilano le dita nei capelli unti, l’uno con l’altra. Si stringono come se volessero fondersi, senza sentire il marcio unto e terroso intorno a loro. Lui scatta all’indietro:
– «Cos’hai lì?»
– «Ancora la pistola, lo sai. Sono le regole».
Lui torna a sedere. Al muro, come prima.
– «Mia moglie, sì. Te l’ho detto, bambini niente, voglio dire non ancora. Per il resto, non so. Sarei riuscito meglio a pensare, a riflettere, se avessi potuto scrivere».
– «Ho diviso con te quello che c’era da mangiare, se si può chiamare mangiare. Volevi anche carta e penna? O preferivi un laptop? Potevi mandare tutto a memoria, sai? Tanti di noi lo fanno, quando sono nelle vostre galere. Mandano a memoria anche i vostri nomi, quando parlate tra voi fra una tortura e l’altra».
– «Ci sono rabbini che mandano a memoria il Talmud, c’erano ebrei nei Lager che mandavano a memoria le loro poesie, le musiche. Nel ghetto di Varsavia…».
– «Zitto, viene qualcuno».
Un suono leggero e confuso fa cadere qualche pietra, si sente che si smuovono pezzetti di macerie, un po’ alla volta.
Lui, a bassa voce:
– «Potrebbe essere solo un gatto».
Lei, quasi impercettibile:
– «Che ridere. Credi che ce ne siano ancora? Secondo me abbiamo mangiato gli ultimi molto tempo fa!»
– «Per questo facevi le fusa, ogni volta che…?»
Trattengono a stento le risa. Fissi, gli occhi negli occhi, scintille ardenti nel chiaroscuro. Si bloccano quando una voce dura riempie la bruna penombra:
– «Nasrin! Mi mandano a dirti che è quasi ora! Lui vale più di cinquanta dei nostri. Deve arrivare intero. Fra poco ti mando Ruwaida. Si aspetta da te il nuovo numero di sicurezza».
Si sentono ancora passi, sempre più fiochi, intermittenti, sino a che scompaiono. Lei:
– «Guarda che quello non scherza. Quando sarai con lui, riga dritto».
Lui si alza, prende il secchio e ci guarda dentro:
– «Ma lo sai che quest’acqua è proprio uno schifo? Andrebbe appena bene per lavare stracci, e invece. Ma adesso basta. Lo vedi, però: sono così confuso che a parlare di noi non ci riesco».
– «Finalmente il prigioniero di gran prezzo parla come un uomo e non da guerriero. Il figlio del padrone balbetta davanti alla figlia della schiava?»
Da un lato viene una voce. A parlare è una donna tozza, quadrata, avvolta in vestiti scuri, che si stacca di colpo dal buio:
– «Nasrin, rimettiti il velo sui capelli!»
Lei si volta di scatto verso l’angolo morto e scuro, atterrita:
– «Ruwaida, da dove vieni fuori? Qui… è passato tuo marito. Sai che la consegna tocca a me, vero?»
– «So tutto. Conosco un altro passaggio, l’hanno aperto i bombardamenti tre mesi fa. E non mi serve il numero di sicurezza, vedi? Ti ho trovata, ti riconosco e ti vedo di persona. So tutto da tempo. Ho il doppio dei tuoi anni, ho figli grandi, cosa credevi di nascondermi, bambina? E quello, so anche chi è».
Nasrin vorrebbe spiegarsi, prova ad aprire bocca ma riesce solo a sorridere.
Ruwaida prosegue, impietrita, ma con voce tranquilla:
– «In famiglia ha almeno due poliziotti e un alto funzionario, che probabilmente è anche nel Mossad. Per questo l’avevano dato ad Ahmed, uno dei migliori. È morto troppo presto, Ahmed. È già un anno. E c’è stato bisogno di te. Il rischio era calcolato. Adesso te lo porteranno via, e di morte là fuori ce n’è abbastanza così. Anche se ho voglia di strozzarlo con le mie mani. Insomma, cosa sto a parlare? Salutatevi. Guarda che c’è poco tempo».
Nasrin stringe un po’ le spalle, ora ha un sorriso infinito:
– «Ruwaida, dobbiamo salutarci davanti a te? Sarò bambina, forse, ma lo sei stata anche tu. Prova a ricordarti cos’era, dai. Non puoi lasciarci soli?»
Ruwaida non si muove:
– «Ci sono metri e metri di macerie coi corpi dentro, sono sotto di noi e anche sopra. Invece la tua testa è piccola e vuota. Mi vuoi far entrare nei cunicoli per farti un favore? O vuoi che esca fuori senza di lui? Ci sarebbero sospetti, domande. Salutatevi e basta. Se proprio vuoi che non ascolti, ripeterò a voce bassa qualcosa di Abu Shawish. Lo sai che l’avevo conosciuto? Un altro martire. La poesia mi aiuterà a non sentire quanto sei sciocca».
Ruwaida si volta e comincia a recitare, scandendo convinta. Lui si avvicina a Nasrin, non riesce a togliere gli occhi da lei:
– «Tutto quello che ti ho detto, in questi giorni infiniti, in queste ore tremende e meravigliose, è tutto vero, tutto. Se hai sentito che c’erano polvere e grasso, sabbia e melma fra i nostri corpi, hai sbagliato. Per me erano stelle, stelle in fondo alla terra».
Nasrin:
– «La terra che è di tutti, quando ci si ama. E no, né sabbia né sporco ho sentito, solo il tuo corpo che era mio, mio da tenerlo per sempre, mio da essere sua senza fine. Se mai una donna ti dirà il suo amore, da domani in poi, credimi: non sarà mai come il mio. Io, custode sotterranea, che ti ho nutrito col mio poco pane e tutta me stessa».
I versi sulle labbra di Ruwaida si fanno più alti, più ritmici e densi. Lui mormora:
– «Ti ricordi, quel giorno? Le bombe cadevano vicinissime, e noi tremavamo insieme alla terra, al cemento che scricchiolava, alla polvere che vestiva la nostra pelle».
Nasrin:
– «Era solo polvere, per noi là sotto, e la polvere non uccide. Credevi che fosse giorno; invece là fuori era notte: le mie vicine di casa, le mie compagne di studi dormivano sopra, in quel che restava del palazzo, dentro tende di stracci e sacchetti di plastica. In una sola notte, proprio quella, ne morirono otto. Spero solo che si siano spente in un attimo, che non siano state sepolte vive per poi soffocare come topi impazziti. Non lo saprò mai. E sotto, nelle viscere della terra, sì, quella notte ti amavo».
Ruwaida continua a dire versi, ma adesso scuote il capo, digrigna i denti. Nasrin prende qualcosa da una nicchia, mette tutto nelle mani di lui:
– «I tuoi documenti, ciò che avevi addosso. L’orologio, beh, serviva a uno dei nostri. Il cellulare c’è ma senza scheda».
Si sente un lungo fischio, da fuori. Nasrin si irrigidisce:
– «Sono loro, è il momento che ho temuto di più. Devi andare, tornare a ciò che è tuo, a un destino che non conosciamo. Sai una cosa? Mi sarebbe piaciuto lasciarti almeno una fotografia. Insomma, dai, capisci? Una fotografia di me».
Lui si morde le labbra secche, si stringe le mani nelle mani, alza le spalle. Non sa dove guardare. Sibila:
– «Ce l’ho, adesso, la tua foto. Anche se non dovevo dirtelo».
– «Lo so che ce l’hai, anche se dovevo far finta di non saperlo. Ma volevo dire, insomma, non quella. Una vera. Una foto… una foto carina».
Ruwaida ha smesso, ora è in silenzio e resta voltata dall’altra parte, ferma come una rupe. Lui guarda sbigottito, prova a riflettere:
– «Quando l’hai saputo?»
– «Adesso sarebbe lungo da spiegare. Ma dovevi aspettartelo, che provassi a guardare. Pensi che in un cunicolo sottoterra una donna smetta di essere donna? Ho provato, ecco tutto, l’ho acceso e so cosa è successo».
Lui si scuote appena, la guarda timido:
– «È una funzione automatica, non potevo neanche disinstallarla. Se qualcuno prova a entrare senza password, il cellulare scatta una foto, senza flash e senza rumore, cattura l’immagine anche al buio e la conserva in memoria. Insomma, ci sei dentro tu, pare. Chissà che musino hai. La tua impronta, tutta per me: le guance di una cerbiatta ladruncola, gli occhioni golosi, due labbra sbigottite e le dita appiccicate sullo schermo. Sono le labbra che ho morso nella polvere, le dita di burro che conoscono il mio naso e il mio petto. Voglio vederti in quella foto, la guardiamo insieme subito?»
Fuori si sente un altro fischio, più lungo, imperioso. Lui si mette il cellulare sotto la camicia, velocemente, e fa due passi verso la fessura, verso il pulviscolo di luce opaca. Nasrin grida un numero e:
– «Sta per uscire!»
Ruwaida adesso si è voltata verso di loro, è vicina, nella mano scintilla il bagliore di una lama:
– «Resta dove sei! Ordini o non ordini, io ho perso due fratelli e una nuora, per colpa degli assassini furbi come te».
Di scatto, anche Nasrin si volta, ma verso di lei, e punta la pistola:
– «Anche noi bambine sappiamo sparare. Devi saperlo. Mi hai insegnato tu. Non muoverti, Ruwaida. Lui esce, io e te restiamo qui. E stai zitta. Zitta, capito?»
Ruwaida non si muove e abbassa la voce:
– «Sai cosa può costarti? Sai chi è mio marito, no?»
– «So che prima tocca a te. Il secondo colpo è per me. Ma lui è consegnato a Israele, vivo, e tanti dei nostri tornano. Due donne in meno, e si dirà che sono vittime, combattenti, non importa. Ma lui esce vivo».
Ruwaida lascia cadere il pugnale. Drizza la schiena, gonfia il petto. Lo sguardo è inchiodato su Nasrin ma non è di paura. Il viso ha una piega inesplicabile, che sembra guardare lontano.
Adesso i due si baciano, tremano come foglie, le loro mani si sfiorano, vogliono sciogliersi insieme. Sono mani col solo dorso, ora, un dorso fatto ruvido dalla polvere e dallo sporco, mani unite, dita intrecciate, calde come l’ombra e segrete come notti senza numero e senza mai giorno. Poi si staccano. Lui esce, sparisce in un attimo in quella luce densa, che vista da dentro sembra un irreale bagliore.
Nasrin ha il viso segnato da lacrime così grosse e unte che le rigano il volto come insetti. Guarda Ruwaida e sente fino nelle ossa un terrore di ghiaccio. La sua ora è arrivata.
Invece Ruwaida sorride:
– «L’avresti fatto davvero?»
Nasrin è confusa:
– «Sì, perdonami».
Ruwaida si china, lentamente, da donna forte e matura. Poi si rialza:
– «Beh, questo è tempo di riprenderlo, è affilato e fa male. Non come la pistola che hai in mano. Ti ho insegnato a sparare, sì, bambina. Ma l’arma, poi, te l’ho data con le munizioni che non funzionano. Di quelle buone, che te ne facevi? Poteva disarmarti, tentare qualcosa. Ma sapeva che non sarebbe riuscito a tornare su, senza di te. Comunque fuori ci siamo noi, oppure le bombe dei suoi che gettano morte su tutto, senza distinguere. Solo a casa mia, sono quattro».
– «Due fratelli e tua nuora, lo so. Ma…?»
La donna freme, si increspa e si gonfia come un’onda, la voce diventa un cupo ruggito:
– «Mia nuora era al sesto mese. A volte stare nei cunicoli serve a non vedere il peggio. Troppe cose, non sai, troppe. Lo sai che loro sono morti quasi tutti sotto le loro bombe?»
Nasrin ascolta appena. Assorta, punta la pistola verso il pavimento. Si sente solo lo scatto misero del percussore:
– «Ruwaida, adesso non ci capisco più niente».
Ruwaida mette via il pugnale, il suo abito lo ingoia come un oggetto qualsiasi. Ora si sistema le pieghe, tranquilla:
– «Mi sei piaciuta. Chi è capace di scegliere, di rischiare, sa anche ubbidire davvero, sino in fondo. Penso che mio marito ti proporrà per un nuovo incarico».
Lo stesso giorno, l’uomo sale sul pulmino israeliano. Dopo un saluto e qualche domanda gli chiedono il cellulare, per mandare a Tel Aviv le immagini che ha scattato automaticamente dentro i nascondigli, nei cunicoli, nelle celle rimediate. Vogliono i volti dei carcerieri, dei combattenti, dei fiancheggiatori e dei familiari, uno per uno. Anche le donne, anche i bambini, tutti. Un giorno, non si sa quando: occhio per occhio, dente per dente. E subito, ogni volto serve per i sistemi di controllo: dispositivi integrati fatti di dati, tecnologie di riconoscimento, rilevazione aerea, che usando l’intelligenza artificiale conformano la vita e impartiscono la morte. Lui dice di non averlo, il cellulare, ed è vero. Dice che non gli è stato restituito, e questo no, non è vero. Durante il trasferimento, prima di essere consegnato, l’ha fatto scivolare fra le pietre del sentiero, uno dei mille sentieri che solcano il mare di macerie che un tempo fu Gaza.
Un giorno, fra le rovine spazzate via per fare di Gaza non si sa cosa, anche un cellulare sarà tritato; osceno rifiuto, come ciò che resta dei corpi. Dentro c’è un viso vispo, curioso; il viso di una ragazza palestinese che vuole affacciarsi sul mondo di un uomo, vuole rubargli il cuore e donargliene due, vuole restare uniti per sempre. E dentro, c’è anche un messaggio registrato da lui, a voce bassa, prima di lasciarlo cadere dalla camicia. Parole d’amore che qui lasciamo sepolte, parole distillate dal buio e dai sensi, un anno sottoterra, e che solo così, da quelle tenebre, volano via.



