di Luca Cangianti
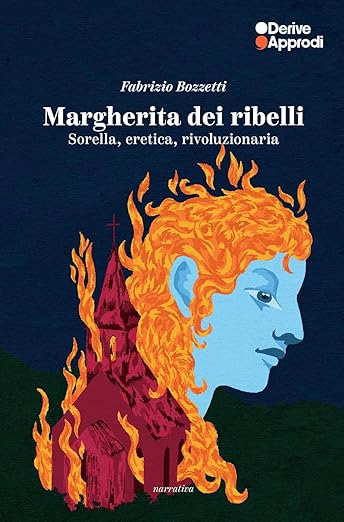 Fabrizio Bozzetti, Margherita dei ribelli. Sorella, eretica, rivoluzionaria, DeriveApprodi, 2025, pp. 416, € 20,00.
Fabrizio Bozzetti, Margherita dei ribelli. Sorella, eretica, rivoluzionaria, DeriveApprodi, 2025, pp. 416, € 20,00.
Valerio Evangelisti ci ha fatto conoscere contropelo le forze femminili, lunari ed eretiche della ribellione attraverso gli occhi della reazione, dell’inquisitore Eymerich. Fabrizio Bozzetti con il romanzo Margherita dei ribelli compie la stessa operazione, ma usa direttamente lo sguardo di un’insubordinata: Margherita Boninsegna di Trento, una giovane nobile segnata dal tradimento del fratello che l’ha rinchiusa in convento per aver rifiutato un matrimonio indesiderato. Questa ferita la disallinea rispetto al mondo ordinario dei primi anni del XIV secolo. Come si presenta l’occasione fugge insieme a un’altra donna, conoscitrice di erbe e seguace di Dolcino, il capo di un gruppo di ribelli che rivendica il ritorno al cristianesimo delle origini: rifiuto dell’opulenza ecclesiastica, condivisione dei beni, uguaglianza di genere e libertà sessuale.
Come nella migliore fiction storica i rimandi all’attualità politica sono molti, ben integrati nel mondo narrativo, ma anche piacevolmente individuabili: «L’unica colpa di Dolcino e di chi lo ama è aver lottato per un mondo migliore, di liberi ed eguali, padroni di niente e servi di nessuno!», grida Margherita in faccia al nemico. Nella sua voce riecheggia sia la parabola evangelica (Luca 17,7-10), sia lo slogan dello spezzone anarchico nelle giornate di Genova 2001: «Padroni di niente, servi di nessuno, all’arrembaggio del futuro!». E ancora: in uno dei blocchi in corsivo, che marcano l’introspezione della protagonista, leggiamo: «Ora intravedo il balenare di ciò che i maschi temono in noi, il grande potere dello spirito selvaggio che dentro ciascuna grida altissimo e feroce.» Uno degli slogan più popolari nei cortei femministi degli ultimi anni è stato appunto: «Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce».
Margherita dei ribelli è molte cose insieme: romanzo storico, di formazione, d’introspezione, d’amore e di critica politica. È attentamente ambientato nel medioevo e incastona la finzione senza attrito con le vicende reali. Narra della graduale presa di coscienza di una ragazza che incontra il mondo deviante dei ribelli, prima incomprensibile e respingente, poi via via affascinante. È la storia di due anime ferite, quelle di Margherita e di Dolcino, che si scontrano, si conoscono, si amano e si armano per affermare un ideale di giustizia. Per tutti questi motivi il romanzo di Bozzetti è un racconto d’azione, di tradimenti, di violenze efferate, di vittorie parziali e di sconfitte umilianti. Come qualsiasi grande vicenda umana, del resto. Allo stesso tempo, nel corso delle vicende, emerge con forza la convinzione (anche questa centrale nella poetica di Evangelisti) che insorgere contro l’ingiustizia, al di là degli esiti, non sia mai inutile. Anche in caso di sconfitta le gesta dei ribelli serviranno d’ispirazione alle future generazioni. È per questo che, passati più di sette secoli, Margherita e Dolcino parlano ancora al nostro cuore.



