di Gioacchino Toni
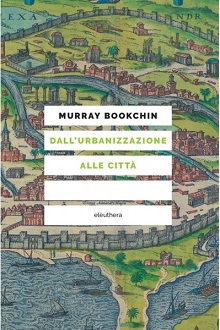 Murray Bookchin, Dall’urbanizzazione alle città, traduzione di Elena Cantoni, elèuthera, Milano, 2023, pp. 392, € 24,00
Murray Bookchin, Dall’urbanizzazione alle città, traduzione di Elena Cantoni, elèuthera, Milano, 2023, pp. 392, € 24,00
Uscito originariamente nel 1987 con il titolo The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship, divenuto nell’edizione del 1992 Urbanization Without Cities per poi, nel 1995, ampliato, assumere il titolo attuale, From Urbanization to Cities. The Politics of Democratic Municipalism, lungi dall’essere una riflessione sulla pianificazione urbanistica o una critica della vita urbana, il volume di Murray Bookchin intende piuttosto formulare una politica municipalista confederale volta a estendere l’autodeterminazione del cittadino attraverso confederazioni di villaggi, borghi e città in contrapposizione allo Stato-nazione.
A differenza di chi, nel denunciare lo svilimento del ruolo del cittadino nella società contemporanea, ha finito col limitarsi a proporre “soluzioni adattative”, la proposta dell’anarchico Bookchin non si rifà all’idea di conquista del potere statuale da parte di un’élite illuminata agente in nome della collettività, bensì mira a un’estensione delle forme di democrazia partecipativa.
Il volume ricostruisce la storia della città intendendola non come ambito di scambio capitalista e di gratificazione individuale, ma come luogo di una politica democratica partecipata. Così come gli ecosistemi si basano sulla partecipazione e sul mutualismo, altrettanto le città, e chi le abita, devono, secondo l’autore, riscoprire tali qualità, stabilendo relazioni sociali armoniose ed etiche.
Il municipalismo democratico rappresenta dunque una filosofia emancipatrice fondata su principi di autodeterminazione, in cui la politica diventa agire quotidiano in cui le comunità locali assumono nelle proprie mani il potere decisionale. Dalla Comune di Parigi alla rivoluzione curda nel nord-est siriano, il municipalismo democratico si configura come strumento utile a sottrarre potere allo Stato-nazione proponendosi di sostituire alla logica dell’urbanizzazione capitalista quella di una società fondata su principi solidaristici, ecologici ed egualitari.
Al fine di recuperare la politica, la cittadinanza e la democrazia, secondo l’autore, occorre guardare alla città come a un’arena pubblica in cui confrontarsi e discutere di affari pubblici, delle modalità con cui migliorare la vita degli individui in quanto esseri civici.
Nelle sue forme iniziali, la città fu l’arena par excellence per riconfigurare i rapporti umani, passando dalle aggregazioni basate su caratteri biologici, come la parentela, ad altre basate su dati prettamente sociali, come la prossimità abitativa; per l’emersione di forme istituzionali progressivamente più secolari; per il rapido proliferare di relazioni culturali spesso innovative; e per l’universalizzazione di attività economiche precedentemente legate all’età, al genere e alle distinzioni etniche. In breve, la città è stata l’arena storica in cui non casualmente le affinità biologiche si sono trasformate in affinità sociali, rendendola il singolo fattore più rilevante per trasformare un popolo etnicamente determinato in un corpo secolare di cittadini, una tribù campanilista in una civitas universale in cui, con il tempo, lo «straniero» e l’«outsider» potevano diventare membri della comunità senza dover comprovare alcun legame di sangue, reale o mitico, con un antenato comune. Così, non solo i rapporti politici hanno rimpiazzato le parentele, ma il concetto di humanitas condivisa ha rimpiazzato l’esclusività del clan e della tribù, le cui pretese biosociali di essere «il popolo» avevano spesso escluso l’«outsider» configurandolo come «Altro» disorganico, esogeno e spesso minaccioso. La città è stata dunque, storicamente, il luogo in cui sono emersi concetti universalistici come quello di «umanità», e tuttora ha il potenziale di diventare il luogo in cui riaffermare i concetti di autogestione politica e cittadinanza, in cui rielaborare nuovi rapporti sociali e una nuova cultura civica. I passi che hanno condotto dal clan di consanguinei, dalla tribù e dal villaggio alla polis, o città politica; dai fratelli e dalle sorelle di sangue, che acquisivano le proprie prerogative per nascita, a cittadini almeno idealmente liberi di decidere quali responsabilità civiche attribuirsi e quali affinità privilegiare sulla base della propria ragione e dei propri interessi secolari – ebbene, tutti questi passi costituiscono una valida definizione di città (pp. 17-18).
Bookchin analizza l’evoluzione delle città intesa come manifestazione di vita comunitaria, umana, etica ed ecologica che ha saputo valorizzare e potenziare l’individualità dando vita a forme istituite di libertà, individuandone quegli elementi di comunalismo autentico che possono essere recuperati e riformulati.
Lasciare che i grandi attributi civici languiscano nel passato, mentre i «futuristi» cibernetici e postmoderni proiettano l’irrazionalità del presente sul secolo a venire, equivarrebbe a permettere che l’ideale di una società razionale – quella che i grandi rivoluzionari di fine XIX e di inizio XX secolo chiamavano la «Comune delle Comuni» – sparisca dalla memoria delle generazioni future (p. 19).
Non si tratta, sottolinea l’autore, di mitizzare un passato in realtà segnato da vizi, limiti e ingiustizie ma, piuttosto, di riprendere «il concetto ellenico e medievale di città come unione etica di cittadini», guardando alla cittadinanza come a «un processo che comporta la trasformazione sociale e individuale delle persone in partecipanti attivi nella gestione della comunità» (p. 21). Guardare agli esempi del passato non significa dunque individuare modelli ideali da cui attingere acriticamente e astoricamente ma, piuttosto, andare alla ricerca di ciò che di innovativo è stato prodotto in termini di partecipazione attiva e diretta degli individui e delle ragioni dei loro fallimenti o dei loro superamenti in direzione opposta.
È importante distinguere il sociale umano dal politico e, come passaggio successivo, il politico dallo statuale. Abbiamo fatto un tremendo pasticcio confondendo le tre cose, e dunque legittimandone una in virtù della mescolanza con l’altra. Questa confusione ha gravi implicazioni per il presente e per il futuro. Abbiamo perso il senso di cosa significhi essere soggetti politici, demandandone le funzioni e le prerogative ai «politici», di fatto un gruppo selezionato e spesso elitario di persone che esercitano una forma di manipolazione istituzionale detta arte di governo. […] In modo analogo abbiamo perso il senso di cosa significhi essere un cittadino, uno status sempre più ridotto a quello di un mero «elettore» e «contribuente» che riceve passivamente i beni e i servizi erogati da uno Stato onnipotente e dai nostri rappresentanti eletti (p. 309).
Per arginare il rischio di una concentrazione di potere nelle mani di strutture che pretendono di operare in nome della collettività, vanificando nei fatti qualsiasi prospettiva di democrazia diretta, è indispensabile, sostiene Bookchin, incentivare forme di educazione municipale fondate sul faccia-a-faccia, sull’interazione personale, sul confronto concreto, così da promuove lo svilupparsi di una reale democrazia diretta. Dunque la necessità di partire dai piccoli gruppi, dalle associazioni di isolato, dai quartieri per dare vita a pratiche consapevoli che non possono essere facilmente bypassate da qualche istanza avanguardista incline ad arrogarsi il diritto di decidere in nome della collettività.
La cellula vitale che costituisce l’unità di base della vita politica non può che essere la municipalità, da cui tutto discende: dalla cittadinanza all’interdipendenza, dal confederalismo alla libertà. L’unico modo per dare concretezza alla politica è partire dalle sue forme più elementari: i villaggi, le cittadine, i quartieri e le città in cui le persone sperimentano, al di là della sfera privata, il livello più intimo di interdipendenza politica. È a questo livello che possono cominciare a familiarizzarsi con il processo politico, che comporta ben più del semplice gesto di informarsi e andare a votare. Ed è a questo livello che possono uscire dall’insularità della vita familiare – al momento celebrata proprio per la sua introiezione e il suo isolamento – e predisporre quelle istituzioni pubbliche che rendono possibile una vasta partecipazione e consociazione della comunità (p. 366).
Non si tratta, sottolinea più volte Bookchin, di far sparire la città, tanto meno di accettarla per quello che è, ma di «dotarla di un nuovo senso, di una nuova politica, di una nuova direzione, e offrire nuovi ideali di cittadinanza, molti dei quali in larga parte già realizzati nel passato», così che, dal basso, si possa costruire, insieme, «una nuova politica, capace di combinare gli alti ideali della cittadinanza partecipativa al riconoscimento di ciò che la città può diventare nel contesto di una società razionale, libera ed ecologica» (p. 25).
L’auspicio di tale prospettiva non è di certo bastevole al suo realizzarsi, le cose, ricorda l’autore, possono andare diversamente; può essere che
in futuro l’urbanizzazione abbia così completamente divorato la città e la campagna che la comunità sia ormai diventata un arcaismo; che la società di mercato si sia infiltrata in modo così pervasivo nei recessi più profondi delle nostre vite private da cancellare ogni senso di personalità, figurarsi di individualità; che lo Stato abbia ridotto non solo la politica e la cittadinanza a parodie di sé stesse ma che le sue fauci abbiano inghiottito persino l’idea di libertà (p. 372).
Alla luce della destrutturazione del mondo naturale che si aggiunge a quella del mondo sociale, «il recupero del concetto classico di politica e cittadinanza non è soltanto la precondizione di una società libera: è la precondizione della nostra sopravvivenza come specie» (p. 372).



