di Armando Lancellotti
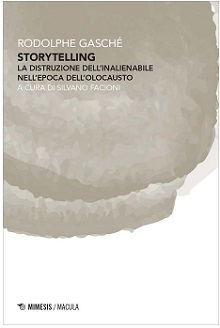 Rodolphe Gasché, Storytelling. La distruzione dell’inalienabile nell’epoca dell’Olocausto, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2023, pp. 146, € 14,00
Rodolphe Gasché, Storytelling. La distruzione dell’inalienabile nell’epoca dell’Olocausto, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2023, pp. 146, € 14,00
Perché molti dei sopravvissuti alla Shoah dai campi di internamento e di sterminio sono tornati “muti”, incapaci cioè di raccontare le loro storie, impossibilitati a farlo dall’insensatezza assoluta dell’orrore che hanno osservato e subito?
Se la (non)vita nel lager zittisce ogni parola, spegne l’immaginazione ed ottunde qualsiasi altra facoltà della mente, non è allora proprio questa l’esperienza più disumanizzante ed alienante che l’uomo abbia mai conosciuto, poiché gli sottrae la qualità che più lo contraddistingue, ossia la capacità di raccontare, di trovare e dare senso alle cose attraverso lo strumento della parola e nella forma del racconto?
Intorno a queste domande si sviluppa il discorso del filosofo lussemburghese e docente della State University di New York, Rodolphe Gasché, che cerca possibili risposte negli scritti di Wilhelm Schapp, Walter Benjamin e Hanna Arendt.
Risalendo all’origine stessa della filosofia, Gasché ricorda come il logos abbia preso forma, per progressivo distanziamento, dal mito, ossia dalla modalità narrativa di descrizione e spiegazione della realtà. La filosofia «quando è fedele al suo gesto fondatore, consiste nel non raccontare storie» (p. 11). Ma in realtà la relazione tra logos o filosofia, da un lato, mito o narrazione, dall’altro, è molto più complessa già in Platone: più volte il mito, nei dialoghi platonici, va in soccorso al logos, lo sostiene, lo compendia e talvolta lo oltrepassa per la superiore capacità di cogliere in maniera diretta la verità. Il logos non esclude il racconto e la decisione della filosofia di non raccontare storie presuppone la possibilità di farlo, così come il silenzio – a differenza del mutismo – presuppone la possibilità di parlare.
Ma vi sono casi in cui l’interdizione di raccontare storie non è dovuta, come per la filosofia, alla scelta di ricorrere ad altre modalità di spiegazione della realtà, ma al fatto che alcune cose, vicende o esperienze non possiedono il requisito necessario affinché possano essere raccontate, cioè la qualità dell’intelligibilità e di conseguenza si sottraggono alla possibilità stessa dell’atto narrativo, inducendo chi le ha vissute al mutismo, all’azzeramento della possibilità di parlare.
«Il mutismo non è il silenzio. […] Il silenzio presuppone la possibilità di parlare» (p. 14); sta in silenzio chi potrebbe parlare. In sostanza, il silenzio è complementare alla parola e non la esclude affatto. Ben diverso è il mutismo cioè l’incapacità di parlare, il venir meno della possibilità del ricorso al linguaggio, dovuto ad eventi impronunciabili, indicibili, per la loro traumatica violenza.
Gasché distingue – forse in maniera un po’ troppo rigida e schematica, soprattutto in riferimento agli internati sopravvissuti dei lager – tra tre diverse modalità di parlare: informare, testimoniare, raccontare e associa il fornire informazioni al lavoro storico-archivistico, la testimonianza all’iniziativa di ricostruzione dei fatti, per esempio in una prospettiva giuridica e il raccontare una storia all’azione propriamente umana del trovare e dare senso alle cose e alle esperienze vissute, che nella rielaborazione attraverso la parola assumono un senso e divengono intelligibili.
Ma è proprio questo terzo ed ultimo uso della parola che è spesso impossibile per i sopravvissuti alla Shoah, relegati in una condizione di mutismo, che sottrae a loro la possibilità di raccontare, di fare della loro esperienza una storia e questo perché ciò che hanno vissuto manca del requisito necessario ad ogni racconto, manca di senso e di intelligibilità.
L’autore insiste particolarmente su questo aspetto della soluzione finale – l’assenza di senso – e lo fa per esempio sulla scorta delle riflessioni della Arendt: i campi di sterminio non furono solo luoghi in cui violenza e brutalità si scatenarono senza freni, ma furono anche e soprattutto territori del non-senso. Dal punto di vista economico e militare risultarono addirittura controproducenti ed inadeguati al fine della vittoria della guerra, pertanto un qualcosa di a-razionale, un’insensatezza fine a se stessa. E allora, se la storia è una forma del discorso «in cui gli eventi si intrecciano in modo da diventare significativi, la storia dell’evento in questione non può essere raccontata» (p. 18).
Auschwitz rimane pertanto un’aporia della civiltà occidentale e proprio la sua aporetica assenza di senso fa di esso un abominio diverso da tutti gli altri ed imparagonabile. Ciò non significa – osserva Gasché – rinunciare al tentativo e allo sforzo razionali della comprensione anche dell’incomprensibile o concepirla come possibile solo per un Dio capace di includere l’orrore in un ordine di senso sovrannaturale, bensì significa riconoscere che «la natura dell’evento chiamato Auschwitz è tale da distruggere ogni senso che potrebbe essergli attribuito» (p. 22). Ricorrendo alla distinzione tra Sinn (senso) e Bedeutung (significato, riferimento), Gasché sostiene che sia impossibile dare un senso (Sinn) ad Auschwitz, nonostante il suo evidente significato (Bedeutung) fosse il progetto di sterminio di un intero popolo. Malgrado l’insieme dei suoi significati o riferimenti sia chiaro, il senso di ciò che condensiamo con la parola Auschwitz sembra consistere nella inintelligibilità della sua insensatezza, che «inocula mutismo nelle sue vittime» (p. 24).
È come se nei sopravvissuti la facoltà dell’immaginazione si paralizzasse dinanzi all’orrore e non fosse più in grado di svolgere il compito che Kant le attribuiva, quello di sintetizzare la molteplicità sensibile dei fenomeni, attribuendole un senso concettuale. «Un’immaginazione terrorizzata dall’enormità dell’orrore insensato è un’immaginazione che condanna al silenzio, o meglio al mutismo, tutte le altre facoltà della mente» (p.27).
Il raccontare storie è una forma del discorso che conferisce senso alle cose e consente a chi le ascolta di trovarvi un indirizzo da seguire, un consiglio, un modello; insomma una storia ha anche una funzione etica. Ma la Shoah, l’evento più traumatico per la civiltà occidentale, ha condotto – dice Gasché – «alla bancarotta dell’etica. Infatti, che una cosa del genere sia stata possibile ha modificato per sempre i fondamenti – metafisici, umanistici e teologici – su cui si è basata almeno l’etica occidentale» (p. 29).
I termini utilizzati per nominare la soluzione finale, come Olocausto o Shoah, al di là delle eccezioni che si possono sollevare sulla loro pertinenza, in qualche modo tentano di dare un senso all’insensatezza, associando una parola a ciò che è propriamente indicibile. Rifacendosi ai termini della lingua tedesca, Gasché considera appropriato usare la parola Erlebnis (vissuto) per indicare ciò che le vittime hanno subito nei campi e non Erfahrung, che sta ad indicare un’esperienza dotata di un senso. Erlebnis, cioè un vissuto che non può essere comunicato attraverso quella figura di senso che è un racconto, perché propriamente non è neppure un’esperienza (Erfharung).
Il mutismo dei sopravvissuti alla soluzione finale trova un’anticipazione storica nell’analogo fenomeno accaduto ai soldati della Grande Guerra. Le atrocità subite e vissute azzerano la forza di quella facoltà umana che dovrebbe essere inalienabile, cioè la capacità di comunicare e scambiare esperienze, di raccontare le proprie storie. Il fenomeno dell’alienazione dell’inalienabile, nel caso della Shoah, è amplificato ed elevato a potenza dal fatto che si tratta di un effetto pianificato, programmato e perseguito dai carnefici, che predispongono ed attuano ogni possibile forma di disumanizzazione della vittima.
Facendo leva sulle testimonianze di Tadeusz Borowski e Primo Levi, Gasché osserva come i prigionieri dei lager appena possibile trascorressero il tempo raccontandosi e scambiandosi storie, «semplici ed incomprensibili» – dice Levi in Se questo è un uomo – «come le storie della Bibbia» (p. 38). Questa frenetica attività di narrazione è da leggersi come un modo per attaccarsi alla vita, per rimanere umani, continuando ostinatamente a dare senso alle cose attraverso il racconto, proprio laddove e quando l’umanità veniva negata e ridotta a mera e cruda vita organica.
Al di là delle cause socioculturali (il senso di colpa e di vergogna dei sopravvissuti, che li induce al silenzio; la paura di alimentare, attraverso la testimonianza, ulteriore odio antisemita) o delle motivazioni psichiatriche (il trauma subito e il disturbo psichico conseguente), secondo Gasché il fenomeno del “mutismo” delle vittime della Shoah richiede di essere spiegato con un approccio più universale e generale, cioè filosofico e da questo punto di vista esso è interpretabile come l’effetto dell’alienazione della capacità umana di creare storie, di condividere la propria storia e se stessi raccontandosi, di costruire un’autocoscienza attraverso le proprie storie.
In conclusione, se la soluzione finale non si fosse interrotta a seguito della sconfitta della Germania, l’intero popolo ebraico – riflette Gasché – sarebbe andato incontro all’estinzione, alla cancellazione totale, di esso non sarebbe rimasta traccia o memoria alcuna per un possibile racconto; sarebbe avvenuta in maniera assoluta ed irreversibile la dissociazione definitiva tra quel popolo e la parola, la narrazione.



