di Sandro Moiso
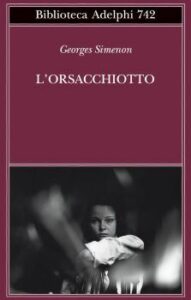 Georges Simenon, L’orsacchiotto, Adelphi Edizioni, Milano 2023, pp. 147, € 18,00
Georges Simenon, L’orsacchiotto, Adelphi Edizioni, Milano 2023, pp. 147, € 18,00
“Sarebbe stato un errore, però, sostenere che la sua segretaria avesse preso il posto di sua moglie. Non aveva preso il posto di nessuno. Aveva riempito un vuoto. Quanto alla causa di quel vuoto…” (L’orsachiotto, G. Simenon)
Prosegue, con l’uscita di questo romanzo, la pubblicazione da parte delle edizioni Adelphi dell’opera integrale di Georges Simenon (1903-1989). Autore sicuramente tra i più importanti del ‘900 di lingua francese che troppo spesso, grazie ad una critica abituata a ragionare per generi e sottogeneri, è stato ricordato e/o celebrato soltanto per i 75 romanzi e i 28 racconti (scritti e pubblicati tra il 1931 e il 1972) che vedono come protagonista il celebre commissario Jules Maigret.
In realtà Simenon, autore tra i più prolifici, ha scritto, spesso utilizzando numerosi e svariati pseudonimi per poter pubblicare in contemporanea presso differenti editori, centinaia di romanzi e racconti che fuoriescono dal ciclo del commissario francese. Romanzi che spaziano tra storie d’ambiente piccolo borghese, se non proletario, e altre ambientate tra la ricca borghesia, sia della ville lumière che della provincia profonda della Francia del XX secolo. Con qualche deviazione spaziale verso il Belgio, in cui Simenon era nato, e altre parti del mondo.
Storie che, come vedremo anche a proposito del romanzo qui recensito, sono ascrivibili nella maggioranza dei casi al noir più classico, senza per forza con ciò voler definire un genere specifico di appartenenza. Piuttosto l’uso del termine serve, in questo caso, a delineare un ambiente psicologico e morale, prima ancora che sociale.
Tanto si è dibattuto nel corso degli ultimi decenni sulla sostituzione del romanzo realistico e sociale avvenuta per mezzo dei romanzi noir, ma anche se ciò è sicuramente vero, è vero altrettanto che non per questo i romanzi dall’anima nera debbano per forza descrivere ambienti sociali degradati economicamente (le periferie delle metropoli o la Marsiglia di Jean-Claude Izzo ad esempio) o le perverse trame del potere politico ed economico (come avviene nei romanzi di Dominique Manotti o Massimo Carlotto) oppure, ancora, gli ambienti e gli affari della “mala” (descritti puntualmente da André Héléna, Léo Malet o Auguste Le Breton).
Simenon ci guida a comprendere che il male del noir pur essendo, come del resto tutto, un prodotto sociale, può annidarsi ovunque. Come capita in questo romanzo, pubblicato originariamente nel 1960, che narra le vicende e l’inverno dello scontento di Jean Chabot: ginecologo di fama, comproprietario di una clinica per puerpere benestanti e responsabile della Maternità di Port-Royal, un appartamento di dodici stanze al Bois de Boulogne, una moglie, tre figli e una segretaria-amante, Viviane, che si è assunta il compito di «evitargli ogni minima seccatura».
Eppure, eppure…
Lo scontento e l’amarezza sono filtrati nella sua vita. Un goccio alla volta oppure per vaste crepe che sono andate aprendosi sempre più nel suo animo, soprattutto dopo l’aver appreso della morte per suicidio di una giovanissima inserviente della clinica, “l’orsacchiotto” del titolo, di cui lui aveva approfittato sessualmente diverse volte durante i lunghi turni di notte nella stessa, tra l’urgenza di un parto e quello successivo.
Ma non è un rimestamento morale legato al senso di colpa quello che accompagnerà il protagonista fino alle ultime, drammatiche pagine delle vicende narrate. No, sarebbe troppo semplice, soprattutto per un autore come Simenon, attento osservatore dei vizi privati e pubblici, altrui e propri.
Al massimo la scomparsa della giovane affogatasi nella Senna, dopo aver saputo di essere incinta e dopo esser stata cacciata dalla stessa clinica rimanendo senza lavoro, può costituire per Chabot una lieve riverniciatura di moralità e un blando senso di colpa destinati a mascherare il ben più profondo malessere che si annida nell’animo di un uomo che pur si è autenticamente fatto da sé.
E non costituisce un vero problema nemmeno l’enigmatica figura di un giovane, probabilmente coetaneo, fratello o amante, della giovane suicida, che perseguita il professore lasciando sul parabrezza della sua automobile dei biglietti sgrammaticati su cui sono scritte, solo e sempre, tre parole: «Io ti uciderò».
No, la vendetta dal basso non può preoccupare e non può spaventare un uomo che si sente morto da tempo. In cui anche i rapporti sessuali sono vissuti come compulsivi, destinati soltanto a riempire un vuoto esistenziale incolmabile.
Aveva preso dei farmaci. Li aveva provati tutti. Aveva persino cercato di distrarsi facendo sesso in modo compulsivo, e per un certo periodo non aveva fatto che andare a donne, approfittando di infermiere compiacenti, e due o tre volte di pazienti che si offrivano, il che gli aveva complicato l’esistenza. Questo era durato fino a Viviane e ogni tanto, se andava in crisi, ci ricascava1.
Vi è indubbiamente molto dell’autore, come per ogni scrittore che meriti davvero questo appellativo, nella figura di Chabot e, forse, proprio per questo Simenon riesce a portarci al cuore di ogni scontento, di ogni male, alla causa ultima di ogni azione registrata in un noir. Il vuoto dell’alienazione che scorre sul fondo della psiche, in maniera conscia o non conscia non importa ai fini dell’analisi ultima, di ogni individuo, maschio o femmina che sia. Insomma, parafrasando insieme Hannah Arendt e Raoul Vaneigem, “la quotidianità e la banalità del male”.
Alienazione che è sicuramente sociale e che è più profonda di qualsiasi semplice causa economica o politica. Nelle pagine dell’autore belga, così come in tutto questo romanzo, la separazione dell’individuo da se stesso e dalla sua vita, o da quella che egli riterrebbe dover esser tale, è totale.
Ed è totale proprio perché il protagonista, ma insieme a lui qualsiasi altro membro, grande o piccolo, del milieu cui appartiene, tutto sommato non sa con sicurezza cosa sia la sua “vera” vita e, soprattutto, cosa davvero vorrebbe al posto di ciò che già ha, o non ha.
Chabot stava dunque fingendo? Il proprio viso lo affascinava. Continuando a guardarsi, levò il bicchiere e lo vuotò d’un fiato, con una smorfia sulle labbra.
Poi, tanto per vedere, per rendersi conto, lentamente tirò fuori di tasca la pistola, più lentamente ancora ne portò la canna alla tempia, l’appoggiò come si appoggia la lingua su un dente che duole.
Evitò di toccare il grilletto. Non aveva intenzione di sparare. Voleva solo fare una prova e, adesso che aveva fatto il gesto, credeva di sapere. Meglio non continuare, non indugiare lì nello studio; l’immagine successiva era il «dopo», con il suo corpo sul pavimento.
Rimise l’arma in tasca, la bottiglia nell’armadio e andò a prendere cappello e cappotto nel guardaroba. In boulevard de Courcelles non si cenava prima delle nove. Per il caffè, non occorreva arrivare prima delle dieci2.
Come teorizzava Anton Čechov a proposito del teatro, se un’arma compare nel corso delle vicende prima o poi sparerà e starà soltanto al lettore scoprire dove, quando e contro chi o cosa.
E’ «l’uomo nudo» quello di cui ci parla Simenon nei suoi romanzi. Nudo davanti a se stesso, prima di tutto, poiché, pirandellianamente, tutto sommato la società gli fornisce un’abbondanza di maschere dietro cui nascondere l’alienazione che lo pervade completamente.
Funziona la scrittura di Simenon, sia sul piano narrativo, secca e spogliata di qualsiasi banalità o parola non necessaria, ma soprattutto come “guida” al noir, di cui rivela implacabilmente come il male, che può nascondersi in ognuno e in ogni vicenda umana, non ha bisogno di complicate trame e complotti per esplodere e manifestarsi. E neppure ha bisogno di esser compreso attraverso descrizioni minuziose di ambienti degradati che finiscono col giustificarne le azioni e le esplosioni.
No, per Simenon basta la vita di ogni giorno.
E questa è la sua lezione più importante, dai romanzi di Maigret a tutti gli altri.
Compreso, naturalmente, quest’ultimo.



