di Samuele Cerea
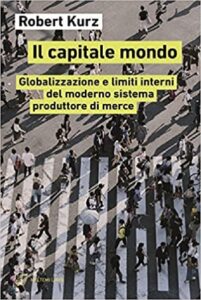 Robert Kurz, Il capitale mondo. Globalizzazione e limiti interni del moderno sistema produttore di merci, Meltemi, Milano, 2022, pp. 539, euro 30,00.
Robert Kurz, Il capitale mondo. Globalizzazione e limiti interni del moderno sistema produttore di merci, Meltemi, Milano, 2022, pp. 539, euro 30,00.
A quanto ci dicono i commentatori stiamo attraversando un’epoca di de-globalizzazione o di post-globalizzazione a base di tensioni internazionali, protezionismo, guerre commerciali, sanzioni economiche e spettri pandemici. Sugli schermi televisivi furoreggia un remake post-politico tanto desolante, quanto potenzialmente micidiale, del classico confronto tra le superpotenze nucleari, che avevamo liquidato un po’ troppo sbrigativamente come un relitto del passato, con le sue proxy-war e le sue figure emblematiche, oggi un tantino surreali. Nel frattempo le élite occidentali elogiano entusiasticamente la logica dei blocchi, auspicano con ansia la fine della dipendenza energetica, mettono in guardia sollecitamente contro il “pericolo giallo”, gli Stati-canaglia vecchi e nuovi e le torme dei falliti globali che si preparano ad assediare la “fortezza Occidente” (o il “giardino meraviglioso” nella poetica lezione di Josep Borrell).
Mentre Big Brother e Goldstein vivono ormai da tempo con noi e anche Oceania sembra a portata di mano vale ancora la pena leggere un libro pubblicato in Germania nei primi anni Duemila, quando le medesime élite politiche ed economiche urlavano dai tetti la buona novella della globalizzazione, trattando con un misto di sufficienza, di fastidio e di apprensione coloro che, ed allora erano davvero tanti, contestavano con ragioni più o meno condivisibili, l’utopia-distopia del mondo unificato?
Il saggio in questione ha per titolo “Il Capitale-mondo” (“Das Weltkapital”, 2004). L’autore, il tedesco Robert Kurz, ha finora goduto di scarsa fortuna e notorietà in Italia anche se taluni rivoli del suo pensiero affiorano talvolta nelle opere di qualche autore nostrano come fiumiciattoli carsici. Scomparso una decina di anni or sono, autore, a partire dagli anni Ottanta, di una decina di libri e di un numero assai maggiore di contributi, apparsi generalmente sulle riviste Krisis e Exit!, nonché di moltissimi articoli per quotidiani come il berlinese “Neue Zeit” e la “Folha” di San Paolo, Robert Kurz può contare da noi, negli ultimi anni, sulla traduzione de Il collasso della modernizzazione e del testo qui presentato oltre che di altri saggi più brevi.
Va detto che Kurz sconta il fatto di aver commesso numerosi peccati contro lo spirito (dei tempi). Anzitutto, contravvenendo agli anatemi postmoderni e alla tendenza attuale verso la “divisione del lavoro” filosofica, nemici giurati della “totalità” e alquanto inclini alle cineserie intellettuali, è l’orgoglioso aedo di una nuova “grande narrazione”. Animata per giunta non certo da una postura contemplativa ma decisamente rivolta verso il sovvertimento dell’ordine sociale esistente. In secondo luogo ha posato le fondamenta di questa impresa sulla base, a dir poco insidiosa, del paria ideologico Karl Marx. E nemmeno su quelle parti della teoria di Marx più o meno sopravvissute allo sconquasso successivo al 1989, come la “lotta di classe” o lo “sfruttamento”, bensì su frammenti, intuizioni, filoni, idee che si stagliano nel panorama del pensiero del filosofo di Treviri come massi erratici o come smarriti isolotti in un esteso arcipelago. Terzo, la teoria di Kurz ha un grave fastidio: analizza e interpreta la realtà sociale ma non contiene nulla che possa essere convertito in breve tempo in un programma politico, al servizio dei partiti della “sinistra” (oggi meno che mai), dei sindacati o dei movimenti di protesta.
Ma veniamo al saggio in questione. Il Capitale-mondo è un libro di grossa mole e non certo di facile lettura. E del resto, da buon seguace di Marx, anche Kurz scrive per lettori che vogliano imparare qualcosa con la propria testa. Aiuterebbe certo una conoscenza almeno elementare del quadro teorico in cui si muove l’autore ma ciò esula dai limiti di una semplice recensione. Si rimanda ad altre opere dal carattere propedeutico. Ci limitiamo a dire che la diagnosi operata da Kurz sui destini della modernità ha il suo fulcro nella critica dell’economia politica di Marx e sulle categorie, in crisi irreversibile, di valore e lavoro (astratto).
Come il riccio di Archiloco anche Robert Kurz conosce una sola cosa ma è grande. Il sistema sociale che indichiamo comunemente in una prospettiva storica con il nome di modernità o società moderna e in una prospettiva socio-economica come società capitalistica o capitalismo tout court è giunto a fine corsa e minaccia di schiantarsi. Buone notizie per gli oppositori del sistema? Non tanto. Il capitalismo ha già imboccato la strada che porta verso il cimitero dei pachidermi della storia. Il guaio è che a sotterrare il capitalismo non saranno audaci schiere di lavoratori organizzati, o qualunque surrogato sulla piazza, ma le sue stesse contraddizioni, che Kurz condensa nel concetto del “limite interno”. Il corollario di questa concezione è però che non è affatto detto che il capitalismo venga seguito da una nuova società più stabile e giusta, da un nuovo ordine coerente; al momento l’alternativa più probabile è che il capitalismo entri in una nuova “era delle tenebre”, caratterizzata dall’implosione delle istituzioni sociali e delle strutture economiche. Come ha detto altrove il nostro autore, “la prigione è in fiamme ma qualcuno ha serrato le finestre e i prigionieri sono bloccati al suo interno”.
La storia del capitalismo è quella di una dinamica irreversibile con le sue fasi. Quella analizzata da Kurz in questo saggio è l’apogeo della fase neo-liberale, iniziata alla fine dei Settanta, poi traumatizzata dalla crisi del 2008. La narrazione assembla l’analisi storica con la critica dell’ideologia, alterna capitoli in cui la natura della globalizzazione viene sviscerata sulla base di una grande quantità di dati economici (il cui filo non è sempre agevole da seguire) ad altri in cui si esaminano le conseguenze della frammentazione sociale, la crisi del denaro e della politica. Da sottolineare, in particolare, la disamina del capitale finanziario e del suo ruolo nel meccanismo dell’economia moderna. La ricchezza di temi è amplissima e Kurz ama dialogare, generalmente in termini polemici, con una moltitudine di voci presenti e passate, da Ulrich Beck a Joseph Stiglitz, da David Ricardo a Rudolf Hilferding, da Michel Aglietta a Peter Sloterdijk. Sarà possibile solo un breve excursus sul carattere generale dell’opera cui uniremo alcuni spunti critici circa numerose convinzioni diffuse oggi tra i contestatori del sistema.
Cosa turba l’apparente imbattibilità del sistema? La sua stessa logica. Nella prospettiva di Kurz la globalizzazione non è il sintomo dello stato di salute del capitale, che abbandona le mura nazionali per propagarsi con le sue catene produttive in tutto il globo ma una chiara conseguenza del fatto che il ristagno della produzione di valore, dovuto all’intervento della tecnologia informatica, della robotica – cioè della Terza Rivoluzione industriale –, costringe le imprese a una concorrenza disperata e cannibalesca, disperdendo le loro fasi produttive per il globo per approfittare del divario dei costi e delle condizioni sociali e giuridiche messe a disposizione degli Stati. Gli investimenti oggi non sono più investimenti per l’espansione ma per la razionalizzazione. Ma se le imprese se la passano male, per gli Stati va anche peggio, costretti dalla crisi delle finanze pubbliche a indebitarsi sempre più sui mercati finanziari, a privatizzare e a tagliare le infrastrutture sociali.
In quest’ottica un effetto salutare del libro potrebbe essere quello di fare piazza pulita di tutta una serie di false idee sulla crisi del sistema e sulla possibilità di venirne a capo. Il primo punto lo si potrebbe intitolare “Com’era verde la mia nazione!” E qui entra naturalmente in gioco la categoria del “sovranismo”, la testa di turco preferita dell’establishment politico-finanziario-mediatico neoliberale. Il problema del sovranismo è che i suoi apostoli più riflessivi, per la maggior parte, non sono né ottusi campanilisti, né irriducibili fustigatori della contaminazione multiculturalista, né fanatici nazionalisti, adusi ad esterofobe campagne aggressive. Il loro errore consiste invece nel credere in ciò che un tempo si chiamava il “primato della politica”, cioè nella convinzione che uno Stato-nazione, ben radicato nelle sue istituzioni, guidato da una classe dirigente volenterosa, sia in grado di controllare, governare, correggere la propria economia di mercato, dirigendola verso obiettivi consoni agli interessi nazionali e della popolazione. Questa idea, che predica l’autonomia dello Stato nei confronti dell’economia o addirittura uno status gerarchico superiore, viene però sconfessata da Kurz. Lungi da essere il nocchiero del mercato, lo Stato e con esso, in generale, la sfera politica, dipende dall’accumulazione di capitale al suo interno, da cui esso preleva ciò di cui abbisogna per le sue “politiche” (sostanzialmente allocazioni di denaro in favore di obiettivi più o meno “democraticamente” prefissati). Ma una volta che il modello dell’accumulazione fordista entra in crisi, anche lo Stato manifesta la sua natura “secondaria” rispetto alla base economica. Di fronte alla transnazionalizzazione e alla razionalizzazione dell’economia, lo Stato, come osserva argutamente Kurz, non può “transnazionalizzarsi” a sua volta, né tantomeno “licenziare” i propri cittadini ma solo operare una “razionalizzazione” distruttiva, rinunciando gradualmente a finanziare le proprie infrastrutture sociali, indebitandosi fino al collo sui mercati finanziari e arrangiandosi così da attirare la quantità maggiore possibile di investimenti.
La critica “sovranista” non vuole comprendere questa relazione causale e interpreta, ad esempio, l’adesione dell’Italia alla moneta unica europea, non come una strategia opportunistica, per quanto miope, al fine della sopravvivenza del paese nel mercato mondiale ma come l’esito del “tradimento” di una casta politica di infedeli (Prodi, Ciampi, Amato etc.), cui sarebbe necessario rispondere con una rinazionalizzazione per la quale non sussiste il benché minimo fondamento.
Del resto tra i medesimi apologeti del sovranismo vale anche il grido “Que viva Keynes!” Da tempo, nel campo della “sinistra” più o meno radicale, l’icona di Keynes gode almeno di altrettanto favore di quella di Marx. Il motivo è presto detto. Il nome dell’economista di Cambridge è associato nella memoria di ogni buon socialdemocratico con i “trenta gloriosi” del XX secolo, con la realizzazione dello Stato del benessere, con il ruolo dello Stato nell’economia. Ciò ha perfino condotto a ritenere qualcuno che la teoria di Keynes sia fondamentalmente anti-capitalista. Ma la “nostalgia keynesiana” della sinistra e per il mondo di cui è stato l’augure è necessariamente legata alle fortune dello Stato-nazione e non è più adeguata al mondo attuale.
Dunque chi ha vinto la lotta di classe? Secondo una battuta attribuita a Warren Buffett, la sua, almeno per il momento. L’idea che la globalizzazione o, più in generale, l’epoca dei movimenti di capitale senza controllo coincida con una “rivincita” dell’élite globale capitalistica, dopo il micidiale affondo delle classi subalterne del secondo dopoguerra è stata sostenuta in tempi relativamente recenti, ad esempio, da David Harvey, secondo il quale il neoliberismo nel suo complesso sarebbe una colossale strategia di intervento del potere privato, delle grandi società industriali e finanziarie, le quali stanche di veder erosi i loro tassi di profitto a vantaggio della classe lavoratrice avrebbero plasmato le classi dirigenti al fine di rilanciare il dominio del potere economico sulla società.
Ma per Kurz l’avanzata della dottrina neoliberale alla fine degli anni Settanta non è stata altro che la risposta “passatista”, perché basata su di un recupero di alcuni aspetti della teoria dell’economia neoclassica, già falliti nell’epoca delle due guerre, alla crisi economica intervenuta in quel periodo. Era stata proprio la difficoltà nell’accumulazione del capitale, dovuta ai primordi della Terza Rivoluzione industriale, e la conseguente crisi del modello keynesiano, a suggerire la necessità di flessibilizzare il lavoro, ridurre la spesa pubblica, privatizzare tutto ciò che era possibile, fino allo sviluppo estremistico del settore finanziario. Dunque alla radice di questa vittoria della “classe sbagliata” c’era il fallimento del vecchio modello, quello della “classe giusta”, non una forma di revanscismo sociologico.
La principale illusione è quella di credere che l’economia di mercato e la democrazia politica non siano in sé cose troppo negative e che il problema consista solo nel combattere tutti quei soggetti che deformano il sistema per il proprio tornaconto. E allora per invertire la tendenza verso la crisi basterebbe che la politica smettesse di concentrarsi solo sul debito pubblico e sul prodotto interno lordo, come chiedono gli eurocrati, ma pensasse invece a promuovere posti di lavoro e aumenti salariali, che si chiudesse una volta per tutte con le privatizzazioni e con la socializzazione delle perdite del settore bancario e finanziario, che si ponessero paletti alla delocalizzazione delle imprese. In poche parole, occorrerebbe ripristinare un “mercato corretto”, immune dall’influenza dell’establishment e dei suoi lobbysti. Il progressivo degrado delle condizioni di vita non sarebbe quindi figlio della dinamica del capitalismo ma solo il frutto di strategie politiche manipolative.
La conclusione più reale è invece che le spaventose disuguaglianze che caratterizzano l’era del capitalismo neoliberale non sono il risultato di una strategia consapevole di élite ben decise a riaffermare il proprio punto di vista di classe ma la conseguenza logica e coerente del fatto che il capitalismo fallisce in ciò che esso ha di più essenziale, vale a dire l’accumulazione di valore effettivamente valido. La società dei “trenta gloriosi” del secondo dopoguerra, l’apoteosi del capitalismo “socialdemocratico”, nei limiti del mondo dell’Occidente sviluppato, con il suo solido capitalismo industriale in espansione, accompagnato da un settore creditizio e finanziario ancillare, si è estinta proprio perché tale modello fatto di sostanziale piena occupazione, di Stato sociale, di crescita dei redditi etc., si era ormai infilato in vicolo cieco fatto di stagnazione e inflazione.
L’abnorme crescita del capitale finanziario, favorita con ogni mezzo sul piano giuridico e normativo dalle classi dirigenti di ogni paese (anche se naturalmente non dappertutto con la stessa prontezza e la stessa rapidità) era dunque necessaria per simulare una crescita economica in totale assenza di una valorizzazione reale del capitale. La soppressione di tutte le catene che ostacolavano la libera circolazione del capitale finanziario era indispensabile, non solo perché lo esigevano gli interessi soggettivi degli attori interessati, ma soprattutto per una imperativa esigenza sistemica: il salvataggio, in ultima analisi illusorio, del sistema di mercato.
Si aggiunga inoltre che questa eclatante asimmetria di ricchezza e di reddito che caratterizza la nuova era neoliberale non è affatto eccezionale nella storia del capitalismo. Come illustra lo stesso Kurz in un altro saggio (“Schwarzbuch Kapitalismus”, 1999) la tendenza del capitalismo è sempre stata quella di ridurre al minimo il consumo delle masse, di deteriorare fino all’estremo la vita sociale. Questo fa sì che la relativa “cuccagna” dell’Età dell’oro fu un evento eccezionale, una sorta di effimero periodo di tepore in un’epoca di glaciazione.
Ne risulta che l’idea del “primato della politica”, della possibilità da parte di una classe dirigente benintenzionata e “popolare” possa ripristinare l’Eden fordista mediante misure redistributive e una nuova strategia di sviluppo economico è una mera illusione. L’“estate di san Martino” del capitalismo non tornerà mai più, tantomeno per mano di un sovranismo progressista.



