di Fabio Ciabatti
 James O’Connor, La seconda contraddizione del capitalismo. Introduzione a una teoria e storia dell’ecologia, Ombre Corte 2021, pp. 144, € 10
James O’Connor, La seconda contraddizione del capitalismo. Introduzione a una teoria e storia dell’ecologia, Ombre Corte 2021, pp. 144, € 10
“Più la natura – modificata dall’agire umano – è vista come storia del lavoro, della proprietà, dello sfruttamento e della lotta sociale, maggiori sono le possibilità di un futuro sostenibile, equo e socialmente giusto”.1 Queste parole che chiudono il testo di James O’Connor (1930-2017) La seconda contraddizione del capitalismo, assumono alla luce della pandemia da COVID-19 una tragica attualità: le massicce deforestazioni delle zone equatoriali dovute alle monoculture sono condizioni perfette per il salto di specie dei virus, gli allevamenti intensivi favoriscono la crescita di contagiosità e virulenza di virus e batteri, le catene del valore e del trasporto merci sempre più estese a livello planetario accelerano la diffusione globale di questi stessi agenti patogeni.
Per questo, come ci ricorda la prefazione di Jacopo Nicola Bergamo e Emanuele Leonardi, c’è chi si è spinto a definire la crisi attuale come la “prima crisi O’Connor”. In altri termini, con l’attuale pandemia per la prima volta si sarebbe manifestata, con simultanea virulenza a livello mondiale, quella seconda contraddizione del capitalismo di cui parla l’economista americano, che fu uno dei padri nobili dell’eco-marxismo, nei due articoli usciti originariamente alla fine degli anni Novanta nella rivista Capitalism Nature Socialism e riuniti nel libro pubblicato da Ombre Corte nell’anno in corso.
Ma cosa intende O’Connor quando parla di seconda contraddizione? Per rispondere bisogna partire dalla prima, quella tra forze produttive (l’insieme strutturato di macchinari, conoscenze tecnico-scientifiche e forza lavoro) e rapporti di produzione (i rapporti giuridici di proprietà). Secondo Marx, fino a un certo livello della maturazione storica di un modo di produzione, i rapporti di produzione sono coerente espressione giuridica delle forze produttive. La proprietà privata dei mezzi di produzione, per esempio, è funzionale all’accumulazione capitalistica. Gli stessi rapporti di produzione, però, diventano un ostacolo per l’ulteriore crescita delle forze produttive quando queste ultime raggiungono un certo livello di sviluppo. In questo caso il sistema si scontra con una contraddizione completamente interna perché sono le sue stesse leggi di funzionamento a creare le condizioni della sua crisi.
Con la seconda contraddizione lo scenario muta perché forze produttive e rapporti di produzione, cioè gli elementi creati dallo sviluppo del sistema capitalistico, entrano in conflitto con qualcosa che non è completamente determinato da questo sviluppo, vale a dire le “condizioni della produzione”. O’Connor parla di di tre tipi di presupposti della produzione capitalistica: gli elementi naturali che entrano nel capitale costante e in quello variabile, la popolazione lavoratrice e le condizioni comunitarie generali della produzione (p. es. i mezzi di comunicazione o lo spazio urbano). Per il capitale, consacrato a un’accumulazione senza limiti, queste condizioni sono dei presupposti esterni e sfruttabili all’infinito. In realtà, trattandosi di condizioni per natura limitate, lo sfruttamento capitalistico produce il loro ineluttabile depauperamento. Ciò a sua volta determina un aumento dei costi di produzione per il capitale e costituisce dunque un elemento di crisi perché incide negativamente sui profitti, fine ultimo della produzione capitalistica.
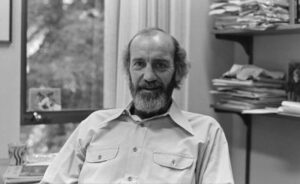 Questo collegamento diretto tra distruzione delle condizioni di produzione e crisi capitalistica, come sottolineano gli autori della prefazione, è stato considerato troppo meccanico anche in ambito marxista, perché prevede che il capitale si faccia carico dei relativi costi, cosa non può essere data per scontata. Pur tenendo conto dell’obiezione, rimane il fatto che la dinamica descritta da O’Connor porta ineluttabilmente all’aggravarsi di una crisi sociale. In questo contesto entrano in gioco due fattori differenti: da una parte l’intervento dello stato e dall’altra i conflitti sociali.
Questo collegamento diretto tra distruzione delle condizioni di produzione e crisi capitalistica, come sottolineano gli autori della prefazione, è stato considerato troppo meccanico anche in ambito marxista, perché prevede che il capitale si faccia carico dei relativi costi, cosa non può essere data per scontata. Pur tenendo conto dell’obiezione, rimane il fatto che la dinamica descritta da O’Connor porta ineluttabilmente all’aggravarsi di una crisi sociale. In questo contesto entrano in gioco due fattori differenti: da una parte l’intervento dello stato e dall’altra i conflitti sociali.
Se non sono i singoli capitali a farsi carico della riproduzione delle condizioni della produzione, dovrà essere il capitale collettivo, attraverso lo stato, a occuparsene. Tra l’altro è la scala dei problemi che si presentano, si pensi per esempio al riscaldamento globale, ad imporlo. Questo intervento non solo ha un costo che viene socializzato attraverso la fiscalità, ma anche il difetto di politicizzare i problemi relativi alla riproduzione sociale complessiva sottoponendo, almeno potenzialmente, alcune scelte economiche determinati al vaglio collettivo, sottraendole al monopolio del capitale. Ma non è tutto. L’intervento dello stato significa la necessità di una pianificazione centralizzata che, per quanto possa essere subordinata agli imperativi del capitale, costituisce, anche se in modo solo potenziale, l’introduzione di meccanismi di governo passibili di essere declinati in senso socialista. È chiaro che l’attuazione di questa potenzialità può avvenire soltanto attraverso i conflitti sociali. Quei conflitti che la distruzione delle condizioni della produzione tende ad alimentare ai diversi livelli su cui si articola: i movimenti ambientalisti, i movimenti femministi e i movimenti territoriali.
I conflitti e le lotte sociali giocano anche un ruolo importante a livello, potremmo dire, di immaginario. Essi, infatti, sono gli elementi che mediano tra i cambiamenti strutturali (sistemi di lavoro, sistemi di vita, rapporti con la natura) e i nuovi tipi di narrazione storica. In un processo tutt’altro che lineare, in considerazione dello sviluppo diseguale e combinato del capitalismo, O’Connor individua quattro tipi di narrazione: all’inizio del capitalismo abbiamo la storia politica che corrisponde al consolidarsi degli stati nazione; viene poi la storia economica che si incentra sul conflitto tra aristocrazia e borghesia, prima, e tra quest’ultima e il proletariato, dopo; si passa successivamente alla storia sociale e culturale in corrispondenza del consumismo (la generalizzazione della soddisfazione dei bisogni umani in forma mercificata) e della società di massa (l’universalizzazione della forma salariale del lavoro); si arriva infine alla storia ecologica.
Ciascun livello arricchisce quello precedente e al tempo stesso lo ingloba. La storia ecologica, dunque, può essere compresa solo nei termini dello sviluppo capitalistico e delle sue rivoluzioni politiche, economiche e socio-culturali. Essa può mettere a tema il rapporto tra uomo e ambiente solo partendo dal processo di mercificazione della natura e dunque da una teoria dell’accumulazione capitalistica di tipo marxista. In questo senso il rapporto tra società e natura può essere compreso solo nei termini di una dialettica autenticamente materialista. Per quanto il capitalismo tratti le condizioni di produzione come merci, esse non sono producibili e riproducibili come una qualsiasi merce. Soffermiamoci brevemente sulla prima tipologia di queste condizioni, la natura. Essa ha una sua componente di autonomia irriducibile rispetto alla prassi sociale e dunque si configura “come momento limitante o abilitante i progetti umani”.2 E questo vale anche per un ipotetico sviluppo delle forze produttive in senso socialista: non potrà mai esistere alcun tipo di crescita quantitativamente infinita della produzione che sia eco-compatibile. D’altra parte, non si deve dimenticare che il lavoro sociale media tra società e natura, trasformando inevitabilmente l’ambiente. Il progetto marxiano di umanizzazione della natura può ancora avere un significato positivo se i rapporti tra umanità e natura non vengono considerati in termini di dominio della prima sulla seconda, ma di cooperazione.
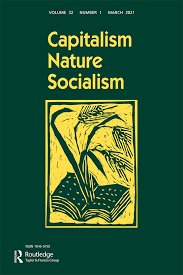 In conclusione, si potrebbe sostenere che l’articolazione sufficientemente compiuta del quarto tipo di narrazione, quella ecologica, è un progetto ancora largamente incompiuto. E ciò perché l’elemento mediatore, i conflitti determinati dalla distruzione delle condizioni di produzione, mantengono allo stato attuale uno stato ancora frammentario. Collegato a questo aspetto c’è il fatto che, nell’immaginario collettivo, l’economia capitalistica viene ancora percepita largamente come una “seconda natura” nel senso che appare come un potere esterno che non può essere controllato. In questo contesto il significante “ecologia” è caratterizzato da un’accentuata ambiguità in quanto arena di una lotta per il suo significato: una lotta tra chi ritiene che i problemi ambientali possano essere affrontati attraverso l’adozione di tecnologie verdi e la modifica dei comportamenti individuali e chi, invece, sostiene la necessità di una profonda trasformazione dei rapporti sociali di produzione.
In conclusione, si potrebbe sostenere che l’articolazione sufficientemente compiuta del quarto tipo di narrazione, quella ecologica, è un progetto ancora largamente incompiuto. E ciò perché l’elemento mediatore, i conflitti determinati dalla distruzione delle condizioni di produzione, mantengono allo stato attuale uno stato ancora frammentario. Collegato a questo aspetto c’è il fatto che, nell’immaginario collettivo, l’economia capitalistica viene ancora percepita largamente come una “seconda natura” nel senso che appare come un potere esterno che non può essere controllato. In questo contesto il significante “ecologia” è caratterizzato da un’accentuata ambiguità in quanto arena di una lotta per il suo significato: una lotta tra chi ritiene che i problemi ambientali possano essere affrontati attraverso l’adozione di tecnologie verdi e la modifica dei comportamenti individuali e chi, invece, sostiene la necessità di una profonda trasformazione dei rapporti sociali di produzione.
Se il capitale globale alla fine trionfa, e se la natura è considerata dalle generazioni future meramente come “capitale naturale” (con gli esseri umani che diventano “capitale umano” e la comunità “capitale comunitario”), la storia dell’ecologia finirà con il diventare la storia della natura capitalistica pura e semplice. I movimenti di resistenza saranno cancellati e giocheranno un ruolo trascurato o dimenticato dagli storici.3
Non è un caso che le élite capitalistiche globali abbiano lungamente corteggiato i giovani dei Fridays for future: il loro obiettivo è quello di incanalare questo movimento verso il sostegno alla green economy; verso, cioè, il supporto a una ristrutturazione dell’economia tutta interna alle logiche dell’accumulazione capitalistica, in grado di sfruttare a proprio vantaggio i disastri creati dall’accumulazione stessa.
Se questa è la posta in gioco occorre, sulla scia di O’Connor, superare l’esaltazione acritica della “differenza” e il correlato timore che la tensione verso l’unità delle lotte sociali e dei conflitti non sia altro che una tendenza verso il totalitarismo, elementi propri di un pensiero post-moderno mai realmente superato. Questa tensione verso l’unità forse non potrà realizzarsi unicamente attraverso una onnicomprensiva identità di classe perché, come sostiene O’Connor, le questioni che riguardano le condizioni di produzione sono problemi di classe e al contempo qualcosa di più. Rimane però vero quanto afferma lo stesso eco-marxista americano:
molte lotte sociali in difesa dell’integrità di particolari luoghi non riescono a diventare universali, e perciò a vincere, e al tempo stesso mantenere la propria diversità, se non quando diventano le lotte per la democratizzazione dello Stato e si uniscono alle lotte del movimento operaio, riconoscendo quello che hanno in comune, ossia la cooperazione del lavoro, teorizzando così l’unità del lavoro sociale”.4



