di Sandro Moiso
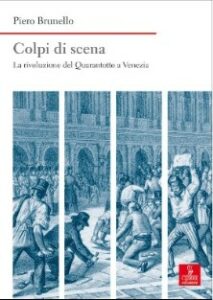 Piero Brunello, Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia, Cierre edizioni, Verona 2018, pp. 440, 18,00 euro
Piero Brunello, Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia, Cierre edizioni, Verona 2018, pp. 440, 18,00 euro
E’ un tema di estrema attualità quello che Piero Brunello pone al centro del suo studio sulla rivoluzione veneziana del 1848: quello di come vengono vissuti, sincronicamente e dai diversi attori, i differenti passaggi di una sommossa che supera i suoi limiti e che da protesta popolare, per quanto rabbiosa, si trasforma in un rovesciamento delle istituzioni cui sembrava inizialmente rivolgere le proprie richieste.
Sembrerebbe così lontano da noi il tema di una rivoluzione risorgimentale da far pensare, ai lettori meno attenti o forse più ideologizzati, che fatti apparentemente già conosciuti e sviscerati possano essere soltanto più oggetto di ricerche erudite o di archivio, finalizzate esclusivamente ai corsi universitari o alla ristretta cerchia degli storici. Eppure, eppure… ancora una volta il passato può illuminare il nostro presente o, almeno, il nostro ragionare su quel che già è stato, sull’attualità e su ciò che ci aspettiamo dal futuro.
Questo accade perché Brunello, con la sua solita abilità di scrittura e con la sua accuratezza nella ricerca, riesce ad andare ben al di là del tema individuato e a far riflettere i lettori su cosa poi, davvero, possa essere o non essere considerata “Rivoluzione”.
Termine abusato e mai del tutto chiarito fino in fondo, soprattutto all’interno di quei discorsi retorici e patriottici sul Risorgimento che, spesso, troppo facilmente e soprattutto a sinistra sono stati fatti sul riscatto dei popoli e sulle rivoluzioni nazionali.
Infatti la seconda domanda che si pone l’autore (che ha insegnato Storia sociale all’Università Ca’ Foscari di Venezia e che si è occupato di migrazioni, scrittura, storia urbana, culture popolari, musica e anarchismo) è proprio se la ‘rivoluzione veneziana’ sia stata tale, negli intenti e nei fini conseguiti dai suoi più o meno consapevoli promotori.
Dicono che gli storici sono avvantaggiati perché studiano eventi sapendo come vanno a finire, e invece è vero il contrario, perché rischiano di non vedere in un’epoca storica le possibilità aperte e l’incertezza dell’esito. Nel caso del Quarantotto le parole stesse, a cominciare da “repubblica”, vengono fraintese qualora si veda in quella rivoluzione un momento preparatorio di qualcosa che si sarebbe realizzato decenni dopo e in modi imprevedibili. Lev Tolstoj ha osservato che «l’uomo che svolge una certa parte in un evento storico non ne coglie mai il senso». Chi il 17 marzo 1848 pensa di fare un «evviva» all’imperatore per aver concesso la Costituzione ricorderà poi di aver partecipato alla prima giornata rivoluzionaria, e chi il 18 marzo festeggia la Guardia civica pensando che questo inauguri un futuro assetto costituzionale dell’impero austriaco sente gridare all’improvviso «abbasso il governo!». Per dirla con Luciano Bianciardi, «chi fa la rivoluzione non si rende ben conto che la sta facendo».1
Per questo motivo Brunello, nella sua accuratissima ricostruzione degli eventi, ha preferito le testimonianze prodotte a ridosso degli eventi perché, sia che si tratti di quelle di uomini importanti (che in apparenza sembrerebbero aver saputo guidare gli eventi) che di quelle di individui anonimi (di cui si supporrebbe l’ignoranza dei fini), tutti gli attori non hanno una chiara idea delle conseguenze dei fatti e delle parole recitate sul palcoscenico sociale.
C’è ancora oggi un’idea forte, figlia di un Novecento già esaurito, che perpetra l’immagine di rivoluzionari in grado di percepire e forzare gli eventi con un ben preciso orientamento, destinato a governare le caotiche correnti della Storia. E’ una visione teleologica e finalistica, spesso ricostruita a posteriori, che ben poco ha a che fare con lo scorrere degli eventi reali e con i bisogni o i sogni che li hanno prodotti.
Non solo: Brunello ci aiuta anche a chiarire come spesso sia i risultati che le idee che in qualche modo hanno contribuito a produrli sono forzosamente interpretati per giustificare ex-post le politiche condotte dai governi successivi oppure dai “partiti” che si ritengono depositari di una certa immagine del passato.
Si pensi al mito dell’”indipendenza” italiana, che animò i sentimenti dei promotori delle insurrezioni del Quarantotto e di quelle successive. Tradite quasi da subito, poco dopo la creazione del Regno d’Italia (1861) e la cessione del Veneto allo stesso nel 1866, come conseguenza della cosiddetta Terza guerra d’indipendenza, con l’ingresso dell’Italia in quella alleanza che vedeva proprio nell’Austria-Ungheria uno dei sodali politici e militari. Alleanza difensiva si disse allora (1882), ma che certo dovette agitare non poco il sonno di coloro che, vivi oppur morti, proprio nell’austriaco avevano visto l’incarnazione del dominio e del nemico.
Ma se questo non bastasse, andrebbe ancora osservato che a rovesciare quell’alleanza avrebbe contribuito proprio, tra gli altri, quel Benito Mussolini, dai ‘nobili natali socialisti’, condannato poi quale “traditore della Patria” proprio da coloro che nella Resistenza avrebbero individuato un “secondo Risorgimento”.
Un ripetuto infrangersi di onde sulle scogliere della Storia che indicano come gli idoli dello Stato e della Nazione abbiano sempre bisogno di narrazioni mitiche destinate a conservare in maniera gattopardesca la sostanza della differenziazione sociale e della proprietà privata per mezzo di solidi confini che sono sempre, comunque e prima di tutto, di classe.
Sarà il vecchio Aleksandr Herzen a suggerirlo in un suo scritto citato a pagina 206: «Non basta odiare la corona, bisogna anche perdere il rispetto del berretto frigio». In una sorta di invito ad una rivoluzione permanente che la teleologia storica tende inevitabilmente a rimuovere dall’orizzonte del possibile, invitandoci ad accontentarci dell’ordinario.
Ordinario, che nei suoi termini “nazionali”, come già ricordava Carlo Cattaneo alla fine del 1848, mostrava come: «L’Ungaro voleva esser libero, ma oppressore dello Slavo e del Valacco. Il Viennese voleva essere libero, ma opprimere e lo Slavo e il Valacco, e l’Ungaro stesso e l’Italiano»2
“Italiano” che, tranne gli sparuti casi di volontari garibaldini in Polonia nel 1863 e in Grecia nel 1897, vedrà molti artefici del risorgimento, ad esempio Francesco Crispi, contribuire all’espansione imperialistica italiana verso l’Africa Orientale fin dagli anni ottanta del XIX secolo.
No, la ricerca di Brunello non si spinge così avanti, ma ci aiuta a riflettere. Soprattutto in tempi in cui molti che si vorrebbero antagonisti e rivoluzionari si pensano ancora patriottardi e facilmente anti-europei in nome di un fantomatico interesse nazionale comune. Invece di combattere il primo nemico che è sempre tra le mura di casa, come nella maggior parte dei femminicidi, e dimenticando che a chiamare a raccolta intorno alla Nazione già ci pensano i media, l’avvocato del popolo, il PD e i suoi miserabili derivati, le cinque stelle del nulla e la Destra; sovranista, sociale o moderata che quest’ultima sia. Insomma: una pessima compagnia.



