di Riccardo Canaletti
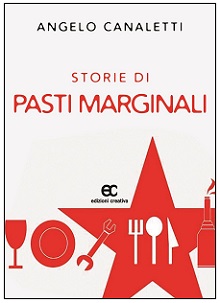 Presentiamo di seguito l’intervista ad Angelo Canaletti, autore di due romanzi noir (Storie di Pasti marginali e Antipasti marginali, usciti entrambi per le Edizioni Creativa) che perfettamente si inseriscono nel filone percorso anche da altri componenti del collettivo “sedicente intellettuale” di cui Canaletti fa parte: la “Carboneria letteraria”. Una realtà alla quale l’autore deve molto, penso ad altri romanzi come La notte apparente di Alberto Cola (altro carbonaro); ma una realtà che sa prendere molto anche dall’autore, dotato di sottile ironia e di grande conoscenza storica del periodo che va dagli anni ’68/’69 fino ai nostri giorni. In questa compagine di eventi due elementi saltano all’occhio: una grande capacità di creare intrecci che sappiamo mettere in dialogo passato e vicende presenti (in particolare il periodo che gravita intorno al ’77 e il presente inteso come categoria, ovvero un presente che non si riduce mai ai fatti di un protagonista, e di pochi personaggi connessi, ma che si apre alla complessità che, per le stesse parole dell’autore, fa un po’ da sostrato alla trama dei suoi romanzi); e una grande capacità di fare critica di quei tempi, di quei movimenti, ma senza mai arrendersi a inutili disfattismi. Abbiamo ironia, autocritica, analisi e narrazione che, in una più che armonica (e leggera) costruzione letteraria come quella del romanzo/racconto resa in brevi capitoli, agili, ognuno dei quali resta come un’immagine quasi fosse un track di un album musicale, fanno luce su varie vicende, vari concetti mai chiariti, o i cui chiarimenti non sono mai stati accettati dai più.
Presentiamo di seguito l’intervista ad Angelo Canaletti, autore di due romanzi noir (Storie di Pasti marginali e Antipasti marginali, usciti entrambi per le Edizioni Creativa) che perfettamente si inseriscono nel filone percorso anche da altri componenti del collettivo “sedicente intellettuale” di cui Canaletti fa parte: la “Carboneria letteraria”. Una realtà alla quale l’autore deve molto, penso ad altri romanzi come La notte apparente di Alberto Cola (altro carbonaro); ma una realtà che sa prendere molto anche dall’autore, dotato di sottile ironia e di grande conoscenza storica del periodo che va dagli anni ’68/’69 fino ai nostri giorni. In questa compagine di eventi due elementi saltano all’occhio: una grande capacità di creare intrecci che sappiamo mettere in dialogo passato e vicende presenti (in particolare il periodo che gravita intorno al ’77 e il presente inteso come categoria, ovvero un presente che non si riduce mai ai fatti di un protagonista, e di pochi personaggi connessi, ma che si apre alla complessità che, per le stesse parole dell’autore, fa un po’ da sostrato alla trama dei suoi romanzi); e una grande capacità di fare critica di quei tempi, di quei movimenti, ma senza mai arrendersi a inutili disfattismi. Abbiamo ironia, autocritica, analisi e narrazione che, in una più che armonica (e leggera) costruzione letteraria come quella del romanzo/racconto resa in brevi capitoli, agili, ognuno dei quali resta come un’immagine quasi fosse un track di un album musicale, fanno luce su varie vicende, vari concetti mai chiariti, o i cui chiarimenti non sono mai stati accettati dai più.
Altra questione importante è quella che vede scansare qualunque forma di ortodossia (gramsciana, leninista, etc.) per concedersi, proprio tramite l’autocritica e l’ironia, a una visione delle cose meno “dogmatica” e/o “universale”, potremmo dire “antireligiosa”. La violenza, elemento su cui si basa la storia, non è mai uno strumento assoluto, un qualcosa da difendere o celebrare. La violenza non è mai un fine, uno scopo. La violenza è solo la risposta, la “reazione” ad una vita che è, per il novantanove percento del tempo, non violenta, assuefatta alle logiche dell’economia, della politica e del lavoro. Guardare al mondo del vissuto, invece che al mondo delle scienze (se volessimo mantenere una distinzione che già Edmund Husserl, padre della fenomenologia, aveva fatto), significa lasciare aperto il campo dell’incertezza, del probabile (e dell’improbabile). Significa non assicurarsi nessun risultato, ma mirare all’azione, un’azione che, lontanissima dall’idea “corporativista” di alcune realtà armate del secolo scorso, si snoda nella giornata dei due protagonisti, Umberto e Gino, uomini normali ma stanchi di abbassare sempre la testa.
In questo dialogo parleremo del primo libro, Storie di Pasti marginali
Come è venuta l’idea del libro? I personaggi, ad esempio, non sembrano prendersi sul serio, eppure sono dotati di una certa coscienza politica e anche di una determinata cultura. Umberto e Gino, due figure in qualche modo autobiografiche?
Smontiamo gli equivoci: cinque o sei anni separano la mia biografia da quella dei personaggi. Loro erano a Roma nel ’77, io alle medie, a Civitanova Marche. È evidente che condividiamo una biografia culturale e lo spirito politico è affine. Eppure le motivazioni sono altre, a cominciare da una certa insofferenza per romanzi e cinematografia dedicata a poliziotti bravi e buoni, magistrati raffinati e risolutivi, giudici simpatici e benevoli. Qui si vuole narrare delle storie di due antagonisti; gli eroi, i buoni, sono fuori dalla legge, esercitano il loro intelletto per sfuggire alla legge. Riprendono cioè il meglio, a mio parere, dell’esperienza delle lotte autonome degli anni Settanta e delle fughe conseguenti. Senza cedere troppo alla seriosità. Anzi, direi, cedendo assai poco. Per questo li ho descritti spesso nella loro imbranataggine.
Nel romanzo narrazione e riflessione politica si alternano in equilibrio, ma in dei punti della storia quest’ultima sembra prevalere sul racconto. C’è un tentativo di difesa, di ripresa, o si vuol semplicemente sottolineare come azioni del genere non siano prive di senso?
Bene, è pur sempre un romanzo, e quindi la vicenda è una storia di fantasia, non si pretende di descrivere un atto nel senso di auspicarlo. Il fatto in sé è funzionale al racconto e allo sviluppo della trama e dei personaggi. Resta il fatto che ciò che è auspicabile è la rivolta, ovvero il desiderio di rivolta. Non so quali azioni siano sensate, ma ritengo assai sensato ragionare sul tempo presente per mettere a fuoco quanto sia insensato e spesso meno favorevole di quello che negli anni Settanta ha scatenato rivolte sociali nel cosiddetto Occidente industrializzato. La politica è vista come critica della politica e fa da controcanto all’attuale rimozione della politica.
La “risposta al Capitale” dei protagonisti è fortemente ironica, seppur mai ridicola. È una forma di violenza, in qualche misura? O dobbiamo guardare ad Umberto e Gino solamente come due uomini delusi? Sono, cioè, dei perdenti da compatire (io non credo) o personaggi con una loro forza che sta negli ideali, più che nella realizzazione?
Ecco, questo non è facile a dirsi. Sono dell’idea che i due atteggiamenti convivano. Perché è umano avere ideali anche quando si sente il peso della sconfitta o dell’emarginazione. Eppure io credo che prevalga in Umberto e Gino un percorso ancora diverso: la loro strada è lunga, a partire da quegli anni ribelli fino a Pasti Marginali. Tra delusioni, discussioni e ripresa dell’azione, riescono comunque a mantenere una loro lucidità e capacità di analisi. Sicuramente qualcuno li compatisce, altri ancora riconoscono le loro idealità, e molti li ignorano. Loro scelgono un percorso “violento” nel senso che si muovono al di fuori del consentito e infrangono la tranquillità delle vittime, in un caso si scontrano con la morte. Ma non è una scelta basata sulla violenza come meccanismo perfetto e ineludibile, riconduce di più a una necessità, ad un mezzo opportuno e mai osannato in quanto tale. Per intendersi, non mimano la lotta armata brigatista, ma si rifanno agli espropri proletari. Due pratiche che nell’essere diverse operativamente connotavano due idee diverse di rivolta e di coinvolgimento sociale.
Sempre parlando dei protagonisti, non si può certo definirli eroi. Eppure si parteggia per loro, per via della loro simpatia e della loro umanità. È stata una formula calcolata o i personaggi sono cresciuti con la storia e con l’autore?
Difficile rispondere. Prima di tutto perché non sono un professionista della scrittura e non so muovermi tra gli argomenti propri della letteratura e dei suoi meccanismi codificati. Dico che sono eroi in quanto protagonisti e che la loro forma si è data nel corso della stesura e nel fluire delle idee narrative. L’intenzione di guardare tutto con occhio ironico è sicuramente voluta, come pure il mio parteggiare per le loro scelte in contrasto con quelle di buon senso di molti altri personaggi. Come pure è esplicito il desiderio di mettere in cattiva luce l’ex poliziotto e il magistrato. Poi, nello scrivere, la storia si sviluppa in modo a volte imprevedibile per chi la scrive.
 Passando agli altri personaggi, che non potrebbero in qualche modo non definirsi anche loro protagonisti, la domanda più spontanea è: perché questo interesse nel tratteggiare con tanta perizia anche psicologica delle figure, potremmo dire, alla periferia della vita? degli esclusi (penso alla prostituta)
Passando agli altri personaggi, che non potrebbero in qualche modo non definirsi anche loro protagonisti, la domanda più spontanea è: perché questo interesse nel tratteggiare con tanta perizia anche psicologica delle figure, potremmo dire, alla periferia della vita? degli esclusi (penso alla prostituta)
Penso che la prostituta, Svetlana, sia il personaggio puro per eccellenza. Nella sua vita carica di esperienza negative, lei svetta come elemento di candore, anche quando esercita la sua professione o pensa al suo futuro da modella. È una ragazzina che vorrebbe essere tale ma si ritrova a vivere in quel modo a causa di una vita in cui lei non ha potuto mai dare precedenza alle sue scelte. Su di lei si concentra tutto il mio affetto. Per gli altri protagonisti, come dici giustamente, il mio obiettivo era quello di renderli attori essenziali allo sviluppo delle vicende. Non credo che ci possano essere figure umane di secondo piano, anche quando sono tra quelli che io disdegno e tratteggio in modo non positivo. L’attenzione per ognuno è un modo per rendere efficace la vicenda di ognuno nell’economia di questa storia.
Il paesaggio assume un ruolo non solo di cornice ma ha, anzi, impresse tutte le caratteristiche “sociali” del contesto in cui esso sussiste (Nord Europa, Marche, etc.). Cosa significa paesaggio? E qual è il luogo a lei più vicino nella storia, non necessariamente geograficamente?
Amo il freddo, quindi la finale Norvegia assomiglia al mio paesaggio ideale. Che poi è il senso del racconto, l’adozione dell’idea di fuga come ribellione e non come ritirata. L’esodo come rivolta, secondo i ragionamenti di molti autori a me cari rintracciabili in una pubblicazione periodica di qualche anno fa, titolata Luogo Comune. Ma ogni luogo ha un senso, un suo senso. Dalla metropoli alla provincia, alle regioni in ebollizione sparse per il pianeta. Ogni luogo è un’esperienza ò la conoscenza di altre esperienze. Certamente un luogo non è solo geografia. E i luoghi a cui mi riferisco sono sempre antropizzati, non ho un’idea positiva della natura in sé. Non mi interessa proprio sapere che ci sono delle belle cascate, mi interessa vederle o studiarle o capire come farne buon uso. Che non vuol dire sfruttare la natura, ma semplicemente interagire con la natura. Senza umanità non trovo i valori naturali di particolare interesse. Dove si sviluppa la storia si sviluppa una parte di umanità irrequieta. Inoltre, ogni luogo è simbolo di una contraddizione.
La tematica politica, ritorniamoci, si presta bene a certe riflessioni. Non c’è apologetica, ma non c’è nemmeno delusione. Come guardare agli eventi del ’77 e del ’68?
Ogni processo storico è bene che si connetta sempre al suo tempo. Le riproposizioni fanno diventare tutto tragedia o farsa. Io ritengo estremamente utile capire quei processi e quei periodi, coglierne la portata e valutarne le assurdità che pure erano presenti. Il fatto più interessante è che nei movimenti dal ’68 al ’77 si è dato vita a una capacità elaborativa di quel presente in grado di prefigurare lo sviluppo futuro della società dell’Occidente industrializzato. La riduzione del tempo di lavoro, la comunicazione come fattore produttivo, l’automazione e le migrazioni dal sud del mondo, per dirne alcune. E la necessità di scardinare il patto tra capitale e movimento operaio ufficiale, con annessi sindacati, per dare corso allo sviluppo di desideri e bisogni immediati. Quello che è importante e non è morto era e resta la voglia di lottare contro il presente, di non accettarlo preconfezionato e definito per legge.
Nella misura in cui ci si appresta a leggere questo noir con gli occhi critici di un lettore attento, non può che nascere alla fine un sentimento di rivolta, una voglia vicina a quella di Umberto e Gino. Qualche formula per quest’epoca? Qualche consiglio per i giovani che vorrebbero non cedere alle lusinghe e alle violenze della coercizione e del Capitalismo?
Non si danno consigli a chi è giovane, si vorrebbe essere giovani e basta! Sono io che li attendo da voi, buoni consigli per non morire delusi.



