di Franco Pezzini
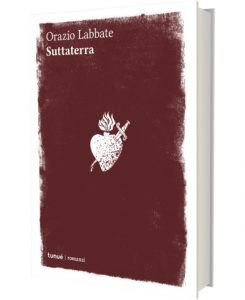 Orazio Labbate, Suttaterra, Tunué 2017, pp. 140, € 12.
Orazio Labbate, Suttaterra, Tunué 2017, pp. 140, € 12.
Per Borges i sogni rappresenterebbero il più antico genere letterario: non solo perché resoconti di sogni ci arrivano dall’antichità più remota coi più vari (e a volte pragmaticissimi) intendimenti, ma perché, in radice, l’atto stesso di sognare conosce una nostra dimensione “autorale”. Certo, basta intendersi sull’autoralità per qualcosa che erompe da dimensioni tanto profonde e magmatiche. Ma Borges va oltre, avvicinando il sogno alla poesia, linguaggio-ponte tra sogno e veglia e che può indifferentemente originare dall’uno o dall’altra. Queste considerazioni vengono alla mente leggendo un romanzo strano e affascinante di Orazio Labbate, ‘Suttaterra’, edito (come il suo primo, ‘Lo Scuru’, 2014, esordio dell’autore e prequel) dalla meritoria Tunué: un testo che non si limita a narrare situazioni fortemente oniriche ma del sogno riesce a restituire addirittura l’impasto espressivo, l’esperienza – usiamo pure questo termine – di smarrimento, l’alterità visionaria. Leggendo abbiamo la sensazione di figure o immagini sempre un passo di lato rispetto a dove stiamo cercando di guardare, o percepite soltanto con la coda dell’occhio ed è impossibile centrarle nel campo visivo; immagini – ancora – avvertite ma con uno scarto di significati, per cui ci pare di dover riconoscere qualcosa e lo incalziamo invano. Un’opera assolutamente in prosa, che tuttavia (si torna a Borges) muove sul linguaggio-ponte tra il sogno e quella veglia che almeno in teoria dovrebbe connotare il lettore: quasi a schiudere nel suo ritmo allucinatorio una dimensione poetica da canto sciamanico. Mi rendo conto che possono sembrare enfatizzazioni da recensore compiaciuto, alla ricerca di frasi a effetto: ma chi ha letto ‘Suttaterra’ può testimoniare per me.
Giuseppe Buscemi vive a Milton, West Virginia (legittimo domandarsi se nella scelta del toponimo sussista qualche eco di Paradisi perduti, ma forse non c’entra): è figlio di un avvocato divenuto predicatore e fanatico religioso, il Razziddu protagonista dello ‘Scuru’ che l’ha cresciuto in un contesto di ossessione e delirio, e ha trovato lavoro come impresario di pompe funebri (“dedicarsi alla dominazione della morte”). Da un anno Giuseppe è rimasto vedovo della moglie, la bellissima e angelicata Maria Boccadifuoco, morta – per ora non abbiamo dettagli – assieme al bimbo che attendevano, e si strugge in piena deriva psicologica ed emotiva. E il lettore con lui, sono pagine coinvolgenti.
Ma succede qualcosa di molto particolare: Giuseppe riceve una lettera dalla defunta. Maria – non può essere che lei – gli dà appuntamento nel loro “posto speciale”, nella Sicilia del viaggio di nozze: e il Nostro parte. Raggiunge la costa, attraversa l’Atlantico su una nave infera dal provocatorio nome di Christmas (ma lui è un anti-san Giuseppe, lei si chiamava Maria e c’è di mezzo un bimbo che non è nato) e si confronta con uno strano capitano che sintetizza un paio di ruoli del ‘Dracula’ di Stoker: e dopo una navigazione lunga e strana infine approda a Gela. Lì viene accolto da una specie di antievangelista a cui dobbiamo il sovraeccitato racconto di tutta la vicenda, il nano Alfonso Scibetta che fa pensare all’Hop-Frog di Poe; e lì inizia a cercare la moglie come un Orfeo sghembo (o come il detective protagonista di ‘Angel Heart’, capiremo poi in che senso). Il fatto è che i deliri del padre sembrano aver trovato una cassa di risonanza nell’interiorità turbata di Giuseppe: e se il vecchio si confrontava con la proiezione allucinata e invertita del Signore dei Puci (una statua un po’ impressionante di Cristo utilizzata in processioni notturne del Giovedì santo a Butera, che causava autentici incubi all’autore bambino e che ha un ruolo importante nello ‘Scuru’) a turbare Giuseppe è un’altra immagine religiosa trasfigurata in chiave demoniaca, la Madonna dell’Alemanna, di cui il nano Scibetta si proclama apostolo. La catabasi di Giuseppe tra personaggi oscuri e onirici è destinata però a far emergere qualcosa che lui oscuramente sa…
L’operazione linguistica di Labbate è straordinaria, e nel braciere di questo lessico del delirio si individuano riletture personalissime di autori molto diversi. Autori letterari (Ligotti ma anche i gotici dell’ottocento, e poi Bufalino, Consolo, D’Arrigo…) ma anche cinematografici – ovviamente David Lynch – tradotti in parole: autori avvicinati come i morti con certe droghe iniziatiche, dopo sai che ci hai parlato e ti hanno consegnato qualcosa.
Il sogno, dunque. Ma non un sogno qualunque: un sogno gotico. Come Walpole ci insegna (sulla base anche lì di un sogno da cui sorgerà il suo romanzo, per serendipity – il termine in fondo è suo – seminale di un genere), il Castello può apparirci finto, assurdamente teatrale o di cartongesso: può svelarsi grottesco, lasciarci la sensazione di non riuscire ad afferrarne le dinamiche o scopriamo di averne dimenticato i dettagli – quel dimenarsi di figure dove ognuno finge d’essere qualcun altro, compreso l’autore – appena chiuso il libro. Ma appunto come nel teatro, con la sua schematicità simbolica, quei fondali presuppongono qualcos’altro, un gioco/rito che il partecipe riesce a cogliere. È un Castello che emerge come punta di un iceberg, a ricordare tutto quel che sta sotto, resta rimosso o inconscio: e voler fermarsi a quei singoli dettagli – che non a caso fluiscono via – rischia d’essere il proverbiale fissare il dito invece che la luna. Con ‘Suttaterra’ accade qualcosa di simile, perché è (almeno in parte) simile il meccanismo. Certo, la storia è terribile, ma anche qui c’è il grottesco: come possiamo considerare “seria” una nave il cui capitano si chiama come il pazzo del ‘Dracula’ e rimanda alle coordinate infere del vascello Demeter stokeriano? Eppure, in qualche modo come in Walpole, è “seria” proprio perché è finta: quella serietà è qualcosa che guarda altrove, tra le pieghe della nostra cultura e – soprattutto – da qualche parte dentro di noi. Quel che noi troviamo in ‘Suttaterra’, il teatro eccessivo, strabordante, barocco e in ultima analisi grottesco delle immagini – un teatro pirotecnicamente macabro, a volte straziato ma subito pronto a ricominciare con gli eccessi – è come la punta dell’iceberg. Vi troviamo mascheroni gotici, icone religiose stranianti, incappucciati, catabasi in sotterranei, figure deformi, proiezioni di film onirici in cinema sinistri, locali notturni da Loggia nera e tanto altro, come in certe sarabande surrealiste di Jean Rollin… Terribile quella Madonna che rivela stigmi diavoleschi, come in certe storie devote medievali dove il Nemico si finge la Madre di Dio e viene smascherato per qualche dettaglio stonato, a strappare brividi onirici da Perturbante. Ma terribile in fondo lo stesso castello (non d’Otranto, ma) di Gela, il Petrolchimico che ne corona il panorama infero.
Insomma un sogno, e un sogno gotico. Ma al di là di una suggestione generale e in fondo generica sul linguaggio dell’onirico e del gotico, nello specifico di ‘Suttaterra’ qual è l’iceberg sottostante? O, fuor di metafora, quale il senso profondo dell’operazione, al di là di una straordinaria (ripetiamolo) operazione linguistica e di un’effervescenza visionaria condita di cultura e intelligenza? Tutto si consuma in un semplice gioco di prestigio letterario?
Direi proprio di no, e in realtà Labbate degli indizi li offre. A partire dall’iniziale citazione da Cioran: “Secondo Origene, gli dèi etnici erano idoli, una sopravvivenza del politeismo; e San Paolo li aveva abbassati al rango di demoni”. Nonostante gli orrori onirici descritti, nonostante il finale feroce dell’apologo, in ‘Suttaterra’ non troviamo un discorso sul Male: i demoni di Giuseppe Buscemi sono “il diavolo” solo in termini di approssimazione allucinatoria, onirica. È molto più credibile vederli come l’espressione parossistica, invertita o piuttosto memore di una complementarietà infera, degli “dei etnici” citati da Cioran, gli dei delle genti e di un paganesimo arcaicissimo ancora radicato nello straordinario tripudio di miti della Sicilia. Nell’’Eneide’, prima della catabasi del protagonista agli inferi, Virgilio chiede agli dei dell’abisso che gli sia “lecito dir cose udite, svelare per vostra potenza / il mondo sotto la terra in tenebra fonda sepolto” (VI, 266-267, trad. Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi 1967). Labbate ha idealmente chiesto una simile licenza di dire il non dicibile: perché il vero tema di ‘Suttaterra’ è appunto – e fin dal titolo – l’indicibile per antonomasia, la morte. La morte di chi è caro, il senso di vuoto che irrompe e il sogno di poter ricevere una lettera da quel passato che non vuole passare (se notiamo, lì sta il cuore dolente di tutto il testo); i sensi sghembi di colpa, con l’inaccettabilità e le rimozioni che fanno da pendant; il peso dei morti – e di un passato che pure è “morto” – sui vivi, come di Razziddu su Giuseppe; la catabasi in un Ade che abbiamo dentro a questionare con la categoria-morte, a contemplarne l’oscenità e la bizzarria. La morte come unico problema materialmente irresolubile per l’homo sapiens: e non è un caso se nel mondo antico i rituali ancestrali sul misterioso rinnovarsi della natura fossero divenuti col tempo rituali per strappare una vita nell’Aldilà. Rituali misterici che permettevano la rivelazione appunto dell’indicibile, attraverso un linguaggio febbricitante di immagini e simboli. Ma se Maria Boccadifuoco è l’Euridice di un Orfeo in piena deriva, se è la Kore rapita non sulla piana di Enna ma a Gela, allora capiamo, i tasselli vanno a posto: la cripticità onirica e il fluire “poetico” hanno un senso ben al di là dell’esperimento linguistico nel rendere la radicale alterità di un’esperienza; il ruolo di mediatore con il mondo ctonio rivestito dal gestore dei morti Giuseppe non è un puro dettaglio nel segno del macabro; la contrapposizione tra Maria e l’altra Maria, l’Alemanna, si rivela come rifrazione di volti diversi di un’unica Grande Dea (come ricorda Graves, Euridice può ben essere il nome della Signora dei morti); la mascherata grottesca, paradossale, volutamente eccessiva racconta insomma la celebrazione di un Mistero pagano, la discesa nel regno dei morti, in piena coerenza coi miti di una Sicilia arcaicissima. Ma coerente anche con il linguaggio delle nostre profondità interiori: la catabasi tra i morti dell’antico eroe è racconto sussurrato di un’esperienza universale e molto concreta, di rilettura della realtà – il rapporto coi morti, con le stagioni ormai morte, con una percezione più acuta della nostra mortalità – a un certo punto della vita.
Ancora Virgilio, con una scelta che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro tra i critici, al termine dell’avventura negli inferi fa uscire Enea e la Sibilla da una delle porte dei sogni, e più precisamente da quella dei sogni fallaci. Walpole capirebbe, e certamente anche Labbate: quel ramo d’oro che è la letteratura deve apparire farlocca, mentire, giocare, usare maschere. Solo così può accennare all’iceberg – quello sì autentico, indicibile per le parole distratte della vita quotidiana – che si spalanca sotto.



