di Giovanni Iozzoli
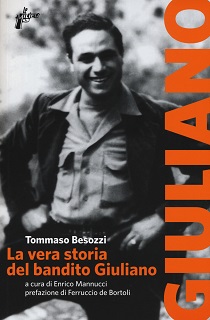 Tommaso Besozzi, La vera storia del bandito Giuliano (a cura di Enrico Mannucci), Milieu edizioni, Milano, 2017, pp. 206, € 15,90
Tommaso Besozzi, La vera storia del bandito Giuliano (a cura di Enrico Mannucci), Milieu edizioni, Milano, 2017, pp. 206, € 15,90
Bene ha fatto Milieu Edizioni a riproporre oggi La vera storia del bandito Giuliano, uno dei libri che, a suo tempo, contribuì alla nascita del giornalismo d’inchiesta in Italia. Lo scrisse Tommaso Besozzi, inviato storico di «Epoca», e quel testo rappresentò una delle prime occasioni in cui una “controinchiesta” giornalistica smontò e sbugiardò la narrazione ufficiale di una vicenda dal grande rilievo nazionale e dalle forti ricadute politiche.
Nell’Italia conformista degli anni ’50, quel libro coraggioso – che sfidava sul campo la versione di Stato, l’acquiescenza al potere, l’omertà diffusa, i pregiudizi e i luoghi comuni – diventerà un esempio per molte altre “controinchieste” (pensiamo a quelle su piazza Fontana) che con il tempo si consolideranno come una specie di genere giornalistico. Nell’Italia appena uscita dal fascismo, nel clima da guerra fredda che si andava stringendo sulle coscienze, il giornalismo critico e indagatore che sbugiarda il potere, ha una sua dinamica dirompente e di forte pedagogia democratica: l’opinione pubblica italiana imparava timidamente che le istituzioni non sono ammantate di sacrale sincerità; possono mentire, depistare, deviare dalle loro funzioni. E coltivare il dubbio e il controllo sul loro operato, non è disfattismo ma sano scetticismo democratico.
Tanto Ferruccio De Bortoli nella prefazione, quanto il curatore Enrico Mannucci – «custode attento e non acritico dell’eredità besozziana» – ci raccontano molto sulla figura di questo vecchio cronista di strada, scorbutico, coraggioso, anticonformista senza esibizionismi, dal linguaggio sobrio ed efficacissimo:
Quello dei grandi inviati che non hanno bisogno di romanzare nulla perché sono in grado di descrivere tutto. Con serietà, con rispetto della realtà, che non piegano ai loro desiderata. Besozzi si mimetizza. Cerca di capire. Non è schiavo di pregiudizi nordici (p. 7).
Ma se lo scopo di questa riproposizione editoriale è celebrare la memoria del cronista e di un giornalismo che non c’è più, il bandito Giuliano non si accontenta di restare mero oggetto di indagine – reclama anch’egli il suo posto nella storia, al fianco di Besozzi, possiamo dire. Tanto che questi due archetipi narrativi – il fuorilegge inafferrabile e il giornalista d’assalto – quasi si rispecchiano l’uno nell’altro, dentro una comune vocazione al declino e al fallimento. Salvatore Giuliano finirà ammazzato per decisione della mafia e della politica, che prima lo utilizzeranno e poi ne disporranno l’esecuzione e Besozzi, il grande inviato, morirà solo, sucida e depresso, in un mondo giornalistico in rapida evoluzione in cui farà sempre più fatica ad inserirsi. Due vite sideralmente diverse, che incrociarono per qualche mese i loro destini nelle campagne siciliane e legarono per sempre i loro nomi.
Quando l’inviato di «Epoca» arriva in Sicilia, dopo Portella della Ginestra, è già un professionista stimato. Il bandito di Montelepre è al culmine del suo effimero potere e della sua notorietà, pesando come una minaccia internazionale «sul prestigio della Repubblica». Giuliano ruba, taglieggia, recluta truppe, spadroneggia su un vasto territorio – cinquemila km quadrati tra borghi e montagne – e trova anche il tempo di farsi intervistare dalla grande stampa estera e lanciare messaggi politici contraddittori – a seconda dei soggetti che lo assoldano o lo strumentalizzano. La strage di Portella segna il suo consapevole arruolamento tra le forze d’ordine – Cosa Nostra, agrari, DC – che combattono senza esclusione di colpi la battaglia anticomunista e antioperaia.
Besozzi fotografa subito il clima diffuso:
gli abitanti della zona erano assolutamente favorevoli a Giuliano, salvo rarissime eccezioni […] E in gran parte era stata proprio la polizia a creare quell’atmosfera, quel rancore, quello spirito di rivolta. Ha usato metodi spietati. Ancora una volta la repressione indiscriminata non aveva risolto nulla, anzi aveva raggiunto l’effetto contrario. La limitazione odiosa e assurda dell’erogazione dell’acqua, la chiusura dei negozi di alimentari che ha costretto donne e bambini a far la fame; le retate in grande stile che riempivano le carceri di Palermo, di Termini Imerese, di Trapani, di Cefalù; il ripristino del confino di polizia in seguito al quale migliaia di persone sono salpate verso le piccole isole (p. 74).
La povera gente condivide il mito fasullo dell’intrepido bandito, fino a non vedere – persino dopo il massacro di Portella – le collusioni e le complicità delle sue bande: forse questa gente preferisce il banditismo e il suo falso alone di riscatto, alla militarizzazione ad opera dei carabinieri, che si comportano come una truppa d’occupazione straniera. L’occhio del cronista è freddo e imparziale; non si autocensura – come tristemente tende a fare il giovane giornalismo contemporaneo -, non teme una narrazione cruda, critica, impietosa.
Il contesto politico della Sicilia post-bellica in cui si muove Besozzi è intricatissimo: i poteri della repubblica poco legittimati, la presenza americana incombente, le suggestioni indipendentiste, sapientemente stimolate da settori atlantici, le lotte sindacali e le occupazioni dei latifondi, il Comando Forze Repressione Banditismo che ha mano libera sul territorio, Cosa Nostra che lascia gli agrumeti e comincia modernizzare il suo business. E tutto un contorno pittoresco di vedove velate e addolorate, centinaia di morti ammazzati, procaci giornaliste americane che filtrano col bandito (e si scopriranno in rapporti con la Cia), la solidarietà di massa dei paesani, schiacciati tra omertà, paura e simpatia. In questi scenari esotici e romanzeschi, l’austero giornalista lombardo si muove con naturalezza, ignorando pericoli e schivando trappole:
Anch’io, naturalmente, ho tentato di raggiungere i briganti di Montelepre nel loro covo, sulla montagna. Ma non ho mai avuto fortuna. Non ho mai visto Giuliano […] pensavo che avrei potuto cercare anch’io di avere un colloquio con il brigante. L’impresa non era poi così rischiosa e difficile come, forse, il lettore si immagina; ma non era affatto spiccia. L’interessamento e la malleveria di personaggi autorevoli e rispettabilissimi mi avevano consentito di iniziare i primi approcci (p. 97)
Per quanto nella sua modestia Besozzi sminuisca il suo lavoro di scavo, quello significava allora fare il giornalista: entrare dentro una storia, andare per vicoli e montagne, sporcarsi le mani e portare a casa un pezzetto di verità in più, rispetto al già noto. Ma non è destino che il Cronista e il Bandito si incontrino in vita: è solo all’obitorio di Castelvetrano che il corpo crivellato di colpi di Giuliano finirà sotto lo sguardo indagatore di Besozzi.
Besozzi sta battendo le stradine di Castelvetrano e le campagne d’intorno, parla con la gente, interroga i possibili testimoni. Troppi particolari non tornano. La versione ufficiale non lo convince. A un certo punto non ci crede proprio più. Chiede tempo alla redazione, vuole controllare, confrontare le dichiarazioni, ripassare al microscopio la ricostruzione proposta dal colonnello Luca (p. 173).
Clamoroso è il titolo del reportage che esce su «L’Europeo» quattro settimane dopo: “Di sicuro c’è solo che è morto”; come a dire , “il caso non è chiuso, siamo pronti a mettere in discussione tutta la versione di regime”.
Il libro La vera storia del bandito Giuliano uscirà poco più tardi e la voce del giornalista, asciutta e disincantata, fotograferà impietosamente quell’Italia dove niente è come sembra: Giuliano non è Robin Hood, non è un eroe romantico ma un vanesio violento e velleitario che ha messo la sua fama al servizio della malapolitica; l’eroica Arma dei Carabinieri ha allestito una messinscena ingloriosa intorno al cadavere del bandito; l’uomo di cui più Giuliano si fidava, l’amico fraterno Pisciotta, lo ha ammazzato nel sonno. E per finire in bellezza, nel corso di un processo:
Gaspare Pisciotta, rivolgendosi al Presidente, aveva annunciato con fortissima voce, d’aver due lettere da consegnare all’autorità […] Vennero alla luce, infatti, due foglietti di carta velina coperti da una fitta scrittura. Erano indirizzate al Procuratore della Repubblica e al Presidente della Corte di Cassazione […] In entrambe Pisciotta diceva che sino ad allora era stato zitto per amor di Patria, su certe questioni, raccattando tre o quattro condanne all’ergastolo, ma nessuno poteva sperare che seguitasse in eterno; che aveva chiesto inutilmente di conferire con una “commissione” su faccende molto delicate; che era stufo di attendere: o qualcuno si decideva a venire da Roma, per ascoltarlo a quattrocchi, o avrebbe spifferato tutto davanti ai giudici e al pubblico. (p. 134)
Un mese dopo quest’episodio Pisciotta moriva all’Ucciardone, a causa di un caffè avvelenato. Chiosa Besozzi, col suo stile inconfondibile: «nello zucchero c’era tanta stricnina che sarebbe bastata ad ammazzare un toro» (p. 135).
Il grande giornalista finirà male – deriva professionale, depressione e infine suicidio: una parabola umana inspiegabile, o meglio spiegabile solo con la misteriosa singolarità delle esistenze individuali. Faceva sempre più a fatica scrivere, colto quasi da una progressiva inadeguatezza alle regole di un giornalismo che stava cambiando velocemente, come tutto il resto. Forse intristito anche da un crescente senso di estraneità per un paese in cui modernità, intrigo e opacità, marciavano di pari passo. Un’altra penna brillante e “antitaliana” – come quella, straordinaria, di Luciano Bianciardi – che si rivelava incompatibile con la nascente industria culturale del neocapitalismo nostrano.
Una manciata di anni dopo, il mito di Giuliano si converte in innocuo oggetto di narrazione turistica a Montelepre. Mentre Tommaso Besozzi, sucida, diventerà il modello di molti i giovani giornalisti di allora che – come lo stesso De Bortoli – pur non avendolo mai conosciuto, sognavano di ripeterne le gesta.
Come in ogni vicenda italiana che si rispetti, restano un mucchio di morti sullo sfondo, a partire dai braccianti di Portella della Ginestra, prime vittime dello stragismo politico-mafioso, sepolti con le loro bandiere rosse e il sogno di un Italia diversa.



