di Gioacchino Toni
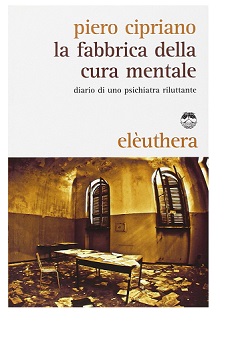 Piero Cipriano, La fabbrica della cura mentale. Diario di uno psichiatra riluttante, Elèuthera, Milano, 2013, 176 pagine, € 14,00
Piero Cipriano, La fabbrica della cura mentale. Diario di uno psichiatra riluttante, Elèuthera, Milano, 2013, 176 pagine, € 14,00
«C’è una frase di De André che sempre mi accompagna nei momenti di maggior conflitto con il mio mestiere: “Chi va dicendo in giro che amo il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo…”. Credo che essere basagliano trent’anni dopo la 180, voler continuare a deistituzionalizzare, a negare l’istituzione del male mentale e dei manicomi, significhi essere un po’ bombarolo. Bombarolo come Basaglia» (Piero Cipriano, p. 56).
Tra il 2013 ed il 2016 Piero Cipriano ha dato alle stampe tre testi importanti a proposito della gestione coercitiva istituzionale di chi è afflitto da sofferenza mentale. Di due dei tre testi che compongono la trilogia ci siamo già occupati in passato: Il manicomio chimico (Elèuthera, 2015) [su Carmilla], che ricostruisce l’avvento dell’era della psichiatria chimica e La società dei devianti (Elèuthera, 2016) [su Carmilla], ove l’aspetto diagnostico è indicato come meccanismo di conferimento di identità e destino all’individuo. Non resta che presentare La fabbrica della cura mentale (Elèuthera, 2013), primo volume della trilogia dello psichiatra riluttante, come ama definirsi Cipriano.
Anche ne La fabbrica della cura mentale, come negli altri libri, l’autore alterna racconti di esperienze vissute in prima persona come essere umano, ancor prima che come psichiatra, all’interno dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, a riflessioni derivate dalla partecipazione a convegni e da letture di saggi e romanzi. Dunque, il testo alterna dati scientifici, esperienze tra i pazienti e storie d’invenzione.
«Se il SPDC [Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura] non è un manicomio io direi che assomiglia a una catena di montaggio. Il manicomio ricordava un campo di concentramento, il SPDC ricorda una fabbrica. Il che è un passo avanti […] Il SPDC è meglio del manicomio. Però guardiamo da vicino, trent’anni dopo la 180, come viene ricoverato nella gran parte dei SPDC d’Italia, un malato con crisi mentale acuta. Come inizia la sua carriera di malato di mente. Come, anche se il manicomio non c’è più, il malato viene ugualmente ridotto a cosa, a un corpo rotto» (p. 31). Al malato che giunge in un SPDC particolarmente agitato, trattenuto da più persone (agenti, infermieri, medici…), viene praticata una terapia sedativa prima di essere ricoverato. Se il malato manifesta (o ha fama) di essere “problematico”, viene legato al letto così, quando si risveglia, rimbambito dai farmaci, si ritrova bloccato da quattro fasce e capisce che è meglio “non disturbare”, che conviene adeguarsi alle regole del reparto, ai suoi orari ed ai suoi rituali. Una volta data prova di sottomissione, il paziente (paziente per forza), accompagnato, può uscire dalla porta del reparto costantemente chiusa ma se non si è “normalizzato a sufficienza”, anche nel caso si sia presentato in reparto volontariamente, il ricovero si trasforma praticamente in TSO.
Una volta dimesso, nel caso il paziente si dimostri ancora “grave e pericoloso”, «va in una Casa di cura Convenzionata, a far ricchi gli imprenditori della follia. Lì passa uno, due o tre mesi con l’autorizzazione del medico del Centro di Salute Mentale (CSM), così nel frattempo respira […] Prima o poi, però, esce anche dalla Casa di Cura e deve essere ripreso in carico dal CSM. Purtroppo, tranne eccezioni virtuose, è il paziente che deve raggiungere il CSM, dato che gli operatori non si possono muovere per andare al suo domicilio perché sono pochi o non ci sono le macchine o per altri motivi […] Per cui, dopo un po’, il paziente addomesticato si inselvatichisce di nuovo e si dà alla macchia […] dopo qualche settimana o mese, quello ritorna in crisi acuta in SPDC, perché i parenti o i vicini hanno chiamato il CSM […] e ricomincia il gioco della porta che gira» (pp. 32-33).
È terrificante. Ma è così che funziona la fabbrica della cura mentale. «Il SPDC è una fabbrica. Il primario è il direttore della fabbrica. Che ha una catena di montaggio a cui badare. Uno Psichiatra è un tecnico specializzato addetto a questa specie di catena di montaggio umana, dove il malato è la macchina biologica rotta, che deve essere aggiustata non con la parola, con la relazione o con un po’ d’umanità, ma con il farmaco» (p. 33).
Già, la psichiatria chimica si sostituisce alle parole perché queste, continua Cipriano, gli psichiatri le conservano «per il pomeriggio, per lo studio privato, per i pazienti più danarosi, meno gravi, meno malati, meno sporchi, più colti, quelli più piacevoli da vedere (della stessa classe sociale del terapeuta, si sarebbe detto in altri tempi). In SPDC basta il farmaco. E se non basta ci sono le fasce» (p. 33). Ma se farmaco e fasce non bastano, ecco che «il paziente viene inviato di soppiatto, senza dirlo troppo in giro, in qualche casa sicura attrezzata per la terapia elettrica, terapia che […] se non altro toglie la memoria e la consapevolezza di sé» (p. 33). Grazie l’elettrochoc il malato viene internato per qualche mese ed il medico può rifiatare in attesa di ritrovarselo alle porte del reparto.
Cipriano dedica qualche pagina al lessico adottato dai medici; un linguaggio incomprensibile ai più che contribuisce a mantene i camici bianchi unici depositari del “segreto della salute e della malattia” ed intanto ai tirocinanti viene insegnato a riconoscere i sintomi, così da poter collocare il caso in un quadro clinico al fine di formulare una diagnosi, quella diagnosi che, come ottimamente spiegato dal Nostro psichiatra riluttante nel volume La società dei devianti, conferisce identità e destino all’individuo.
Tornando ai Dipartimenti di Salute Mentale italiani, sostiene Cipriano, la Legge 180 del 1978 è male applicata in buona parte di essi, visto che, in molti casi, non viene messa in discussione la centralità del ricovero, il primato della clinica rispetto ai luoghi della vita delle persone. Roberto Mezzina, psichiatra del DSM triestino, denuncia questa logica sottolineando come non vi sia alcuna necessità scientifica di confinare l’individuo in un luogo se non lo si concepisce come “corpo da custodire” affinché questo venga controllato e “riparato” prima di restituirlo al corpo sociale. Dunque, aggiunge Cipriano, si tratta di un’operazione di controllo e «per far sì che la questione del controllo sociale dell’emergenza urbana non si concluda inevitabilmente con l’arrivo nel luogo magico del pronto soccorso, e con il passaggio ultimo e definitivo nel SPDC, è necessario ripensare i servizi territoriali, i cosiddetti Centri di Salute Mentale, spesso ridotti a meri ambulatori dove si prescrivono psicofarmaci» (p. 38).
Cipriano indica alcuni esempi alternativi di trattamento dei malati; tra questi i CSM aperti ventiquattro ore al giorno triestini, che ospitano i pazienti in luoghi aperti basati sulla relazione e non sull’internamento coatto, e il modello di cura alternativo Soteria, ideato dallo psichiatra americano Loren Mosher, basato su un’abitazione ospitante un numero ridotto di individui affetti da primi episodi di psicosi in cui non si ricorre ad alcuna etichetta nosografica e, soprattutto, si selezionano gli operatori in base alle loro caratteristiche di empatia e disponibilità. Tra i motivi della scarsa diffusione di tali modalità di cura alternative, Cipriano indica come secondo alcuni psichiatri critici «il vero motivo del dogma della farmacologizzazione precoce delle psicosi è la forte collusione [degli operatori e delle istituzioni] con le multinazionali dei farmaci e le università, grazie alla quale si è mantenuta, in cinquant’anni di psicofarmacologia, la stessa approssimazione degli anni Sessanta» (p. 40). È talmente strutturata l’idea che terapia psichiatrica significhi somministrazione di psicofarmaci che lo psichiatra che anche solo diminuisce la terapia farmacologica ad un paziente, rischia di essere condannato da un tribunale. «Basaglia sosteneva che gli psicofarmaci servono a sedare, più che il malato, l’ansia dello psichiatra» (p. 42).
Nel volume ci si sofferma anche sulla pratica del legare i pazienti con disturbi psichici. Pratica che, nonostante non sia menzionata dai libri di psichiatria, continua ad essere diffusamente praticata. Il ricorso alle fasce di contenzione, secondo Cipriano, è diffuso anche a causa di carenze legislative ma questo non basta a spiegare il fenomeno. Nemmeno la motivazione economica (legare costa meno che aumentare le risorse umane nei reparti), secondo lo psichiatra riluttante è sufficiente a spiegare il diffuso ricorso a tale pratica. Probabilmente si tratta di «una questione di etica e di cultura» (p. 53). Occorrerebbe cambiare la testa degli operatori.
«Quando un matto agitato viene catturato dalle forze dell’ordine, ammanettato e portato nel pronto soccorso di un ospedale, e lo psichiatra non fa altro che sostituire le manette con le sue fasce, ecco, in quel caso non ha fatto lo psichiatra, ma ha fatto il poliziotto, si è adeguato alla misura poliziesca, ha fatto l’antipsichiatra, insomma. Per cui io ribalterei la vecchia dicotomia degli anni Settanta tra psichiatria e antipsichiatria. Il vero antipsichiatra per me non è colui che ricusa le fasce, ma è colui che lega; viceversa, il vero psichiatra non è colui che lega, ma colui che non accetta di adoperare le fasce» (p. 54).
 Riflettendo sul ricorso alla contenzione da parte di tanti operatori, Cipriano riprende le riflessioni di Hannah Arendt circa la banalità del male; in effetti, sostiene, questi operatori che ricorrono alle fasce non sono sadici torturatori, eppure lo fanno. Riprendendo e parafrasando brillantemente l’incipit di Anna Karenina di Lev Tolstoj – “Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo” – Cipriano giunge alla conclusione che «ogni psichiatra che non lega si assomiglia; e non lega per un motivo molto semplice, perché ha compreso che non è giusto, non è terapeutico, anzi è antiterapeutico, è una tortura, è un crimine. E per questo è felice […] uno psichiatra che non lega è felice. Viceversa, ogni psichiatra che ritiene giusto, utile, terapeutico legare un altro uomo “è infelice a modo suo”» (p. 55). In tale varietà di “infelici” c’è chi lega per paura, chi perché è autoritario, chi perché semplicemente lo ha sempre fatto senza chiedersi nulla, chi perché di notte in reparto vuole dormire, chi perché non conosce bene i farmaci e via dicendo. Gli infelici legano per tanti diversi motivi. «Gli psichiatri felici, invece non legano. E non legano per un solo motivo» (p. 55).
Riflettendo sul ricorso alla contenzione da parte di tanti operatori, Cipriano riprende le riflessioni di Hannah Arendt circa la banalità del male; in effetti, sostiene, questi operatori che ricorrono alle fasce non sono sadici torturatori, eppure lo fanno. Riprendendo e parafrasando brillantemente l’incipit di Anna Karenina di Lev Tolstoj – “Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo” – Cipriano giunge alla conclusione che «ogni psichiatra che non lega si assomiglia; e non lega per un motivo molto semplice, perché ha compreso che non è giusto, non è terapeutico, anzi è antiterapeutico, è una tortura, è un crimine. E per questo è felice […] uno psichiatra che non lega è felice. Viceversa, ogni psichiatra che ritiene giusto, utile, terapeutico legare un altro uomo “è infelice a modo suo”» (p. 55). In tale varietà di “infelici” c’è chi lega per paura, chi perché è autoritario, chi perché semplicemente lo ha sempre fatto senza chiedersi nulla, chi perché di notte in reparto vuole dormire, chi perché non conosce bene i farmaci e via dicendo. Gli infelici legano per tanti diversi motivi. «Gli psichiatri felici, invece non legano. E non legano per un solo motivo» (p. 55).
La tortura è ovviamente qualcosa di diverso da un ricovero psichiatrico ma, afferma Cipriano, il rapporto che lega torturato e torturatore a volte non è poi così diverso dal rapporto tra il ricoverato in un SPDC e lo psichiatra che lo lega al letto. A tal proposito l’autore de La fabbrica della cura mentale riprende alcune considerazioni sulla tortura di Françoise Sironi (Persecutori e vittime) provando a confrontarle con la psichiatria coercitiva. Ecco allora che la domanda “Come si può curare chi è stato vittima di torture?”, pensando ad un paziente ricoverato in maniera coatta, magari legato e sedato, può diventare: “Come può la psichiatria curare una vittima della psichiatria?”. Oppure, se a proposito della tortura Sironi mette in luce il suo essere un’esperienza incomunicabile, avvolta dal silenzio sia da parte di chi la pratica che di chi la subisce, di cui si può, eventualmente, avere informazioni soltanto dalle testimonianze delle vittime, non molto diversa è la situazione dei ricoveri psichiatrici; chi è stato legato al letto ripetutamente per giorni e giorni, difficilmente può essere testimone dell’accaduto anche a causa della poca credibilità che gli viene concessa. In tal caso la coltre di silenzio può essere infranta solo da qualche operatore dissenziente. Altro esempio di analogie è dato dal fatto che nelle pratiche della tortura non di rado si ricorre al terrore generato dal costringere i torturati ad assistere alla tortura di altri prigionieri. Ebbene, continua Cipriano, nei reparti psichiatrici i pazienti si trovano ad assistere al bloccaggio ed alla contenzione di altri ricoverati e tutto questo non può che generare in essi il terrore che ciò possa accadere anche a loro se non si comportano secondo le regole del reparto. Oppure, ancora, nelle prigioni spesso si alternano carcerieri buoni a carcerieri cattivi esattamente come accade nei reparti psichiatrici. Nelle galere è prevista la medicazione non terapeutica a scopo punitivo, pratica diffusa anche nei reparti psichiatrici e così via…
Sul finire del libro, Cipriano, riprendendo il triste caso dell’anarchico Franco Mastrogiovanni – a cui l’autore ha fatto riferimento anche nel suo scritto “Lo specialista pericoloso” [su Carmilla] -, riflette amaramente sul ruolo che lo psichiatra si trova a ricoprire di questi tempi. «Siamo meri esecutori dei crimini in tempo di pace. Perché fuori facciamo i comunisti, i progressisti, ci iscriviamo ad Amnesty International, votiamo Sinistra, Ecologia e Libertà o Partito Democratico, compriamo “La Repubblica”, “il manifesto”, “L’Unità” o “Il fatto quotidiano”, siamo contro i leghisti che vogliono gli stranieri fora da le bal. Ma quando siamo in camice, dentro al nostro ospedale, dentro al nostro reparto psichiatrico, diventiamo carnefici come il potere ci vuole. E leghiamo la gente. E la chiudiamo dentro. E la sorvegliamo e la puniamo. Fora da le bal allo strano, al diverso, all’alienato. Nella nostra pratica professionale non siamo più comunisti, progressisti, democratici, tolleranti, ma perfetti fascisti» (p. 158).



