di Piero Cipriano
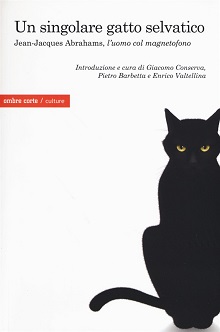 Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina (Introduzione e cura di), Un singolare gatto selvatico. Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono, Ombre Corte, Verona, 2017, pp. 152, € 14,00
Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina (Introduzione e cura di), Un singolare gatto selvatico. Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono, Ombre Corte, Verona, 2017, pp. 152, € 14,00
Un singolare gatto selvatico, sottotitolo Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono, libro a cura di Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina, edito da Ombre Corte, è un libro che mi ha incuriosito molto, ma non certo perché ho a cuore le sorti della psicanalisi, di cui non mi importa granché, ma perché sapevo che entrambi i miei demoni, il demone della letteratura selvaggia Roberto Bolaño e il demone della psichiatria critica e antistituzionale Franco Basaglia, in qualche modo, si erano occupati di Abrahams.
Abrahams
Chi è Abrahams? Riassumo la sua storia assurda.
Nasce nel 1935 da una più che agiata famiglia ebrea, figlio di un importante avvocato. Durante la guerra fuggono negli USA, studia in inglese, studente brillante, maturità a sedici anni, vuol diventare pilota ma i genitori lo inducono a scegliere giurisprudenza. Si laurea ciononostante a soli ventun anni, il più giovane avvocato del Belgio, lavora con il padre, da cui non viene pagato. Eppure il suo primo caso giudiziario è un successo, potrebbe diventare più bravo del padre. Invece a trentun anni, 1966, l’anno prima di brandire il magnetofono contro il suo ex analista, interrompe l’attività di avvocato. E perché andava da un analista? Chi lo sa. Suo padre, a quattordici anni, lo obbliga. Non sappiamo perché, sappiamo che Abrahams vive questa imposizione come un “assalto alla sua giovinezza”. Per quindici anni, dai quattordici ai ventinove, dal 1949 al 1964, si reca due tre volte a settimana in analisi. Io avrei vissuto questa imposizione come una tortura, un TSO, o meglio, un Trattamento Psicanalitico Obbligatorio, dove il proponente è stato il padre e il convalidante l’analista.
Nel dicembre del 1967, a 32 anni, Abrahams diventa il paziente selvaggio, o il gatto selvaggio, per dirla con gli autori di questo libro, e irrompe col magnetofono nello studio del suo ridicolo analista.
Il dialogo psicanalitico, come lo chiama Abrahams, è eloquente, e fa bene Sartre a pubblicarlo.
Una settimana dopo, il ridicolo analista lo fa internare in manicomio. Con la collaborazione del padre (ancora lui) e del fratellastro di Abrahams (scherzo della sorte, anch’egli psicanalista) (per cui a questo punto sono tre i soggetti che internano Abrahams). Dopo una settimana Jean-Jacques fugge, ma verrà ricoverato altre tre volte.
Dopo inizia una nuova vita da poeta/drammaturgo/vendicatore/utopista selvaggio bolañiano. L’anno dopo il gesto del magnetofono e tre ricoveri, nel 68, scrive una lettera alla rivista di Sartre, Les Temps Modernes, racconta la sua rocambolesca fuga dal terzo piano del manicomio con frattura di una mano, gli propone di pubblicare la trascrizione della registrazione al magnetofono, a cui dà il titolo provocatorio Il dialogo psicanalitico. In seguito scriverà di teatro, dove trasferisce la sua utopia di democratizzare il rapporto tra analista e paziente: anche qui ambisce alla scomparsa di ogni differenza tra vita e teatro, tra attori e spettatori, che scompaiano i rapporti di potere. In uno spettacolo dal titolo Rappresentazione critica dell’Edipo re si rivolge al pubblico, per aiutarlo a scoprire la verità sul mito di Edipo, metterlo in guardia rispetto a questa storia, la più terrificante di sempre, e lo fa deridendo ancora una volta il discorso psicanalitico, promette di svelarne i segreti, di rivelare ciò che c’è da sapere su castrazione identificazioni catarsi sublimazione eccetera. Il messaggio è: non c’è stato nessun parricidio, non c’era bisogno di farne una tragedia. D’altra parte, la sua vita dimostrava che se c’era stato un tentativo di far fuori qualcuno, era di figlicidio che si doveva parlare, il figlicidio di suo padre nei suoi confronti, non il contrario.
Abrahams ha un problema con la paternità ma ama sua madre, al punto che quando muore la disseppellisce (per imbalsamarla) e per giorni guida per Bruxelles con la salma. Qui sembra un folle conclamato, o un perfetto personaggio bolañiano. E’ talmente convinto che i rapporti tradizionali nella famiglia debbano cambiare, che quando nasce suo figlio lo chiama Yahveh (padre di tutti gli esseri umani).
La sua attività artistica si conclude nei primi anni 80, in seguito a un avvelenamento da monossido di carbonio. Un suicidio mancato?
Bolaño
Sì ma che c’entra Bolaño? Bolaño cita Sophie Podolski, amica di Abrahams, che a sua volta ha vissuto e ha lavorato nel centro di ricerca di Montfaucon, sorta di comunità hippy, e la cita in Anversa, che non è un libro qualsiasi ma un libro assurdo, al limite dell’illeggibile, peraltro il primo libro narrativo scritto da Bolaño, lo scrive nel 1980, quando lui, ventisette anni, migra dal Messico alla Spagna, migrazione che segna pure il suo passaggio dalla poesia alla narrativa. Infatti Anversa è un ibrido, non si capisce molto, non capisci neppure perché il titolo sia Anversa, se non nel capitolo intitolato Anversa, dove Bolaño descrive un incidente, tra un camion carico di maiali e un’auto, in cui muoiono sia l’autista che alcuni suini. In questo libro più volte Bolaño nomina questa giovane poetessa di un solo libro, che somiglia maledettamente ai poeti messicani protagonisti de I detective selvaggi, libro che lui pubblicherà qualche anno dopo e che è, probabilmente, il suo capolavoro (insieme a 2666). Sophie Podolski kaput, scrive. Ma allora cosa c’entrano Podolski e Abrahams con Bolaño? C’entrano che entrambi avrebbero potuto entrare, a pieno titolo, tra i personaggi bolañiani, far parte di quegli assurdi poeti messicani che si autonominarono infrarealisti (ne I detective selvaggi li chiama visceralisti). L’infrarealismo era la terza via, tra la poesia del cileno Pablo Neruda, che consideravano una squallida poesia politica comunista marxista, e la poesia del messicano Octavio Paz, una asettica poesia nascosta in una torre d’avorio, loro inseguivamo Nicanor Parra. Loro scopo era mettere in discussione l’autorità del poeta padre, Paz e Neruda, la Poesia mainstream latinoamericana che visceralmente contestavano, e pure loro come Abrahams cercavano, forse, la madre: la poetessa Cesària Tinajero. E come questi poeti l’ex analizzando Abrahams, l’ex brillante avvocato diventato teatrante, prova a mettere in discussione l’autorità del padre, il suo psicanalista, e l’intera Psicanalisi ortodossa, quella pratica claustrofilica che ama restare chiusa nella sua chiesa, nel suo confessionale.
Dunque, Abrahams e Sophie Podolwski suscitano l’interesse di Bolaño perché somigliano molto ai suoi poeti selvaggi messicani, poeti che piuttosto che scrivere poesia vivono da poeti, la cui esistenza selvaggia è una continua e costante performance, e non scrivono quasi per niente poesia, e non pubblicano quasi niente. Abrahams è uno di loro. Scrive per stralci, dà i propri scritti a qualche editore, dice fatene ciò che volete.
Basaglia
Dunque gli autori di questo libro tirano dentro Bolaño, che c’entra poco e niente, diciamolo, e non si occupano affatto del punto di contatto tra Abrahams e Basaglia, almeno una citazione. Zero. Eppure Sartre lo suggerisce, nel testo con cui perora Il dialogo psicanalitico sulla sua rivista Les Temps Modernes, quando afferma che, soprattutto in Italia Abrahams troverebbe validi interlocutori, giacché è qui che “una nuova generazione di psichiatri” (e a chi può mai riferirsi, se non a Basaglia?) “cerca di stabilire con le persone che cura un legame di reciprocità… psichiatri che rispettano prima di tutto in ogni malato il soggetto, la libertà deviata di agire”.
Basaglia cita Abrahams ne Le conferenze brasiliane. Quando dice: dal punto di vista del sapere lo psichiatra è il medico più ignorante: non sa niente ma compensa questa carenza con il potere. Nel manicomio questo è evidente. Ci sono poi i vari psicanalisti, psicoterapeuti, psichiatri ecc. ognuno tenta di dare una risposta a quello che è la malattia mentale, ma se noi parlassimo con ciascuno separatamente ci sentiremmo dire che non sanno cos’è la follia, e ciascuno ammetterà anche che la relazione con il paziente è una relazione di potere. L’esempio dello psicoanalista è il più tipico. Su questo problema del dominio dello psicanalista sullo psicanalizzato Abrahams discute in L’uomo col magnetofono. Un giorno un paziente va dallo psicanalista con il registratore e dice: questa volta chi fa la psicoanalisi sono io, lei è il paziente e io lo psicanalista. Lo psicanalista resta sorpreso, cerca di dissuaderlo, ci convincerlo a riprendere il suo posto, siccome il paziente si rifiutava, lo psicanalista prese il telefono e chiamò la polizia.
L’utilizzo che Basaglia fa di Abrahams, per dimostrare che la psicanalisi, non meno della psichiatria (da cui non si distingue così tanto, in termini di potere) è una pratica oppressiva, lo trovo molto interessante. A me questo bizzarro uomo col magnetofono non interessa tanto per il contributo che vuol portare alla critica della psicanalisi, o al miglioramento della psicanalisi. E a questo proposito, trovo interessante ciò che scrive, in questo libro, Antonello Sciacchitano. L’analisi, ci ricorda Sciacchitano, tendenzialmente produce paranoia, e (come la performance di Abrahams dimostra) ciò accade non solo nell’analizzato, ma anche nell’analista. E’ proprio la lunga formazione psicanalitica che induce, nella personalità dell’analista, elementi di rigidità paranoica. Sono, le “sovrastrutture ideologiche, scafandri che le istituzioni psicanalitiche smerciano come formazione psicanalitica e che lo psicanalista adotta per addomesticare la realtà selvaggia della clinica” (i complessi edipici freudiani gli archetipi junghiani i significanti lacaniani e così via). Il punto dolente del freudismo, continua Sciacchitano, è che resta un’analisi che tende a rinforzare l’Io di fronte alle pulsioni dell’Es e ai dettami cervellotici del Super-Io: ma ciò spinge l’Io verso la paranoia. E’ frequente, infatti, che le analisi freudiane finiscano in paranoia: l’Io debole dell’analizzato, dopo l’analisi si sente così forte da analizzare l’analista: è Abrahams questo.
Dunque personalmente mi ritengo fortunato per non aver risposto alle sirene di questa disciplina, tanto superba quanto sopravvalutata, ho sempre contestato gli psicanalisti, claustrofilicamente chiusi nei loro studi d’avorio, staccati dalla vera sofferenza, dalla miseria, dalla merda, dalla feccia umana. Dai manicomi insomma, d’ogni sorta. Dalla sofferenza hard. Dalla miseria esistenziale di “chi non ha non è” (diceva Basaglia).
Sembrano anacronistiche ma le ritengo ancora valide certe affermazioni di Basaglia nel corso delle sue straordinarie conferenze in Brasile, a proposito del mondo della psicanalisi. Eccone alcune.
“Io non voglio offendere nessuno, ma qual è la differenza tra una prostituta che vende il suo corpo e il medico che si prostituisce nel suo ambulatorio, quando dovrebbe dare il massimo della sua attività alle istituzioni pubbliche?” “Gli psicanalisti”, aggiunge, “hanno sempre una gran lista di attesa, come gli aeroplani”. Perché? Perché gli psicanalisti rispondono ai problemi di quella parte della popolazione che ha i mezzi per difendersi, e non certo ai bisogni dei miserabili, perché “chi non ha non è”, chi non ha il danaro non se la può pagare la terapia psicanalitica. Perché la psicanalisi è “terapia di classe”, “cosa ha fatto la psicanalisi per il malato mentale del manicomio nel corso di questo secolo?”
Affermazioni forti, apparentemente datate, ma non tanto. E’ a margine di queste affermazioni e di questa critica della psicanalisi che, nelle conferenze in Brasile, Basaglia cita Abrahams. E lo cita come esempio del potere e della repressione non solo psichiatrica ma perfino psicanalitica.
Ma perché questo dialogo affascina Basaglia, così come affascina Sartre? Perché capovolge i rapporti tra analista e analizzando, capovolge il rapporto di potere tra i due, e la violenza, che c’è, perché c’è, passa dall’altra parte. Lo psicanalista ridicolo, incapace di gestire l’irruzione nel suo studio del paziente col magnetofono, grida “Violenza fisica! Violenza fisica! Non sono abituato alla violenza fisica!”, così grida. A quella psicologica invece evidentemente ci è abituato, quella per cui obbligare per anni a stare steso sopra un lettino girato di spalle senza poter guardare l’espressione del volto del cosiddetto analista, depositario del segreto, della verità, del tempo della guarigione. Alla violenza dell’interminabile asimmetrica relazione psicanalitica a quella ci è abituato.
Dice Abrahams, nella sua registrazione: “Non si può guarire là sopra – al divano intende – e lei stesso non è guarito perché ha passato anni là sopra. Lei non osa guardare la gente in faccia. Lei mi ha obbligato a voltar le spalle e non è così che si può guarire la gente. Vivere con gli altri significa saperli guardare in faccia”.
Continua: “Sono venuto da lei per molti anni due o tre volte a settimana e cosa ne ho ricavato? Lei ora sta raccogliendo quello che ha seminato con la sua ingannevole teoria”.
Ancora: “Lei è un privilegiato, è venuto dopo di Freud, le hanno pagato gli studi, ed è riuscito a mettere una targa sulla porta! E adesso rompe le palle a un sacco di persone con il diritto di farlo. Lei è un fallito e non farà altro nella vita che rifilare i suoi problemi alle persone…”.
Ecco: uno psicanalista che a queste affermazioni riesce a balbettare solo: “Violenza fisica! Violenza fisica!” conferma di essere davvero un fallito.
Ma a cosa somiglia questa violenza, istituzionale, dello psicanalista e della psicanalisi che Abrahams contesta? Ce lo racconta Basaglia. Somiglia, in scala ridotta, in versione soft, edulcorata, alla violenza che riceve l’internato in manicomio (o, ancora oggi, del ricoverato in molti SPDC o in altri luoghi della psichiatria).
Scrive Basaglia, ne L’istituzione negata, che nel manicomio entra un corpo malato, già messo a dura prova dalla follia, già indebolito. Ma quando inizia questa sua carriera di malato mentale, e varca la soglia dell’istituzione, del manicomio, e penetra in quel luogo dove “prima di uscire sono state controllate serrature e malati”, là dove il corpo malato dell’internato è un suppellettile che ha lo stesso valore di una serratura, il corpo del malato diventa oggetto e (per dirla con le parole di Husserl) smette di essere leib, corpo vissuto, corpo soggetto, corpo che sono, e diventa körper, corpo non più vissuto, corpo oggetto, corpo che ho. E quale possibilità ha l’internato del manicomio, per riprendersi quel poco di soggettività, riprendersi il suo corpo vissuto, il corpo proprio, se non agire, agitarsi, reagendo, con la sua violenza (una violenza apparentemente immotivata, ingiustificata, inopinata, come sempre viene considerata la violenza del folle), alla violenza dell’istituzione manicomiale che ha oggettivato il suo corpo?
Eccoli, allora, questi corpi obbligati dei malati, vengono depositati con violenza ancora oggi dentro la maggior parte dei SPDC, che per riprendersi un po’ di quella soggettività che gli viene estorta dall’istituzione, e tornare a essere leib e non körper, s’incazzano, si insubordinano, diventano agitati, aggressivi, e quasi sempre la risposta dell’istituzione, del SPDC bunker, del servizio forte, blindato, è un rilancio, un’escalation della violenza iniziale, per cui ecco l’uso del farmaco a scopo non terapeutico (sedare) e ecco l’uso delle fasce.
Ma lo scriveva chiaro Franca Ongaro: la medicina è la scienza del corpo morto, scienza che ha cercato di comprendere, nelle aule di anatomia patologica, l’uomo vivo, il malato, attraverso il corpo morto del cadavere. E pure l’ospedale, il luogo di cura per definizione, riproduce il corpo morto dissezionato del cadavere, coi suoi reparti per lo scheletro, per l’apparato digerente, respiratorio, cardiovascolare, eccetera. E in ospedale l’uomo vivo è gradito sempre allettato, clinofilo, perché la clinica è corpo morto, e pure nel reparto psichiatrico, deputato alla cura della psiche malata, il corpo è quasi sempre orizzontale, cadaverico, grazie al ruolo clinofilo di farmaci e fasce.
Allora non solo la psichiatria paga il debito con la medicina e l’anatomia patologica ponendo in posizione cadaverica il paziente (allettandolo con farmaci e fasce quando si agita, quando vuol essere per forza soggetto), ma anche la psicanalisi (con più classe, con più garbo, certo) fa la stessa cosa, data la sua derivazione medica (ce lo ricorda sempre Sciacchitano in questo libro, che la psicanalisi deriva dall’ipnosi, ipnosi che Freud non fu mai abile a fare, e perciò dovette inventarsi un altro modo), altro non ha fatto, la psicanalisi, se non tenere a corpo morto un soggetto, per anni, rendendolo, a volte (sostiene provocatoriamente ma non tanto il maggior etnopsicologo vivente: Tobie Nathan) uno zombie, un morto vivente, qualcuno ormai posseduto dalla teoria del suo analista.
Per cui la violenza di Abrahams per forza mi ricorda, in forma soft, la violenza dell’internato, anzi, ne è preludio, visto che è da quel momento in poi che il selvaggio Abrahams farà un salto di livello, di carriera, passando dalla carriera di portatore di piccola psichiatria alla carriera di malato grave di manicomio, di ricoverato in manicomio, di rocambolesco evasore dal manicomio.
E la piccola violenza di Abrahams, pure questa è un modo per riprendersi il proprio corpo, e riportarlo dalla posizione clinica, psicanalitica, cadaverica e paranoicizzante che non vede mai gli occhi e i pensieri dell’analista, a quella eretta, vitale, di uomo che guarda negli occhi, di uomo in rivolta, potremmo quasi dire (per dirla con Camus).



