di Armando Lancellotti
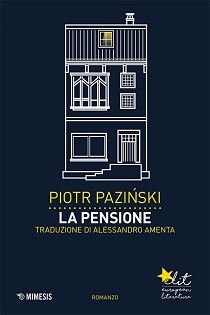 Piotr Paziński, La pensione, Mimesis, Milano – Udine, 2016, pp.176, € 12,00
Piotr Paziński, La pensione, Mimesis, Milano – Udine, 2016, pp.176, € 12,00
La pensione è un romanzo che il polacco Piotr Paziński – prima saggista, critico letterario, giornalista e da ultimo narratore – ha scritto nel 2009 e con cui ha vinto il Premio Letterario dell’Unione Europea nel 2012 e che recentemente è stato tradotto e pubblicato per i lettori italiani dall’editore Mimesis. Scelta condivisibile ed apprezzabile quella di proporre questo breve romanzo che narra l’esperienza – in parte autobiografica – del protagonista-narratore che, poco più che trentenne, ritorna nel luogo in cui da bambino trascorreva le vacanze in compagnia della nonna: una pensione nei pressi di Varsavia, vicino alla Vistola, frequentata dagli ebrei della stessa capitale polacca, o meglio, dai pochi scampati agli orrori della guerra e dello sterminio.
Si tratta, pertanto, di un viaggio nella e della memoria e proprio questo costituisce uno degli aspetti più interessanti del romanzo: come un giovane autore polacco ebreo, agli inizi del XXI secolo, affronti e tratti una materia così densa, grave e complessa quale è la memoria dell’ebraismo polacco. Una problematicità che non riguarda soltanto il contenuto del percorso mnestico messo in atto dal romanzo, che intreccia diversi piani e prospettive temporali – i ricordi di infanzia di un giovane di oggi che contengono quelli dei clienti anziani della pensione di un tempo, a cui si aggiungono le memorie degli ospiti incontrati nello stesso luogo trent’anni dopo – ma investe anche le modalità e le tecniche narrative adeguate ad esprimere e raccontare siffatta complessità.
Paziński sceglie uno stile di scrittura franto e discontinuo che dà luogo ad una successione di brevi capitoletti, senza titolo o numerazione, per lo più scuciti tra loro, cioè privi di uno sviluppo e di un intreccio precisi, fatta eccezione per l’avvicendarsi casuale degli incontri con gli ospiti della pensione che fungono da innesco del processo di emersione del passato. La lunga frequentazione dell’Ulisse di Joyce, gli studi e i saggi compiuti da Paziński sullo scrittore irlandese influiscono sulla scelta dell’autore de La pensione di praticare talvolta la tecnica del monologo interiore e della trascrizione dei pensieri che liberamente scorrono senza un ordine una volta che, data la stura al fluire della memoria, le immagini, le parole, i visi, le situazioni del passato e le riflessioni e le considerazioni nel presente si affastellano e si sovrappongono nella mente dell’Io narrante.
I ricordi e le immagini del passato emergono improvvisamente e casualmente come i pacchetti di cartoline, fotografie, biglietti, lettere, ritagli di giornale conservati in una scatola con cura da antiquario e gelosa devozione dalla signora Tecia – vecchia amica della nonna del protagonista, la signora Bronka – nella inconsapevole attesa che prima o poi arrivasse qualcuno a cui poter mostrare quel prezioso scrigno di detriti del passato.
La signora Tecia sciolse il fiocchetto e sollevò il coperchio. Dentro, stretti come sardine, infilati uno accanto all’altro, c’erano dei pacchettini di carta. Sembravano delle mummie in miniatura, come se i loro proprietari non avessero mai lasciato la casa della schiavitù: ogni pacchettino era avvolto in un giornale e legato con un elastico, i più grandi con due elastici incrociati, per ogni evenienza, non si poteva mai sapere. «Attento a non mischiarli!», avvertì la signora Tecia. «Meglio se te li mostro io». Dentro il primo pacchetto, sotto uno strato di giornali, ce n’era un altro. Quanti anni erano passati? La data si poteva stabilire facilmente. Życie Warszawy, «Riunione del direttivo del voivodato», «Resoconto del compagno K.». Incartati secoli prima. Ognuno di questi pacchetti era un paradiso in miniatura per un archeologo. […] Come faceva la signora Tecia ad avere quelle cartoline? «Non lo so, non ricordo. Raccoglievamo tutto quello che era rimasto dopo la guerra», disse, iniziando forse a pentirsi di avermi mostrato la scatola. (pp. 27-28)
È un luogo triste ora la pensione dove il protagonista-narratore ritorna e dove si recava da bambino per le vacanze – e forse già lo era allora, a fine anni Settanta, seppure non nella consapevolezza e nella percezione di un bambino, uno dei pochi lì presenti in compagnia di anziani ebrei di Varsavia – è un luogo abitato da persone evanescenti come i loro ricordi e quelli che evocano nel protagonista che con loro si intrattiene. Un albergo per ebrei, presso Otwock, raggiungibile con la “linea ferroviaria della Vistola”; una verde regione di boschi non lontano dalla capitale, dove negli anni tra le due guerre la borghesia di Varsavia, tanto gli ebrei quanto i goyim, piacevolmente alloggiava in pensioni accoglienti, senza prestare troppa attenzione a ciò che si stava avvicinando, una catastrofe simbolicamente preannunciata dai tubercolotici ricoverati nei vicini sanatori e luoghi di cura immersi nei medesimi boschi prossimi alla pensione.
E proprio in quel luogo ritornano i pochi scampati alle camere a gas, nel tentativo non solo di ripristinare una parvenza di vita normale, ma anche di trattenere, di conservare nella memoria dei sopravvissuti le tracce del mondo di “prima della guerra”. È un’opera immane di resistenza al lavoro di sottrazione che compie il tempo, come lo è ogni atto di memoria, ma ancora più difficile, al limite della impossibilità, quando – come in questo caso – si tratta di colmare con il ricordo una voragine aperta nella continuità della vita e del tempo dalla Storia e dai suoi orrori, quelli che hanno travolto il popolo dei circa 3 milioni di ebrei che vivevano in Polonia prima della guerra. La pensione diventa allora una sorta di forte assediato dall’incombere dell’oblio, difeso da “soldati della memoria”, sempre più sparuti e vecchi, che lì si ritrovano perché è rimasto quello forse l’unico luogo dove ancora si sentono a casa.
Eppure qualcosa li attirava qui. In questa squallida pensione con l’intonaco perennemente scrostato. Si sentivano a casa. Perlomeno dietro la recinzione. Non è una cosa tanto semplice, sentirsi a casa. Non tutti ci riescono. Così diceva il signor Chaim. Noi non ci sentiamo mai a casa, siamo sempre in viaggio, come in quel bassorilievo sul monumento agli eroi del ghetto, dove il rabbino con la Torà in mano è alla guida del popolo. (pp. 24-25)
È un universo che si accinge a scomparire per la seconda, per l’ennesima volta, nel susseguirsi delle generazioni posteriori allo iato assoluto della Shoah e sempre più lontane eredi di un mondo portato via in blocco e di cui permangono solo ricordi sempre più sfocati. In fondo, proprio il giovane protagonista che si reca nel luogo della propria infanzia potrebbe essere la staffetta che si fa carico della testimonianza e della tua traduzione, ma nel microcosmo isolato e chiuso su se stesso della pensione è avvertito, e lui stesso si percepisce, inizialmente quasi come un estraneo, quasi come un intruso. E non potrebbe essere altrimenti in quell’albergo ormai quasi dismesso, sempre meno frequentato se non da quei vecchi custodi del passato, la presenza dei quali – come dice l’anziano direttore al giovane visitatore – non nota più nessuno.
Ah, quelli!». Fece un gesto con la mano armata di forchetta. «Ma loro sono sempre qui, è come se non ci fossero. Un tempo gli affari andavano a gonfie vele! All’epoca c’erano ancora un po’ di ebrei. (p. 37)
Di questo edificio isolato, di questa sorta di Arca della memoria di un modo scomparso, i veri abitanti sono solo i ricordi e i loro protagonisti scomparsi che risultano però più vivi dei vecchi stanchi e insonni che li rievocano. Come dice ancora una volta il direttore:
Qui tutti hanno una storia […] da vendere. I grandi saldi dei ricordi, come al bazar di Gerusalemme. Ogni storia è come un tappeto persiano, solo che lo danno gratis, perché nessuno vuole comprarlo. (p. 107)
E come in un tappeto persiano zeppo di arabeschi o in un arazzo riccamente istoriato, nella narrazione di Piotr Paziński si dipana una tessitura il cui ordito è un intreccio volutamente inestricabile di tanti diversi fili, che provengono da piani differenti di realtà, ma che alla fine si incrociano e si annodano in un tutt’uno che assume i contorni surreali di una metarealtà onirica, in cui si tengono assieme come attori su di un unico palcoscenico descrizioni, conversazioni, riflessioni, ricordi, associazioni, immagini, ospiti della pensione di oggi, quelli di un tempo conosciuti dal protagonista-narratore, nonché quelli ancora più lontani nel tempo e risalenti al mondo per sempre perduto e scomparso, quello “prima della guerra”. Ricordi e ricordi di ricordi che si moltiplicano e si sovrappongono come gli strati di reperti in un sito archeologico.
Particolarmente efficace e suggestivo il finale – insieme culmine e senso complessivo del romanzo – nel quale il protagonista, dopo un solo giorno ed una sola notte trascorsi nella pensione, si reca alla stazione in compagnia del signor Jakub, per allontanarsi nuovamente – forse per sempre – da quei luoghi, ma prima, condotto dall’anziano ospite, che assurge al ruolo di guida verso il morto mondo del passato e dei ricordi e di simbolo di tutti i pensionanti del passato, prossimo e remoto – e in fondo di tutto il popolo ebraico, anche e soprattutto di tutti coloro che non sono sopravvissuti – raggiunge la cima di una collina, dopo un lungo cammino nel bosco, che funge da percorso straniante – perché lo introduce in una dimensione altra e superiore – e iniziatico – in quanto lo conduce al cospetto di ciò che, forse inconsapevolmente, era andato cercando, recandosi alla pensione della propria villeggiatura infantile: la memoria di un intero popolo, di cui ora sa di essere parte indissolubile, «l’ultimo anello di una catena di generazioni» (p. 171).
Quando raggiungemmo la cima della collina, scese di nuovo una fitta nebbia e il signor Jakub lanciò uno sguardo alla vicina boscaglia, fece un profondo sospiro e finalmente si fermò. Sussurrò qualcosa per un lungo istante, sottovoce, intrattenendo una convrsazione con se stesso, poi colpì la terra con il bastone, così forte che dal sottobosco si levò una nube di polvere. D’improvviso, tutto intorno a noi fu un brulicare di pensionanti, come un tempo nel nostro giardino. Erano più vecchi di allora, ma più familiari, con i loro paltò scuri, i cappotti a quadri e i colli di pellccia, i cappelli e i berretti, gli scarponcini e i mocassini, grazie ai quali li potevo riconoscere facilmente.
C’erano il dottor Lewin, che pubblicizzava le virtù del sanatorio, e il suo assistente, il dottor Centnerszwer, e zia Grunia e il cugino Abrasza, la sorella della signora Tecia e Mojżesz, quello che era andato in guerra in Spagna, via Świętojerska 11, ala interna, secondo piano con vista sul cortile, e suo fratello Izrael, di cui aveva scritto nel suo libro Izaak Feldwurm, divenuto in seguito l’avvocato Kirszemberg di Bat Yam, il professor Wolpe, un sosia del dottor Kahn con un rotolo di fogli, il signor Lifszyc con un berretto di tela bianca, la famiglia Rabinowicz, Pesja, la madre della signora Gienia e il mercante Lewi, padre della signora Regia, grandi magazzini di moda, indirizzo sul biglietto da visita, la nonna e il nonno, quelli della pensione e quelli di viale degli Amici, che non venivano mai nella nostra pensione, quelli di qui e quelli di altrove, che conoscevo unicamente dalle cartoline colorate con quei bei francobolli, quelli vivi e quelli morti da tempo. E quelli che erano andati via e tutti quelli, ed erano la maggioranza, che sarebbero potuti andare con loro, ma non l’avevano fatto. E quelli che erano fuggiti, ma non era servito a niente. E altri ancora, che erano usciti dall’Egitto per smarrirsi e che l’Altissimo aveva sterminato lungo la strada, tanto che non ne era rimasta alcuna traccia. (pp. 168-169)



